
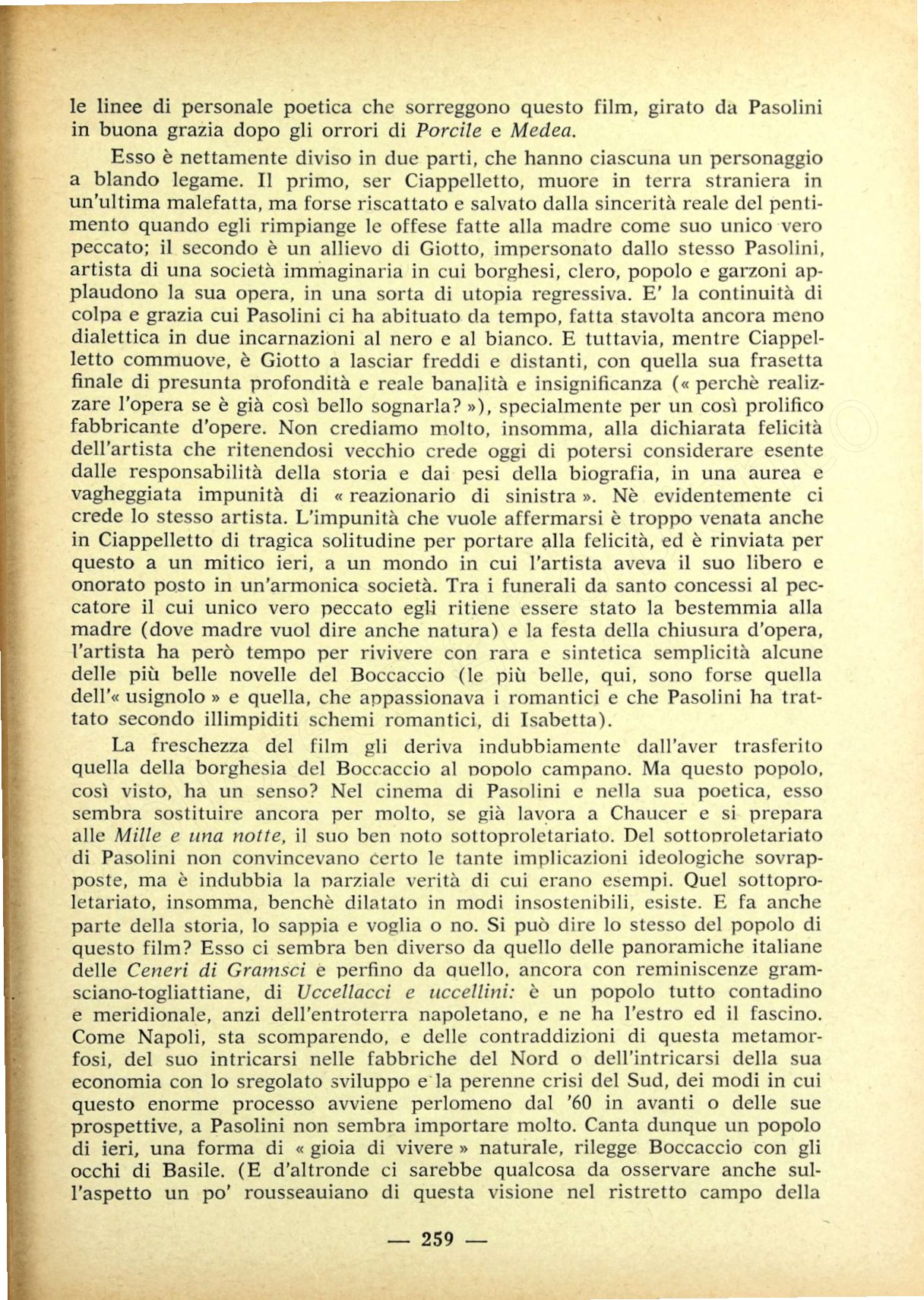
le linee di personale poetica che sorreggono questo film, girato da Pasolini
in buona grazia dopo gli orrori di
Porcile
e
Medea.
Esso è nettamente diviso in due parti, che hanno ciascuna un personaggio
a blando legame. I l primo, ser Ciappelletto, muore i n terra straniera i n
un'ultima malefatta, ma forse riscattato e salvato dalla sincerità reale del penti-
mento quando egli rimpiange le offese fatte alla madre come suo unico vero
peccato; i l secondo è un allievo di Giotto, impersonato dallo stesso Pasolini,
artista di una società imrnaginaria in cui borghesi, clero, popolo e garzoni ap-
plaudono la sua opera, in una sorta di utopia regressiva. E' la continuità di
colpa e grazia cui Pasolini ci ha abituato da tempo, fatta stavolta ancora meno
dialettica in due incarnazioni al nero e al bianco. E tuttavia, mentre Ciappel-
letto commuove, è Giotto a lasciar freddi e distanti, con quella sua frasetta
finale di presunta profondità e reale banalità e insignificanza (« perchè realiz-
zare l'opera se è già così bello sognarla? »), specialmente per un così prolifico
fabbricante d'opere. Non crediamo molto, insomma, alla dichiarata felicità
dell'artista che ritenendosi vecchio crede oggi di potersi considerare esente
dalle responsabilità della storia e dai pesi della biografia, in una aurea e
vagheggiata impunità d i « reazionario d i sinistra ». Nè evidentemente c i
crede lo stesso artista. L'impunità che vuole affermarsi è troppo venata anche
in Ciappelletto di tragica solitudine per portare alla felicità, ed è rinviata per
questo a un mitico ieri, a un mondo in cui l'artista aveva i l suo libero e
onorato posto in un'armonica società. Tra i funerali da santo concessi al pec-
catore i l cui unico vero peccato egli ritiene essere stato la bestemmia alla
madre (dove madre vuol dire anche natura) e la festa della chiusura d'opera,
l'artista ha però tempo per rivivere con rara e sintetica semplicità alcune
delle più belle novelle del Boccaccio ( le più belle, qui, sono forse quella
dell'« usignolo » e quella, che appassionava i romantici e che Pasolini ha trat-
tato secondo illimpiditi schemi romantici, di Isabetta).
La freschezza del f i lm g l i deriva indubbiamente dall'aver trasferito
quella della borghesia del Boccaccio al popolo campano. Ma questo popolo,
così visto, ha un senso? Nel cinema di Pasolini e nella sua poetica, esso
sembra sostituire ancora per molto, se già lavora a Chaucer e si prepara
alle
Mille
e
una notte, il
suo ben noto sottoproletariato. Del sottonroletariato
di Pasolini non convincevano certo le tante implicazioni ideologiche sovrap-
poste, ma è indubbia la parziale verità di cui erano esempi. Quel sottopro-
letariato, insomma, benchè dilatato in modi insostenibili, esiste. E fa anche
parte della storia, lo sappia e voglia o no. Si può dire lo stesso del popolo di
questo film? Esso ci sembra ben diverso da quello delle panoramiche italiane
delle
Ceneri di Gramsci
e perfino da Quello, ancora con reminiscenze gram-
sciano-togliattiane, d i
Uccellacci
e
uccellini:
è un popolo tutto contadino
emeridionale, anzi dell'entroterra napoletano, e ne ha l'estro ed i l fascino.
Come Napoli, sta scomparendo, e delle contraddizioni di questa metamor-
fosi, del suo intricarsi nelle fabbriche del Nord o dell'intricarsi della sua
economia con lo sregolato sviluppo e la perenne crisi del Sud, dei modi in cui
questo enorme processo avviene perlomeno dal '60 i n avanti o delle sue
prospettive, a Pasolini non sembra importare molto. Canta dunque un popolo
di ieri, una forma di «gioia di vivere » naturale, rilegge Boccaccio con gli
occhi di Basile. ( E d'altronde ci sarebbe qualcosa da osservare anche sul-
l'aspetto un po' rousseauiano di questa visione nel ristretto campo della
259
















