
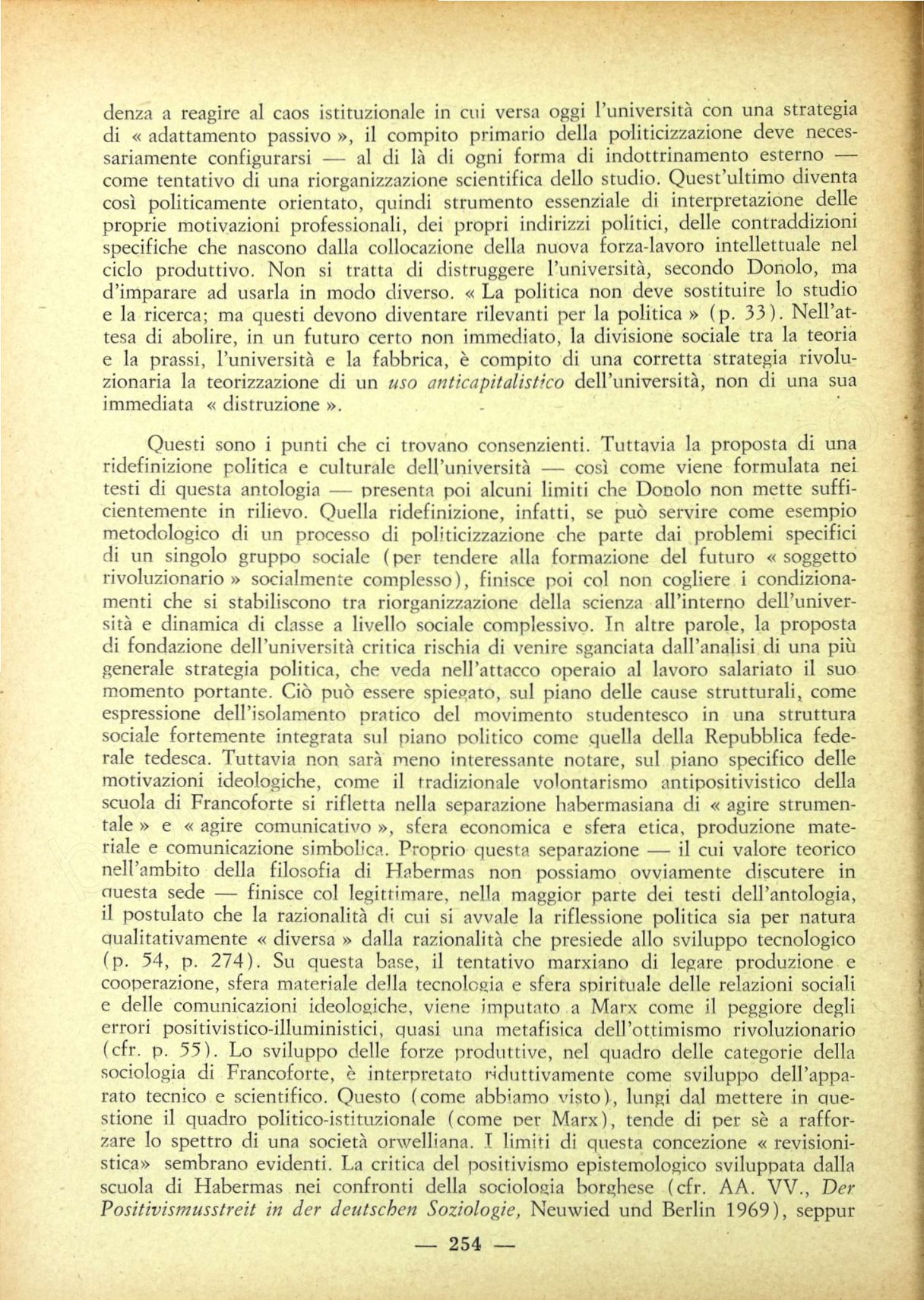
denza a reagire al caos istituzionale in cui versa oggi l'università Con una strategia
di « adattamento passivo », i l compito primario della politicizzazione deve neces-
sariamente configurarsi — al di là di ogni forma di indottrinamento esterno
come tentativo di una riorganizzazione scientifica dello studio. Quest'ultimo diventa
così politicamente orientato, quindi strumento essenziale di interpretazione delle
proprie motivazioni professionali, dei propri indirizzi politici, delle contraddizioni
specifiche che nascono dalla collocazione della nuova forza-lavoro intellettuale nel
ciclo produttivo. Non si tratta di distruggere l'università, secondo Donolo, ma
d'imparare ad usarla in modo diverso. « La politica non deve sostituire lo studio
e la ricerca; ma questi devono diventare rilevanti per la politica » (p. 33). Nell'at-
tesa di abolire, in un futuro certo non immediato, la divisione sociale tra la teoria
e la prassi, l'università e la fabbrica, è compito di una corretta strategia rivolu-
zionaria la teorizzazione di un
uso antica pitalistico
dell'università, non di una sua
immediata « distruzione ».
Questi sono i punti che ci trovano consenzienti. Tuttavia la proposta di una
ridefinizione politica e culturale dell'università — così come viene formulata nei
testi di questa antologia — presenta poi alcuni limiti che Donolo non mette suffi-
cientemente in rilievo. Quella ridefinizione, infatti, se può servire come esempio
metodologico di un processo di politicizzazione che parte dai %problemi specifici
di un singolo gruppo sociale (per tendere alla formazione del futuro « soggetto
rivoluzionario » socialmente complesso), finisce poi col non cogliere i condiziona-
menti che si stabiliscono tra riorganizzazione della scienza all'interno dell'univer-
sità e dinamica di classe a livello sociale complessivo. In altre parole, la proposta
di fondazione dell'università critica rischia di venire sganciata dall'analisi di una più
generale strategia politica, che veda nell'attacco operaio al lavoro salariato i l suo
momento portante. Ciò può esserespiegato, sul piano delle cause strutturali, come
espressione dell'isolamento pratico del movimento studentesco i n una struttura
sociale fortemente integrata sul piano politico come quella della Repubblica fede-
rale tedesca. Tuttavia non saràmeno interessante notare, sul piano specifico delle
motivazioni ideologiche, come i l tradizionale volontarismo antipositivistico della
scuola di Francoforte si rifletta nella separazionehabermasiana di « agire strumen-
tale » e « agire comunicativo », sfera economica e sfera etica, produzione mate-
riale e comunicazione simbolica. Proprio questa separazione — il cui valore teorico
nell'ambito• della filosofia d i Habermas non possiamo ovviamente discutere i n
questasede — finisce col legittimare, nella maggior parte dei testi dell'antologia,
il postulato che la razionalità di cui si avvale la riflessione politica sia per natura
qualitativamente « diversa » dalla razionalità che presiede allo sviluppo tecnologico
(p. 54, p. 274). Su questa base, i l tentativo marxiano di legare produzione e
cooperazione, sferamateriale della tecnologia e sfera spirituale delle relazioni sociali
edelle comunicazioni ideologiche, viene imputato .a Marx come i l peggiore degli
errori positivistico-illuministici, quasi una metafisica dell'ottimismo rivoluzionario
(cfr. p. 55). Lo sviluppo delle forze produttive, nel quadro delle categorie della
sociologia di Francoforte, è interpretato r-iduttivamente come sviluppo dell'appa-
rato tecnico e scientifico. Questo (come abbiamo visto )., lungi dal mettere in que-
stione i l quadro politico-istituzionale (come per Marx), tende di per sè a raffor-
zare lo spettro di una società orwelliana. I limiti di questa concezione « revisioni-
stica» sembrano evidenti. La critica del positivismo epistemologico sviluppata dalla
scuola di Habermas nei confronti della sociologia borghese (cfr. AA. VV.,
Der
Positivismusstreit in der deutschenSoziologie, Neuwied und Berlin 1969), seppur
254
















