
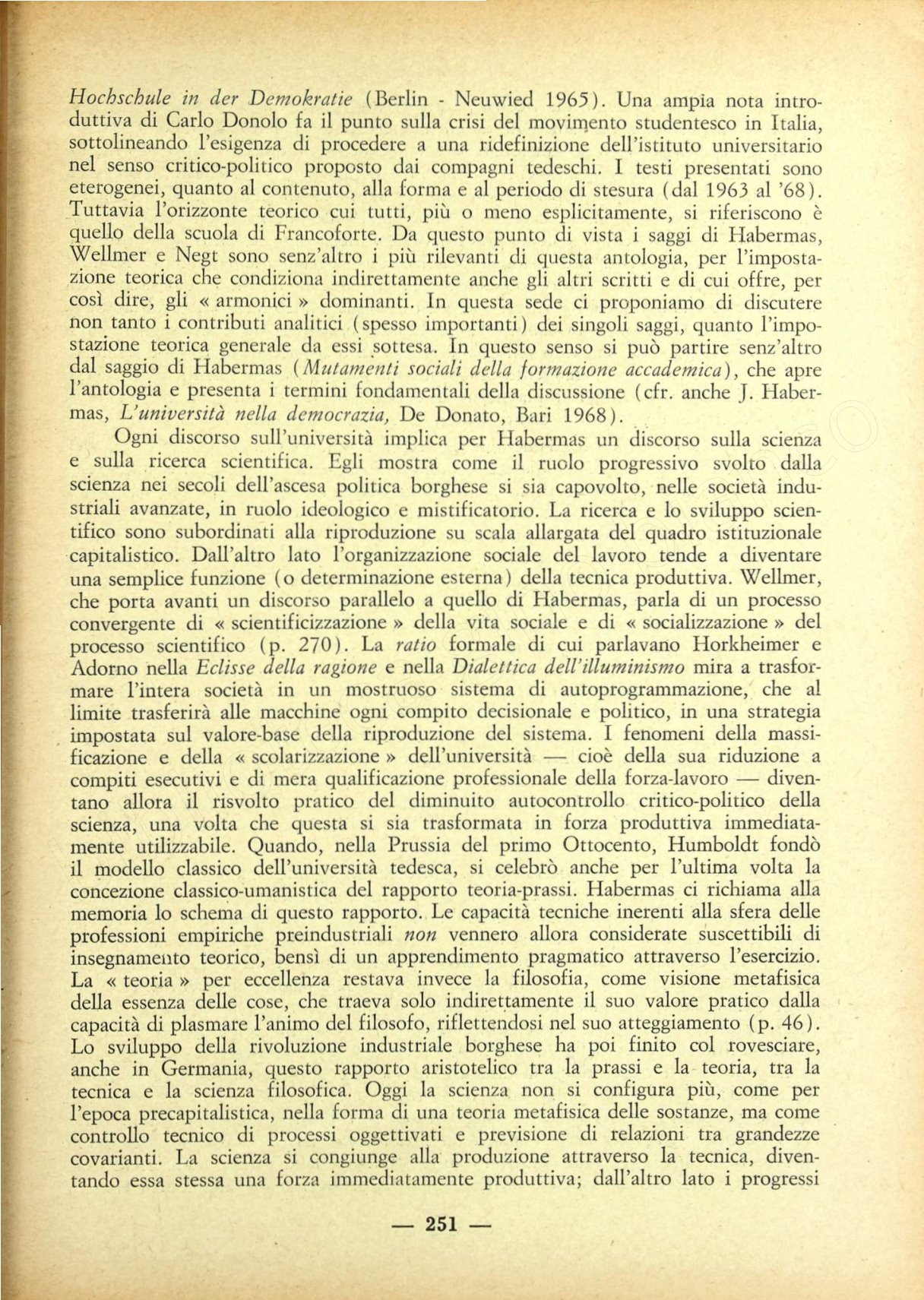
Hochschule in der Demokratie
(Berlin - Neuwied 1965). Una ampia nota intro-
duttiva di Carlo Donolo fa il punto sulla crisi del movimento studentesco in Italia,
sottolineando l'esigenza di procedere a una ridefinizione dell'istituto universitario
nel senso critico-politico proposto dai compagni tedeschi. I testi presentati sono
eterogenei, quanto al contenuto, alla forma e al periodo di stesura (dal 1963 al '68).
Tuttavia l'orizzonte teorico cui tutti, più o meno esplicitamente, si riferiscono è
quello della scuola di Francoforte. Da questo punto di vista i saggi di Habermas,
Wellmer e Negt sono senz'altro i più rilevanti di questa antologia, per l'imposta-
zione teorica che condiziona indirettamente anche gli altri scritti e di cui offre, per
così dire, gli « armonici » dominanti. In questa sede ci proponiamo di discutere
non tanto i contributi analitici ( spesso importanti) dei singoli saggi, quanto l'impo-
stazione teorica generale da essi sottesa. In questo senso si può partire senz'altro
dal saggio di Habermas (Mutamenti sociali della formazione accademica), che apre
l'antologia e presenta i termini fondamentali della discussione (cfr. anche J. Haber-
mas, L'università nella democrazia, De Donato, Bari 1968).
Ogni discorso sull'università implica per Habermas un discorso sulla scienza
esulla ricerca scientifica. Egli mostra come i l ruolo progressivo svolto dalla
scienza nei secoli dell'ascesa politica borghese si •sia capovolto, nelle società indu-
striali avanzate, in ruolo ideologico e mistificatorio. La ricerca e lo sviluppo scien-
tifico sono subordinati alla riproduzione su scala allargata del quadro istituzionale
•capitalistico. Dall'altro lato l'organizzazione sociale del lavoro tende a diventare
unasemplice funzione (o determinazione esterna) della tecnica produttiva. Wellmer,
che porta avanti un discorso parallelo a quello di Habermas, parla di un processo
convergente di « scientificizzazione» della vita sociale e di « socializzazione » del
processo scientifico (p. 270). La
ratio
formale di cui parlavano Horkheimer e
Adorno nella Eclisse della ragione e nella Dialettica dell'illuminismo mira a trasfor-
mare l'intera società i n un mostruoso sistema d i autoprogrammazione, che al
limite trasferirà alle macchine ogni compito decisionale e politico, in una strategia
impostata sul valore-base della riproduzione del sistema. I fenomeni della massi-
ficazione e della « scolarizzazione» dell'università — cioè della sua riduzione a
compiti esecutivi e di mera qualificazione professionale della forza-lavoro — diven-
tano allora i l risvolto pratico del diminuito autocontrollo critico-politico della
scienza, una volta che questa si sia trasformata in forza produttiva immediata-
mente utilizzabile. Quando, nella Prussia del primo Ottocento, Humboldt fondò
il modello classico dell'università tedesca, si celebrò anche per l'ultima volta la
concezioneclassico-umanistica del rapporto teoria-prassi. Habermas ci richiama alla
memoria lo schema di questo rapporto. Le capacità tecniche inerenti alla sfera delle
professioni empiriche preindustriali
non
vennero allora considerate Suscettibili di
insegnamento teorico, bensì di un apprendimento pragmatico attraverso l'esercizio.
La « teoria » per eccellenza restava invece la filosofia, come visione metafisica
dellaessenza delle cose, che traeva solo indirettamente i l suo valore pratico dalla
capacità di plasmare l'animo del filosofo, riflettendosi nel suoatteggiamento (p. 46).
Lo sviluppo della rivoluzione industriale borghese ha poi finito col rovesciare,
anche in Germania, questo rapporto aristotelico tra la prassi e la teoria, tra la
tecnica e la scienza filosofica. Oggi la scienza non si configura più, come per
l'epoca precapitalistica, nella forma di una teoria metafisica delle sostanze,macome
controllo tecnico di processi oggettivati e previsione di relazioni tra grandezze
covarianti. La scienza si congiunge alla produzione attraverso la tecnica, diven-
tandoessastessa una forza immediatamente produttiva; dall'altro lato i progressi
251
















