
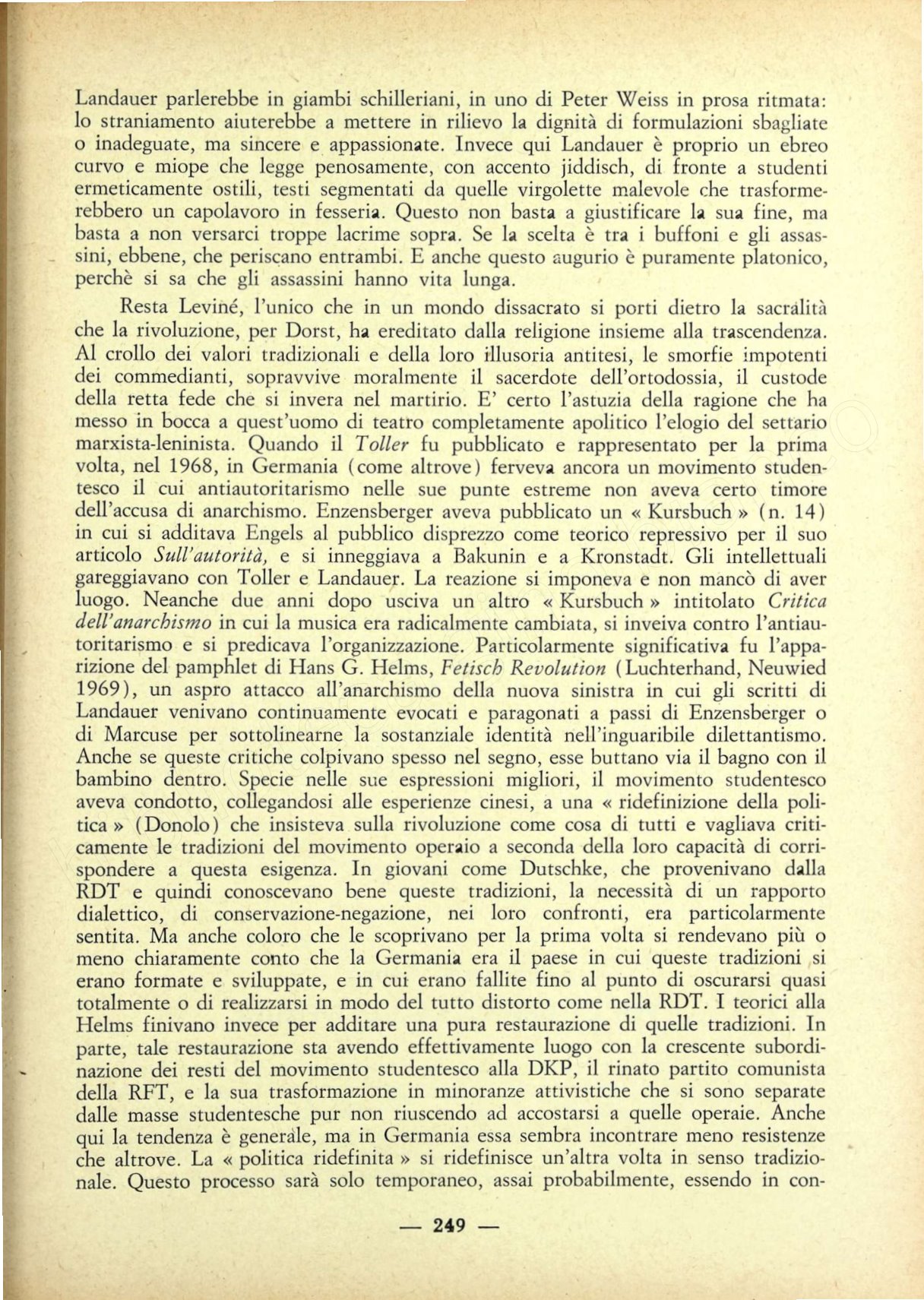
•Landauer parlerebbe in giambi schilleriani, in uno di Peter Weiss in prosa ritmata:
lo straniamento aiuterebbe a mettere in rilievo la dignità di formulazioni sbagliate
o inadeguate, ma sincere e appassionate. Invece qui Landauer è proprio un ebreo
curvo e miope che legge penosamente, con accento jiddisch, di fronte a studenti
ermeticamente ostili, testi segmentati da quelle virgolette malevole che trasforme-
rebbero un capolavoro in fesseria. Questo non basta a giustificare la sua fine, ma
basta a non versarci troppe lacrime sopra. Se la scelta è tra i buffoni e gli assas-
_sini , ebbene, cheperiscano entrambi. E anchequesto augurio è puramente platonico,
perchè si sa che gli assassini hanno vita lunga.
Resta Leviné, l'unico che in un mondo dissacrato si porti dietro la sacralità
che la rivoluzione, per Dorst, ha ereditato dalla religione insieme alla trascendenza.
Al crollo dei valori tradizionali e della loro illusoria antitesi, le smorfie impotenti
dei commedianti, sopravvive moralmente i l sacerdote dell'ortodossia, i l custode
della retta fede che si invera nel martirio. E' certo l'astuzia della ragione che ha
messo in bocca a quest'uomo di teatro completamente apolitico l'elogio del settario
marxista-leninista. Quando i l
Toner
fu pubblicato e rappresentato per la prima
volta, nel 1968, in Germania (come altrove) ferveva ancora un movimento studen-
tesco i l cui antiautoritarismo nelle sue punte estreme non aveva certo timore
dell'accusa di anarchismo. Enzensberger aveva pubblicato un « Kursbuch » (n. 14)
in cui si additava Engels al pubblico disprezzo come teorico repressivo per i l suo
articolo
Sull'autorità,
e si inneggiava a Bakunin e a Kronstadt. Gl i intellettuali
gareggiavano con Toller e Landauer. La reazione si imponeva e nonmancò di aver
luogo. Neanche due anni dopo usciva un altro « Kursbuch » intitolato
Critica
dell'anarchismo
in cui lamusicaera radicalmente cambiata, si inveiva contro l'antiau-
toritarismo e si predicava l'organizzazione. Particolarmente significativa fu l'appa-
rizione del pamphlet di Hans G. Helms,
Fetisch Revolution
( Luchterhand, Neuwied
1969), un aspro attacco all'anarchismo della nuova sinistra in cui gli scritti di
Landauer venivano continuamente evocati e paragonati a passi di Enzensberger o
di Marcuse per sottolinearne la sostanziale identità nell'inguaribile dilettantismo.
Anchesequeste critiche colpivanospesso nel segno,essebuttano via il bagno con il
bambino dentro. Specie nelle sue espressioni migliori, i l movimento studentesco
avevacondotto, collegandosi alle esperienze cinesi, a una « ridefinizione della poli-
tica » (Donolo) che insisteva sulla rivoluzione come cosa di tutti e vagliava criti-
camente le tradizioni del movimento operaio a seconda della loro capacità di corri-
spondere a questa esigenza. I n giovani come Dutschke, che provenivano dalla
RDT e quindi conoscevano bene queste tradizioni, la necessità di un rapporto
dialettico, d i conservazione-negazione, nei loro confronti, era particolarmente
sentita. Ma anche coloro che le scoprivano per la prima volta si rendevano più o
menochiaramente conto che la Germania era i l paese in cui queste tradizioni si
erano formate e sviluppate, e in cui erano fallite fino al punto di oscurarsi quasi
totalmente o di realizzarsi in modo del tutto distorto come nella RDT. I teorici alla
Helms finivano invece per additare una pura restaurazione di quelle tradizioni. In
parte, tale restaurazione sta avendo effettivamente luogo con la crescente subordi-
nazione dei resti del movimento studentesco alla DKP, i l rinato partito comunista
della RFT, e la sua trasformazione in minoranze attivistiche che si sono separate
dallemassestudentesche pur non riuscendo ad accostarsi a quelle operaie. Anche
qui la tendenza è generdle, ma in Germaniaessasembra incontraremeno resistenze
chealtrove. La « politica ridefinita » si ridefinisce un'altra volta in senso tradizio-
nale. Questo processo sarà solo temporaneo, assai probabilmente, essendo in con-
249 -
















