
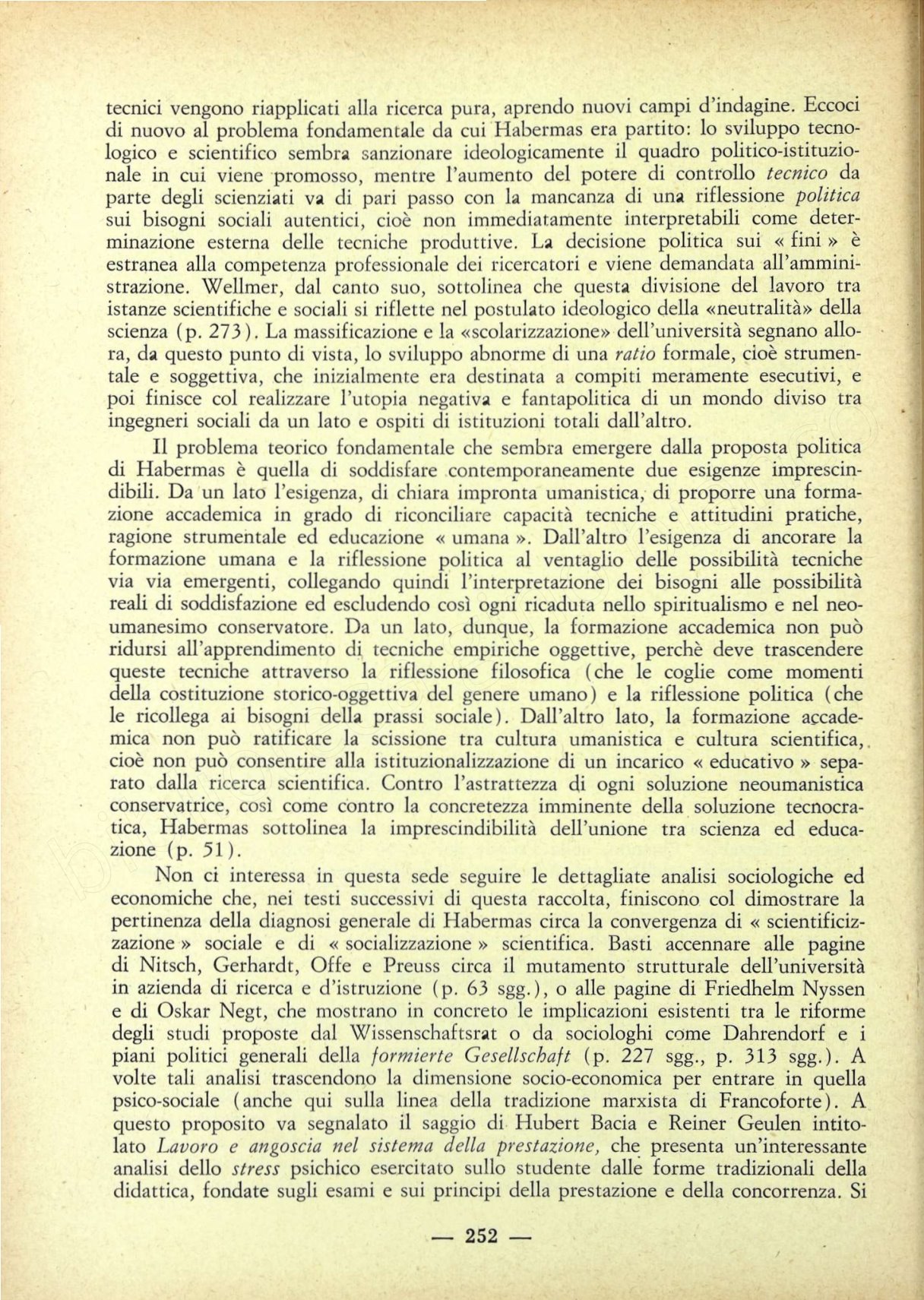
tecnici vengono riapplicati alla ricerca pura, aprendo nuovi campi d'indagine. Eccoci
di nuovo al problema fondamentale da cui 'Habermas era partito: lo sviluppo tecno-
logico e scientifico sembra sanzionare ideologicamente i l quadro politico-istituzio-
nale in cui viene -promosso, mentre l'aumento del potere di controllo
tecnico
da
parte degli scienziati va di pari passo con la mancanza di una riflessione
politica
sui bisogni sociali autentici, cioè non immediatamente interpretabili come deter-
minazione esterna delle tecniche produttive. La decisione politica sui « fini » è
estranea alla competenzaprofessionale dei ricercatori e viene demandata all'ammini-
strazione. Wellmer, dal canto suo, sottolinea che questa divisione del lavoro tra
istanze scientificheesociali si riflette nel postulato ideologico della «neutralità» della
scienza (p. 273). Lamassificazionee la «scolarizzazione»•dell'universitàsegnanoallo-
ra, da questo punto di vista, lo sviluppo abnorme di una
ratio
formale, cioè strumen-
tale e soggettiva, che inizialmente era destinata a compiti meramente esecutivi, e
poi finisce col realizzare l'utopia negativa e fantapolitica di un mondo diviso tra
ingegneri sociali da un lato e ospiti di istituzioni totali dall'altro.
I l problema teorico fondamentale che sembraemergere dalla proposta politica
di Habermas è quella di soddisfare .contemporaneamente due esigenze imprescin-
dibili. Da un lato l'esigenza, di chiara impronta umanistica; di proporre una forma-
zioneaccademica in grado di riconciliare capacità tecniche e attitudini pratiche,
ragione strumentale ed educazione « umana ». Dall'altro l'esigenza di ancorare la
formazione umana e la riflessione politica al ventaglio delle possibilità tecniche
via via emergenti, collegando quindi l'interpretazione dei bisogni alle possibilità
reali di soddisfazione ed escludendo così ogni ricaduta nello spiritualismo e nel neo-
umanesimoconservatore. Da un lato, dunque, la formazione accademica non può
ridursi all'apprendimento di, tecniche empiriche oggettive, perchè deve trascendere
queste tecniche attraverso la riflessione filosofica (che le coglie come momenti
della costituzione storico-oggettiva del genere umano) e la riflessione politica (che
le ricollega ai bisogni della prassi sociale). Dall'altro lato, la formazione accade-
mica non può ratificare la scissione tra cultura umanistica e cultura scientifica,.
cioè non può consentire alla istituzionalizzazione di un incarico « educativo » sepa-
rato dalla ricerca scientifica. Contro l'astrattezza di ogni soluzione neoumanistica
conservatrice, così come contro la concretezza imminente della.soluzione tecnocra-
tica, Habermas sottolinea la imprescindibilità dell'unione tra scienza ed educa-
zione (p. .51).
Non ci interessa in questa sede seguire le dettagliate analisi sociologiche ed
economiche che, nei testi successivi di questa raccolta, finiscono col dimostrare la
pertinenza della diagnosi generale di Habermas circa la convergenza di « scientificiz-
zazione» sociale e di « socializzazione » scientifica. Basti accennare alle pagine
di Nitsch, Gerhardt, Offe e Preuss circa i l mutamento strutturale dell'università
in azienda di ricerca e d'istruzione (p. 63 sgg.), o alle pagine di FriedhelmNyssen
e di Oskar Negt, che mostrano in concreto le implicazioni esistenti tra le riforme
degli studi proposte dal Wissenschaftsrat o da sociologhi come Dahrendorf e i
piani politici generali della
formierte Gesellschaft
(p. 227 sgg., p. 313 sgg.). A
volte tali analisi trascendono la dimensione socio-economica per entrare in quella
psico-sociale ( anche qui sulla linea della tradizione marxista di Francoforte). A
questo proposito va segnalato i l saggio di. Hubert Bacia e Reiner Geulen intito-
lato Lavoro e angoscia nel sistema della prestazione, che presenta un'interessante
analisi dello
stress
psichico esercitato sullo studente dalle forme tradizionali della
didattica, fondate sugli esami e sui principi della prestazione e della concorrenza. Si
- 252
















