
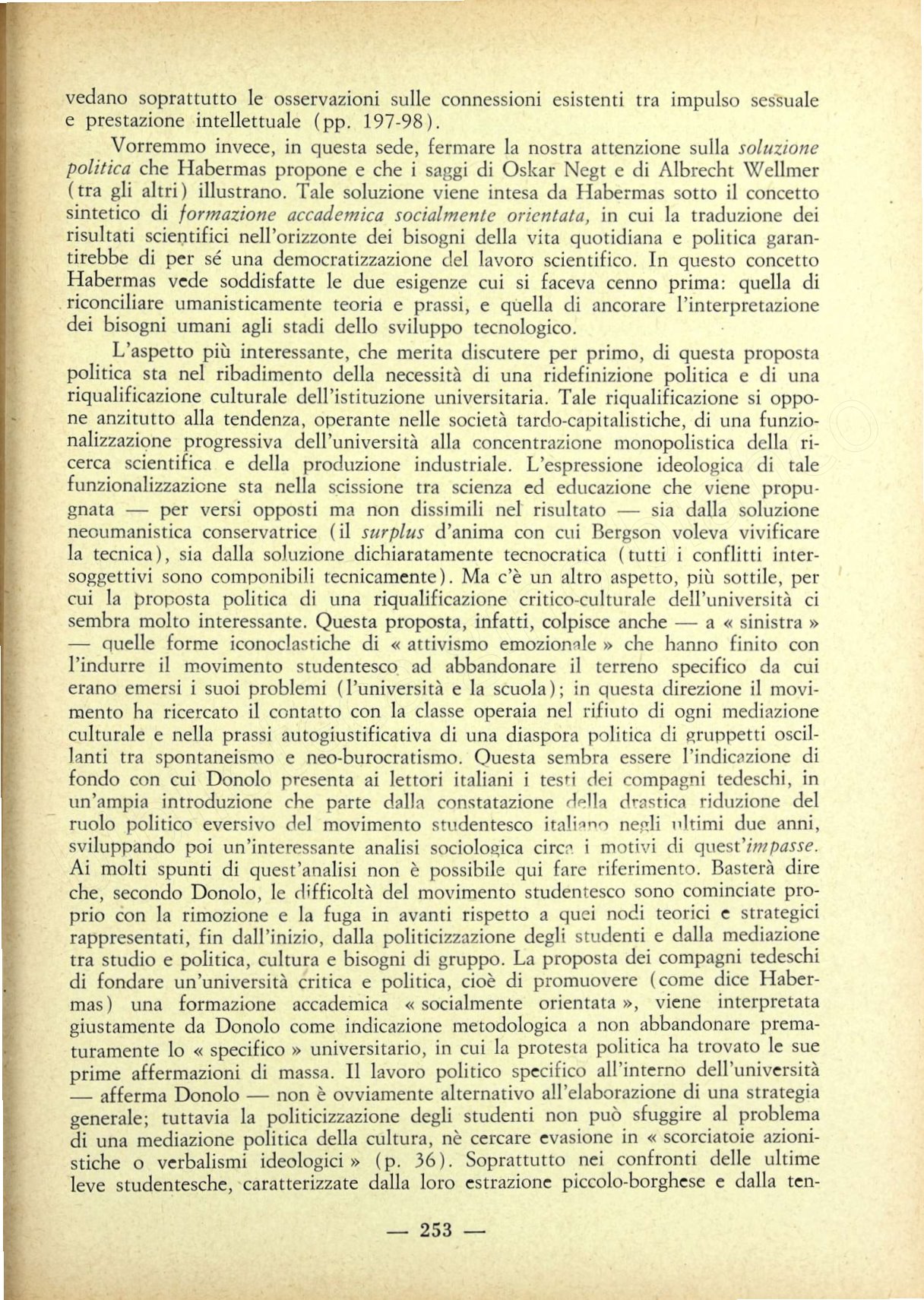
vedano soprattutto le osservazioni sulle connessioni esistenti tra impulso sessuale
eprestazione intellettuale (pp. 197-98 ).
Vorremmo invece, in questa sede, fermare la nostra attenzione sulla
soluzione
politica
cheHabermas propone e che i saggi di Oskar Negt e di Albrecht Wellmer
( tra gli altri) illustrano. Tale soluzione viene intesa da Habermas sotto il concetto
sintetico di formazione accademica socialmente orientata, in cui la traduzione dei
risultati scientifici nell'orizzonte dei bisogni della vita quotidiana e politica garan-
tirebbe di per sé una democratizzazione del lavoro scientifico. In questo concetto
Habermas vede soddisfatte le due esigenze cui si faceva cenno prima: quella di
riconciliare umanisticamente teoria e prassi, e quella di ancorare l'interpretazione
dei bisogni umani agli stadi dello sviluppo tecnologico.
•
L'aspetto più interessante, che merita discutere per primo, di questa proposta
politica sta nel ribadimento della necessità di una ridefinizione politica e di una
riqualificazione culturale dell'istituzione universitaria. Tale riqualificazione si oppo-
neanzitutto alla tendenza, operante nelle società tardo-capitalistiche, di una funzio-
nalizzazione progressiva dell'università alla concentrazione monopolistica della ri-
cerca scientifica e della produzione industriale. L'espressione ideologica di tale
funzionalizzazione sta nella scissione tra scienza ed educazione che viene propu-
gnata — per versi opposti ma non dissimili nel- risultato — sia dalla soluzione
neoumanistica conservatrice ( il
surplus
d'anima con cui Bergson voleva vivificare
la tecnica), sia dalla soluzione dichiaratamente tecnocratica ( tutti i conflitti inter-
soggettivi sono componibili tecnicamente). Ma c'è un altro aspetto, più sottile, per
cui la proposta politica di una riqualificazione critico-culturale dell'università ci
sembramolto interessante. Questa proposta, infatti, colpisceanche — a « sinistra »
— quelle forme iconoclastiche di « attivismo emozionale » che hanno finito con
l'indurre i l movimento studentesco ad abbandonare i l terreno specifico da cui
eranoemersi i suoi problemi (l'università e la scuola); in questa direzione il movi-
mento ha ricercato i l contatto con la classe operaia nel rifiuto di ogni mediazione
culturale e nella prassi autogiustificativa di una diaspora politica di gruppetti oscil-
lanti tra spontaneismo e neo-burocratismo. Questa sembra essere l'indicazione di
fondo con cui Donolo presenta ai lettori italiani i testi dei compagni tedeschi, in
un'ampia introduzione che parte dalla constatazione della drastica riduzione del
ruolo politico eversivo del movimento studentesco italiano negli ultimi due anni,
sviluppando poi un'interessante analisi sociologica circa i motivi di quest'impasse.
Ai molti spunti di quest'analisi non è possibile qui fare riferimento. Basterà dire
che,secondo Donolo, le difficoltà del movimento studentesco sono cominciate pro-
prio Con la rimozione e la fuga in avanti rispetto a quei nodi teorici e strategici
rappresentati, fin dall'inizio, dalla politicizzazione degli studenti e dalla mediazione
tra studio e politica, cultura e bisogni di gruppo. La proposta dei compagni tedeschi
di fondare un'università éritica e politica, cioè di promuovere ( comedice Haber-
mas) una formazione accademica « socialmente orientata », viene interpretata
giustamente da Donolo come indicazionemetodologica a non abbandonare prema-
turamente lo « specifico» universitario, in cui la protesta politica ha trovato le sue
prime affermazioni di massa. I l lavoro politico specifico all'interno dell'università
afferma Donolo — non è ovviamente alternativo all'elaborazione di una strategia
generale; tuttavia la politicizzazione degli studenti non può sfuggire al problema
di unamediazione politica della cultura, nè cercareevasione in « scorciatoie azioni-
stiche o verbalismi ideologici » (p. 36 ). Soprattutto nei confronti delle ultime
levestudentesche, caratterizzate dalla loro estrazione piccolo-borghese e dalla ten-
253 -
















