
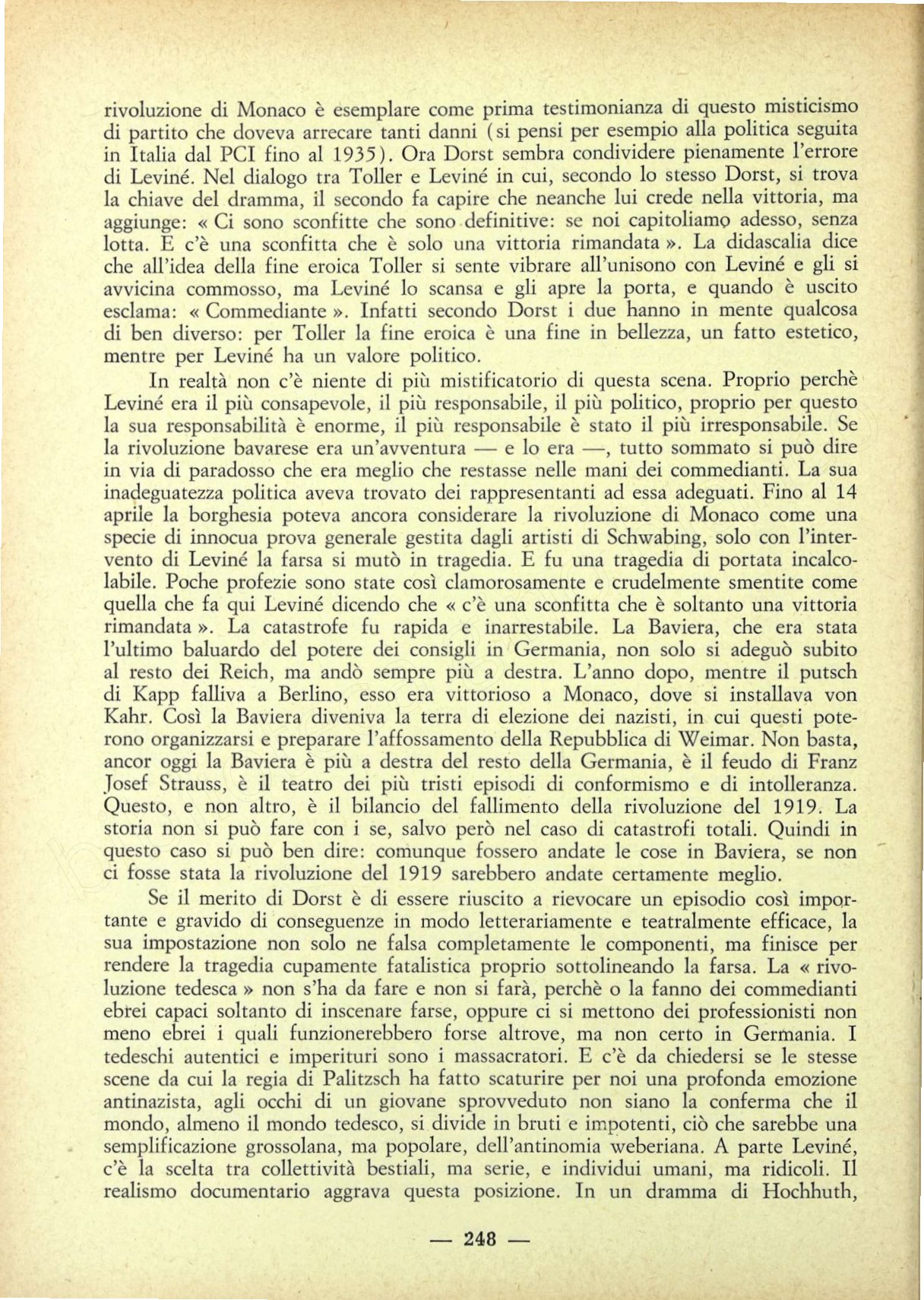
rivoluzione di Monaco è esemplarecome prima testimonianza di questomisticismo
di partito chedovevaarrecare tanti danni ( si pensi per esempio alla politica seguita
in Italia dal PCI fino al 1935). Ora Dorst sembracondividerepienamente l'errore
di Leviné. Nel dialogo tra Toller e Leviné in cui, secondo lo stessoDorst, si trova
la chiave del dramma, il secondo fa capire cheneanche lui crede nella vittoria, ma
aggiunge: « Ci sono sconfitte chesono -definitive: se noi capitoliamoadesso,senza
lotta. E c'è una sconfitta che è solo una vittoria rimandata ». La didascalia dice
cheall'idea della fine eroica Toller si sente vibrare all'unisono con Leviné e gli si
avvicinacommosso, ma Leviné lo scansa e gli apre la porta, e quando è uscito
esclama: « Commediante». Infatti secondo Dorst i due hanno in mente qualcosa
di ben diverso: per Toller la fine eroica è una fine in bellezza, un fatto estetico,
mentre per Leviné ha un valore politico.
In realtà non c'è niente di più mistificatorio di questascena. Proprio perchè
Levinéera il più consapevole, il più responsabile, il più politico, proprio per questo
lasua responsabilità è enorme, i l più responsabile è stato i l più irresponsabile. Se
la rivoluzionebavareseera un'avventura — e lo era —, tutto sommato si può dire
in via di paradossocheerameglio cherestassenellemani dei commedianti. La sua
inadeguatezzapolitica aveva trovato dei rappresentanti adessaadeguati. Fino al 14
aprile la borghesia poteva ancoraconsiderare la rivoluzione di Monaco come una
specie di innocua provageneralegestita dagli artisti di Schwabing, solo con l'inter-
vento di Leviné la farsa si mutò in tragedia. E fu una tragedia di portata incalco-
labile. Pocheprofezie sono state così clamorosamente e crudelmente smentitecome
quellache fa qui Leviné dicendoche « c'è una sconfitta che è soltanto una vittoria
rimandata». La catastrofe fu rapida e inarrestabile. La Baviera, che era stata
l'ultimo baluardo del potere dei consigli in Germania, non solo si adeguò subito
al resto dei Reich, ma andò sempre più a destra. L'anno dopo, mentre i l putsch
di Kapp falliva a Berlino, esso era vittorioso a Monaco, dove si installava von
Kahr. Così la Baviera diveniva la terra di elezione dei nazisti, in cui questi pote-
ronoorganizzarsi epreparare l'affossamento dellaRepubblica di Weimar. Non basta,
ancor oggi la Baviera è più a destra del resto della Germania, è il feudo di Franz
JosefStrauss, è i l teatro dei più tristi episodi di conformismo e di intolleranza.
Questo, e non altro, è i l bilancio del fallimento della rivoluzione del 1919. La
storia non si può fare con i se, salvo però nel caso di catastrofi totali. Quindi in
questocaso si può ben dire: comunque fossero andate le cose in Baviera, se non
ci fosse stata la rivoluzione del 1919 sarebberoandatecertamentemeglio.
Se i l merito di Dorst è di essere riuscito a rievocare un episodio cosi impqr-
tante e gravido di conseguenze in modo letterariamente e teatralmente efficace, la
suaimpostazione non solo ne falsa completamente le componenti, ma finisce per
rendere la tragediacupamente fatalistica proprio sottolineando la farsa. La « rivo-
luzionetedesca» non s'ha da fare e non si farà, perchè o la fanno dei commedianti
ebrei capaci soltanto di inscenare farse, oppure ci si mettono dei professionisti non
menoebrei i quali funzionerebbero forse altrove, ma non certo in Germania. I
tedeschi autentici e imperituri sono i massacratori. E c'è da chiedersi se le stesse
sceneda cui la regia di Palitzsch ha fatto scaturire per noi una profondaemozione
antinazista, agli occhi di un giovane sprovveduto non siano la conferma che i l
mondo,almeno il mondotedesco, si divide in bruti e impotenti, ciò chesarebbeuna
semplificazionegrossolana,ma popolare, dell'antinomiaweberiana. A parte Leviné,
c'è la scelta tra collettività bestiali, ma serie, e individui umani, ma ridicoli. I l
realismodocumentario aggrava questa posizione. I n un dramma di Hochhuth,
248
















