
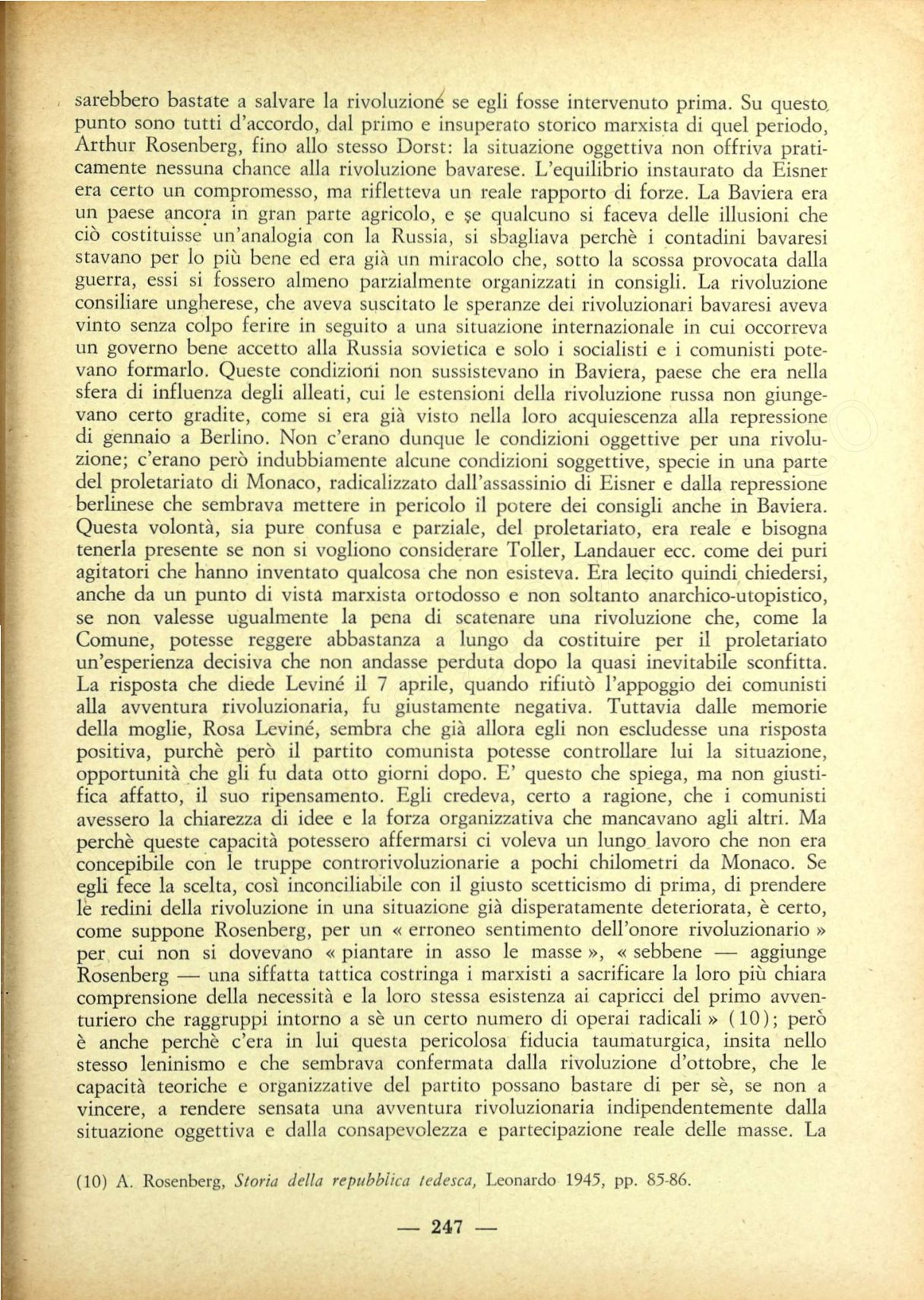
,sarebbero bastate a salvare la rivoluzioné se egli fosse intervenuto prima. Su questo,
punto sono tutti d'accordo, dal primo e insuperato storico marxista di quel periodo,
Arthur Rosenberg, fino allo stesso Dorst: la situazione oggettiva non offriva prati-
camentenessunachance alla rivoluzione bavarese. L'equilibrio instaurato da Eisner
era certo un compromesso, ma rifletteva un reale rapporto di forze. La Baviera era
unpaeseancora in gran parte agricolo, e se qualcuno si faceva delle illusioni che
ciò costituisse un'analogia con la Russia, si sbagliava perchè i contadini bavaresi
stavano per lo più bene ed era già un miracolo che, sotto la scossaprovocata dalla
guerra, essi si fossero almeno parzialmente organizzati in consigli. La rivoluzione
consiliareungherese, cheaveva suscitato le speranze dei rivoluzionari bavaresi aveva
vinto senza colpo ferire in seguito a una situazione internazionale in cui occorreva
un governo bene accetto alla Russia sovietica e solo i socialisti e i comunisti pote-
vano formarlo. Queste condizioni non sussistevano in Baviera, paese che era nella
sfera di influenza degli alleati, cui le estensioni della rivoluzione russa non giunge-
vano certo gradite, come si era già visto nella loro acquiescenza alla repressione
di gennaio a Berlino. Non c'erano dunque le condizioni oggettive per una rivolu-
zione; c'erano però indubbiamente alcune condizioni soggettive, specie in una parte
del proletariato di Monaco, radicalizzato dall'assassinio di Eisner e dalla repressione
berlinese che sembravamettere in pericolo i l potere dei consigli anche in Baviera.
Questa volontà, sia pure confusa e parziale, del proletariato, era reale e bisogna
tenerla presente se non si vogliono considerare Toller, Landauer ecc. come dei puri
agitatori che hanno inventato qualcosa•chenon esisteva. Era lecito quindi, chiedersi,
ancheda un punto di vista marxista ortodosso e non soltanto anarchico-utopistico,
se non valesse ugualmente la pena di scatenare una rivoluzione che, come la
Comune, potesse reggere abbastanza a lungo da costituire per i l proletariato
un'esperienza decisiva che non andasse perduta dopo la quasi inevitabile sconfitta.
La risposta che diede Leviné i l 7 aprile, quando rifiutò l'appoggio dei comunisti
alla avventura rivoluzionaria, f u giustamente negativa. Tuttavia dalle memorie
della moglie, Rosa Leviné, sembra che già allora egli non escludesse una risposta
positiva, purchè però i l partito comunista potesse controllare lui la situazione,
opportunità .che gli fu data otto giorni dopo. E' questo che spiega, ma non giusti-
fica affatto, i l suo ripensamento. Egli credeva, certo a ragione, che i comunisti
avessero la chiarezza di idee e la forza organizzativa chemancavano agli altri. Ma
perchèqueste capacità potessero affermarsi ci voleva un lungo_ lavoro che non era
concepibile con le truppe controrivoluzionarie a pochi chilometri da Monaco. Se
egli fece la scelta, così inconciliabile con i l giusto scetticismo di prima, di prendere
lé redini della rivoluzione in una situazione già disperatamente deteriorata, è certo,
comesupponeRosenberg, per un « erroneo sentimento dell'onore rivoluzionario »
per, cui non si dovevano « piantare in asso le masse », « sebbene — aggiunge
Rosenberg — una siffatta tattica costringa i marxisti a sacrificare la loro più chiara
comprensione della necessità e la loro stessaesistenza ai capricci del primo avven-
turiero che raggruppi intorno a sè un certo numero di operai radicali » ( 10 ); però
èanche perchè c'era in lui questa pericolosa fiducia taumaturgica, insita nello
stesso leninismo e che sembrava confermata dalla rivoluzione d'ottobre, che le
capacità teoriche e organizzative del partito possano bastare di per se, se non a
vincere, a rendere sensata una avventura rivoluzionaria indipendentemente dalla
situazione oggettiva e dalla consapevolezza e partecipazione reale dellemasse. La
(10) A. Rosenberg,
Storia della repubblica tedesca,
Leonardo 1945, pp. 85-86.
— 247 "
















