
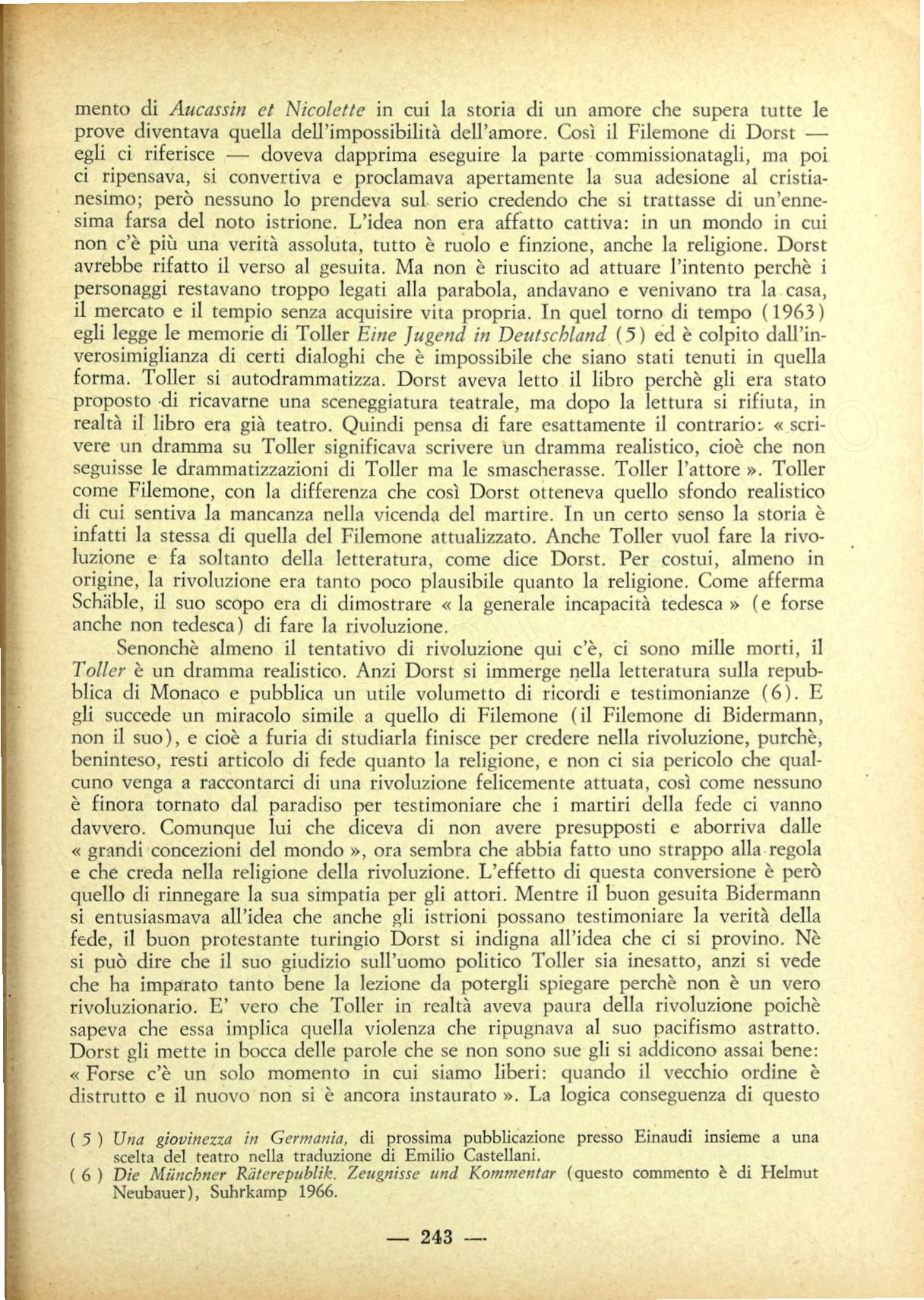
mento di
Aucassin et Nicolette
in cui la storia di un amore che supera tutte le
prove diventava quella dell'impossibilità dell'amore. Così i l Filemone di Dorst
egli ci riferisce — doveva dapprima eseguire la parte commissionatagli, ma poi
ci ripensava, si conveniva e proclamava apertamente la sua adesione al cristia-
nesimo; però nessuno lo prendeva sul. serio credendo che si trattasse di un'enne-
sima farsa del noto istrione. L'idea non era affatto cattiva: in un mondo in cui
non c'è più una verità assoluta, tutto è ruolo e finzione, anche la religione. Dorst
avrebbe rifatto i l verso al gesuita. Ma non è riuscito ad attuare l'intento perchè i
personaggi restavano troppo legati alla parabola, andavano e venivano tra la casa,
il mercato e il tempiosenzaacquisire vita propria. In quel torno di tempo (1963)
egli legge lememorie di Toller
EineJugend in Deutschland
(5) ed è colpito dall'in-
verosimiglianza di certi dialoghi che è impossibile che siano stati tenuti in quella
forma. Toller si autodrammatizza. Dorst aveva letto i l libro perchè gli era stato
proposto <li ricavarne una sceneggiatura teatrale, ma dopo la lettura si rifiuta, in
realtà i l libro era già teatro. Quindi pensa di fare esattamente i l contrario:. « scri-
vere un dramma su Toller significava scrivere un dramma realistico, cioè che non
seguisse le drammatizzazioni di Toller ma le smascherasse. Toller l'attore ». Toller
comeFilemone, con la differenza che così Dorst oiteneva quello sfondo realistico
di cui sentiva lamancanzanella vicenda del martire. In un certo senso la storia è
infatti la stessa di quella del Filemone attualizzato.Anche Toller vuol fare la rivo-
luzione e fa soltanto della letteratura, come dice Dorst. Per costui, almeno in
origine, la rivoluzione era tanto poco plausibile quanto la religione. Come afferma
Schàble, i l suo scopo era di dimostrare « la generale incapacità tedesca» (e forse
anchenon tedesca) di fare la rivoluzione.
Senonchèalmeno i l tentativo di rivoluzione qui c'è, ci sono mille morti, i l
Toller
è un dramma realistico. Anzi Dorst si immerge nella letteratura sulla repub-
blica di Monaco e pubblica un utile volumetto di ricordi e testimonianze (6). E
gli succede un miracolo simile a quello di Filemone ( i l Filemone di Bidermann,
non il suo), e cioè a furia di studiarla finisce per credere nella rivoluzione, purchè,
beninteso, resti articolo di fede quanto la religione, e non ci sia pericolo che qual-
cunovenga a raccontarci di una rivoluzione felicemente attuata, così comenessuno
èfinora tornato dal paradiso per testimoniare che i martiri della fede ci vanno
davvero. Comunque lui che diceva di non avere presupposti e aborriva dalle
«grandi iconcezioni del mondo », orasembracheabbia fatto uno strappo alla-regola
echecreda nella religione della rivoluzione. L'effetto di questaconversione è però
quello di rinnegare la suasimpatia per gli attori. Mentre il buongesuitaBidermann
si entusiasmava all'idea cheanche gli istrioni possano testimoniare la verità della
fede, i l buon protestante turingio Dorst si indigna all'idea che ci si provino. Ne
si può dire che i l suo giudizio sull'uomo politico Toller sia inesatto, anzi si vede
cheha imparato tanto bene la lezione da potergli spiegareperchè non è un vero
rivoluzionario. E' vero che Toller in realtà aveva paura della rivoluzione poichè
sapevache essa implica quella violenza che ripugnava al suo pacifismo astratto.
Dorst gli mette in boccadelle parolechesenonsonosue gli si addiconoassaibene:
«Forse c'è un solo momento in cui siamo liberi: quando i l vecchio ordine è
distrutto e i l nuovo non si è ancora instaurato ». La logicaconseguenza di questo
( 5 )
Una giovinezza in Germania,
di prossimapubblicazionepresso Einaudi insieme a una
sceltadel teatro nella traduzione di Emilio Castellani.
( 6 )
Die Miinchner Réiterepublik. Zeugnisse und Kommentar
(questocommento è di Helmut
Neubauer), Suhrkamp 1966.
243
















