
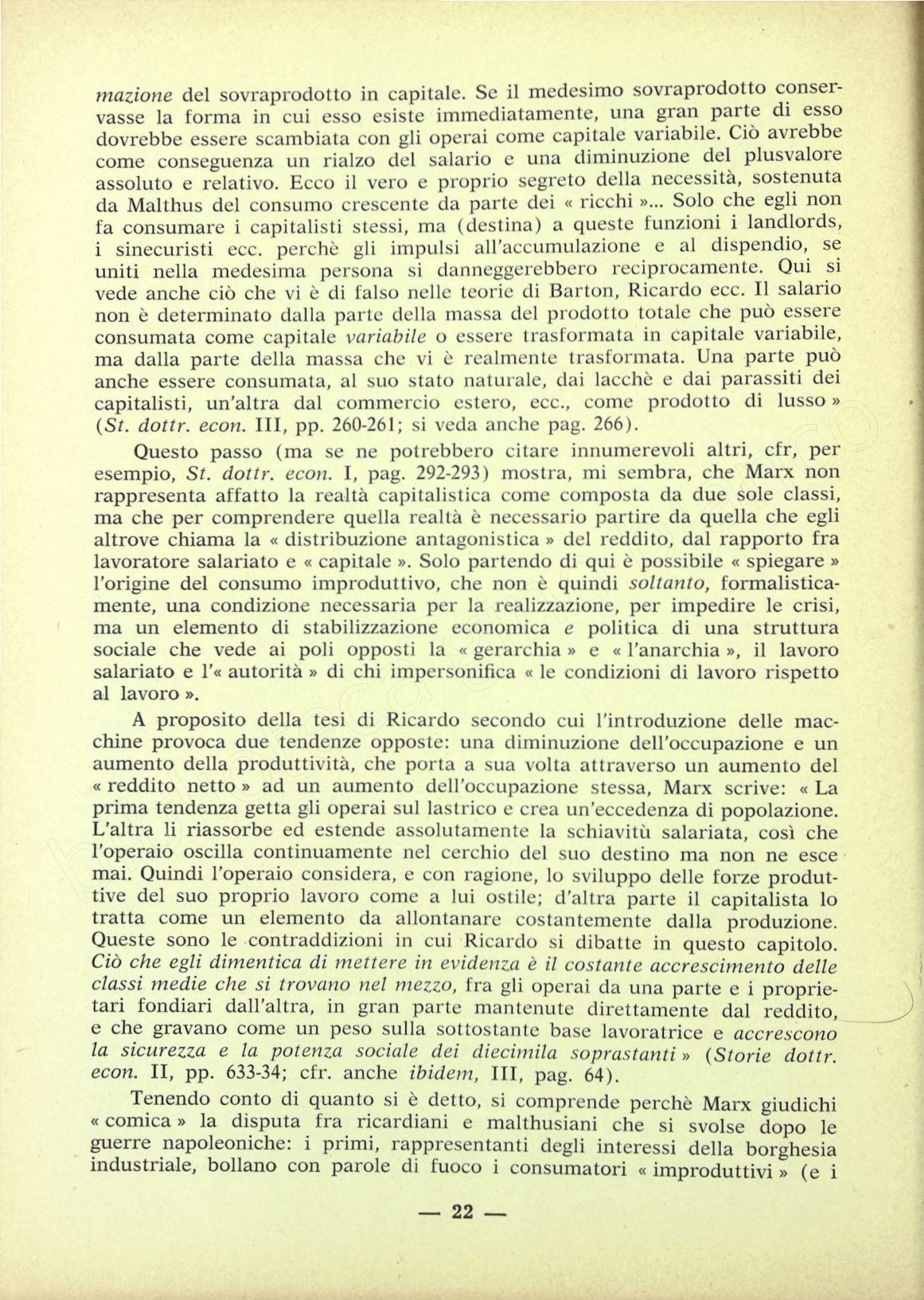
mazione
del sovraprodotto i n capitale. Se i l medesimo sovraprodotto conser-
vasse l a forma i n cu i esso esiste immediatamente, una gran par te d i esso
dovrebbe essere scambiata con gl i operai come capitale variabile. Ciò avrebbe
come conseguenza un r ialzo de l salario e una diminuzione de l plusvalore
assoluto e relativo. Ecco i l vero e propr io segreto del la necessità, sostenuta
da Malthus del consumo crescente da parte dei « ricchi »... Solo che egli non
fa consumare i capitalisti stessi, ma (destina) a queste funzioni i landlords,
i sinecurist i ecc. perchè g l i impul s i all'accumulazione e a l dispendio, se
uni t i nel la medesima persona s i danneggerebbero reciprocamente. Qu i s i
vede anche ciò che vi è di falso nelle teorie di Barton, Ricardo ecc. I l salario
non è determinato dalla parte della massa del prodotto totale che può essere
consumata come capitale
variabile
o essere trasformata in capitale variabile,
ma dal la parte del la massa che v i è realmente trasformata. Una parte può
anche essere consumata, al suo stato naturale, dai lacchè e dai parassiti dei
capitalisti, un'al t ra da l commercio estero, ecc., come prodot to d i lusso »
(St. dot tr. econ. I I I ,
pp. 260-261; si veda anche pag. 266).
Questo passo (ma se ne potrebbero ci tare innumerevol i al t r i , c f r, pe r
esempio,
St. dot t r. econ.
I , pag. 292-293) mostra, mi sembra, che Marx non
rappresenta affatto la realtà capitalistica come composta da due sole classi,
ma che per comprendere quella realtà è necessario part ire da quella che egli
altrove chiama la « distribuzione antagonistica » del reddito, dal rapporto f ra
lavoratore salariato e « capitale ». Solo partendo di qui è possibile « spiegare »
l'origine del consumo improduttivo, che non è quindi
soltanto,
formalistica-
mente, una condizione necessaria per la realizzazione, per impedire le crisi ,
ma u n elemento d i stabilizzazione economica e pol i t ica d i una s t rut tura
sociale che vede a i po l i oppost i l a « gerarchia » e « l'anarchia », i l lavoro
salariato e l'« autorità » di chi impersonifica « le condizioni di lavoro rispetto
al lavoro ».
A proposito del la tesi d i Ricardo secondo cui l ' introduzione del le mac-
chine provoca due tendenze opposte: una diminuzione dell'occupazione e un
aumento della produttività, che porta a sua volta attraverso un aumento del
« reddito net to » ad un aumento dell'occupazione stessa, Mar x scrive: « La
prima tendenza getta gli operai sul lastrico e crea un'eccedenza di popolazione.
L'altra l i riassorbe ed estende assolutamente l a schiavitù salariata, così che
l'operaio oscilla continuamente nel cerchio del suo destino ma non ne esce
mai. Quindi l'operaio considera, e con ragione, lo sviluppo delle forze produt-
tive del suo propr io lavoro come a l u i ostile; d'al t ra parte i l capitalista l o
tratta come u n elemento d a allontanare costantemente da l l a produzione.
Queste sono le .contraddizioni i n cu i Ricardo s i dibatte i n questo capitolo.
Ciò che egli dimentica di mettere in evidenza è i l costante accrescimento delle
classi medie che si trovano nel mezzo,
f ra gl i operai da una parte e i proprie-
tari fondiar i dal l 'al tra, i n gran par te mantenute direttamente da l reddi to,
e che gravano come un peso sul la sottostante base lavoratrice e
accrescono
la sicurezza e l a potenza sociale de i diecimi la soprastanti » (Stor ie dot t r.
econ.
I I ,
pp. 633-34; c f r. anche
ibidem,
I I I ,
pag. 64).
Tenendo conto d i quanto si è detto, si comprende perchè Marx giudichi
«comica » l a disputa f r a r icardiani e mal thusiani che s i svolse dopo l e
guerre napoleoniche: i pr imi , rappresentanti degl i interessi del la borghesia
industriale, bol lano con parole d i fuoco i consumatori « improdut t ivi» ( e i
22 —
















