
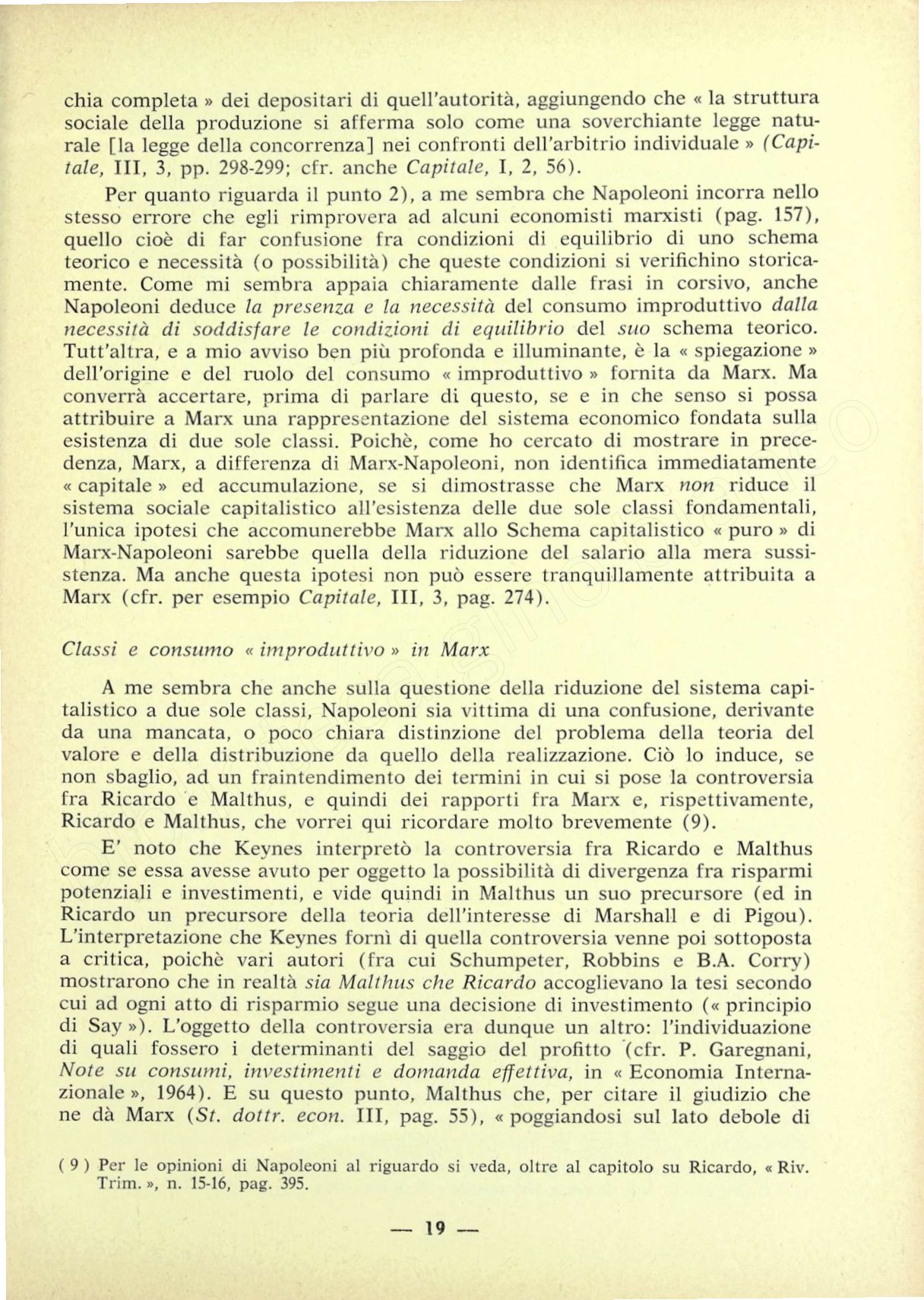
chia completa » dei depositari di quell'autorità, aggiungendo che « la struttura
sociale della produzione si afferma solo come una soverchiante legge natu-
rale [la legge della concorrenza] nei confronti dell'arbitrio individuale »
(Capi-
tale,
I I I , 3, pp. 298-299; cfr. anche
Capitale,
I , 2, 56).
Per quanto riguarda il punto 2), a me sembra che Napoleoni incorra nello
stesso errore che egli rimprovera ad alcuni economisti marxisti (pag. 157),
quello cioè d i f a r confusione f ra condizioni d i equilibrio d i uno schema
teorico e necessità (o possibilità) che queste condizioni si verifichino storica-
mente. Come mi sembra appaia chiaramente dalle frasi i n corsivo, anche
Napoleoni deduce
la presenza
e
la necessità
del consumo improduttivo
dalla
necessità d i soddisfare l e condizioni d i equilibrio del suo schema teorico.
Tutt'altra, e a mio avviso ben più profonda e illuminante, è la « spiegazione »
dell'origine e del ruolo del consumo « improduttivo » fornita da Marx. Ma
converrà accertare, prima di parlare d i questo, se e in che senso si possa
attribuire a Marx una rappresentazione del sistema economico fondata sulla
esistenza di due sole classi. Poichè, come ho cercato di mostrare in prece-
denza, Marx, a differenza di Marx-Napoleoni, non identifica immediatamente
«capitale » ed accumulazione, se s i dimostrasse che Marx
non
riduce i l
sistema sociale capitalistico all'esistenza delle due sole classi fondamentali,
l'unica ipotesi che accomunerebbe Marx allo Schema capitalistico « puro » di
Marx-Napoleoni sarebbe quella della riduzione del salario al la mera sussi-
stenza. Ma anche questa ipotesi non può essere tranquillamente attribuita a
Marx (cfr. per esempio
Capitale,
I I I , 3, pag. 274).
Classi e consumo « improduttivo » in Marx
A me sembra che anche sulla questione della riduzione del sistema capi-
talistico a due sole classi, Napoleoni sia vittima di una confusione, derivante
da una mancata, o poco chiara distinzione del problema della teoria del
valore e della distribuzione da quello della realizzazione. Ciò lo induce, se
non sbaglio, ad un fraintendimento dei termini in cui si pose la controversia
fra Ricardo e Malthus, e quindi dei rapporti f ra Marx e, rispettivamente,
Ricardo e Malthus, che vorrei qui ricordare molto brevemente (9) .
E' noto che Keynes interpretò l a controversia f ra Ricardo e Malthus
come se essa avesse avuto per oggetto la possibilità di divergenza fra risparmi
potenziali e investimenti, e vide quindi in Malthus un suo precursore (ed in
Ricardo un precursore della teoria dell'interesse d i Marshall e d i Pigou).
L'interpretazione che Keynes fornì di quella controversia venne poi sottoposta
a critica, poichè vari autori ( f r a cui Schumpeter, Robbins e B.A. Corry)
mostrarono che in realtà
sia Malthus che Ricardo
accoglievano la tesi secondo
cui ad ogni atto di risparmio segue una decisione di investimento (« principio
di Say »). L'oggetto della controversia era dunque un altro: l'individuazione
di quali fossero i determinanti del saggio del profitto e(cfr. P. Garegnani,
Note su consumi, investimenti e domanda effettiva, in « Economia Interna-
zionale », 1964). E su questo punto, Malthus che, per citare i l giudizio che
ne dà Marx
(St. dottr. econ.
I I I , pag. 55), « poggiandosi sul lato debole di
( 9 ) Per le opinioni di Napoleoni al riguardo si veda, oltre al capitolo su Ricardo, « Riv.
Trim. », n. 15-16, pag. 395.
— 19
















