
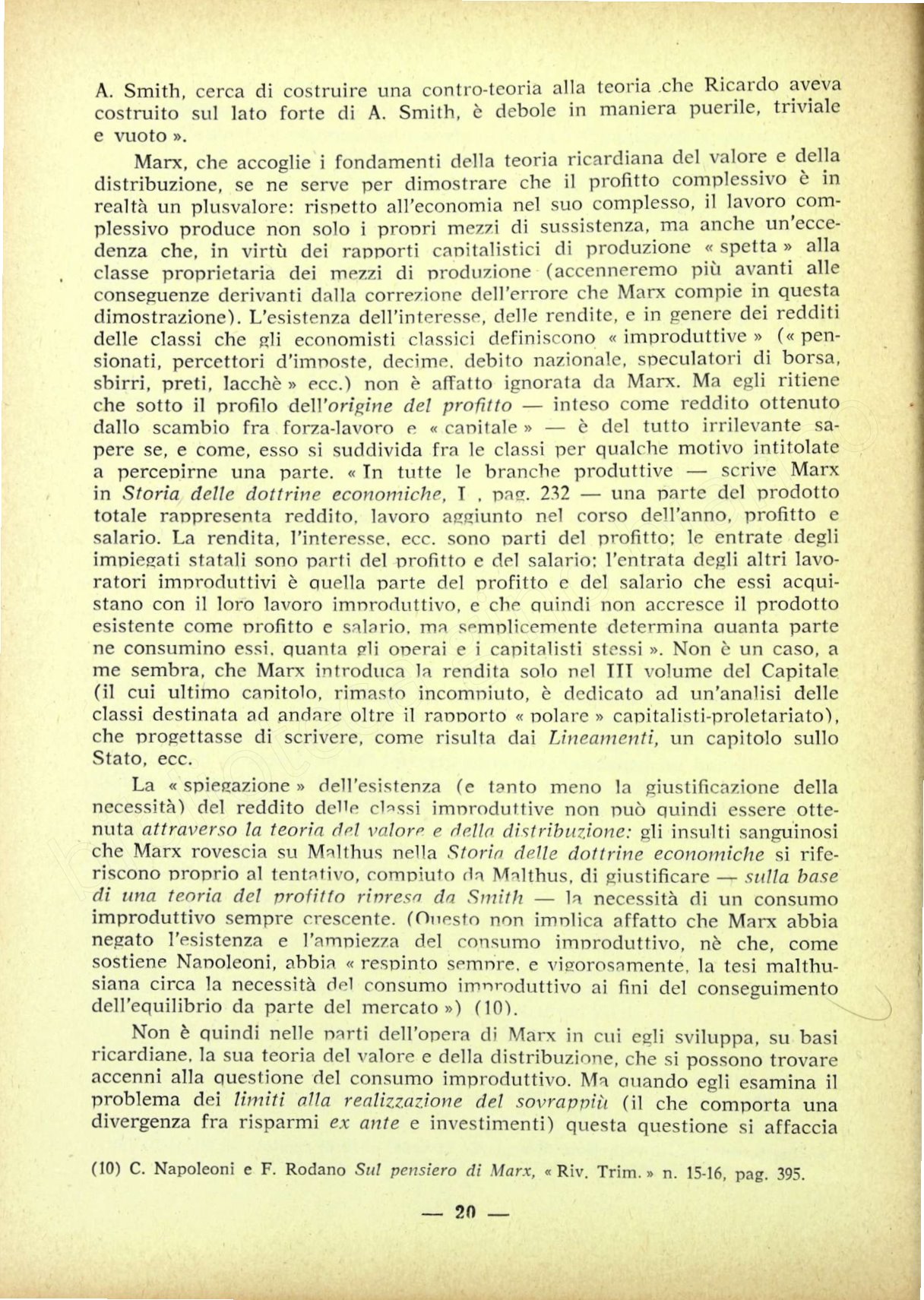
A. Smith, cerca di costruire una contro-teoria alla teoria .che Ricardo aveva
costruito sul lato forte d i A. Smith, è debole i n maniera puerile, triviale
e vuoto ».
Marx, che accoglie i fondamenti della teoria ricardiana del valore e della
distribuzione, se ne serve per dimostrare che i l profitto complessivo è i n
realtà un plusvalore: rispetto all'economia nel suo complesso, i l lavoro com-
plessivo produce non solo i propri mezzi di sussistenza, ma anche un'ecce-
denza che, i n virtù dei rapporti canitalistici d i produzione « spetta » al la
classe proprietaria dei mezzi d i produzione• (accenneremo più avanti al le
conseguenze derivanti dalla correzione dell'errore che Marx compie in questa
dimostrazione). L'esistenza dell'interesse, delle rendite, e in genere dei redditi
delle classi che gli economisti classici definiscono « improduttive » ( « pen-
sionati, percettori d'imposte, decime. debito nazionale, speculatori di borsa,
sbirri, preti, lacchè » ecc.) non è affatto ignorata da Marx. Ma egli ritiene
che sotto i l profilo
dell'origine del profitto
— inteso come reddito ottenuto
dallo scambio f ra forza-lavoro e « capitale » — è del tutto irrilevante sa-
pere se, e come, esso si suddivida fra le classi per qualche motivo intitolate
a percepirne una parte. « In tutte l e branche produttive — scrive Marx
in
Storia delle dottrine economiche,
I , pag. 232 — una parte del prodotto
totale rappresenta reddito, lavoro aggiunto nel corso dell'anno, profitto e
salario. La rendita, l'interesse, ecc. sono parti del profitto; l e entrate degli
impiegati statali sono parti del profitto e del salario: l'entrata degli altri lavo-
ratori improduttivi è quella parte del profitto e del salario che essi acqui-
stano con i l loro lavoro imnroduttivo, e che quindi non accresce i l prodotto
esistente come profitto e salario, ma semplicemente determina auanta parte
ne consumino essi, quanta gli onerai e i capitalisti stessi ». Non è un caso, a
me sembra, che Marx introduca la rendita solo nel I I I volume del Capitale
(il cui ultimo capitolo, rimasto incompiuto, è dedicato ad un'analisi delle
classi destinata ad andare oltre il rapporto « polare » capitalisti-proletariato),
che progettasse di scrivere, come risulta dai
Lineamenti,
un capitolo sullo
Stato, ecc.
La « spiegazione » dell'esistenza ( e tanto meno l a giustificazione della
necessità) del reddito delle clnssi imnroduttive non può quindi essere otte-
nuta attraverso la teoria del valore e della distribuzione: gli insulti sanguinosi
che Marx rovescia su Malthus nella
Storia delle dottrine economiche
si rife-
riscono proprio al tentativo, compiuto da Malthus, di giustificare
s u l l a base
di una teoria del profitto ripresa da Smith — la necessità di un consumo
improduttivo sempre crescente. (Onesto non implica affatto che Marx abbia
negato l'esistenza e l'ampiezza del consumo improduttivo, nè che, come
sostiene Nanoleoni, abbia « respinto sempre, e vigorosamente, la tesi malthu-
siana circa la necessità del consumo imnroduttivo ai fini del conseguimento
dell'equilibrio da parte del mercato ») (10).
Non è quindi nelle parti dell'opera di Marx in cui egli sviluppa, su basi
ricardiane, la sua teoria del valore e della distribuzione, che si possono trovare
accenni alla questione del consumo improduttivo. Ma auando egli esamina il
problema dei l imi t i alla realizzazione del sovrappitt ( i l che comporta una
divergenza fra risparmi
ex ante
e investimenti) questa questione si affaccia
(10) C. Napoleoni e R Rodano
Sul pensiero d i Marx,
«
Riv.
Tr im. » n. 15-16, pag. 395.
— 20
















