
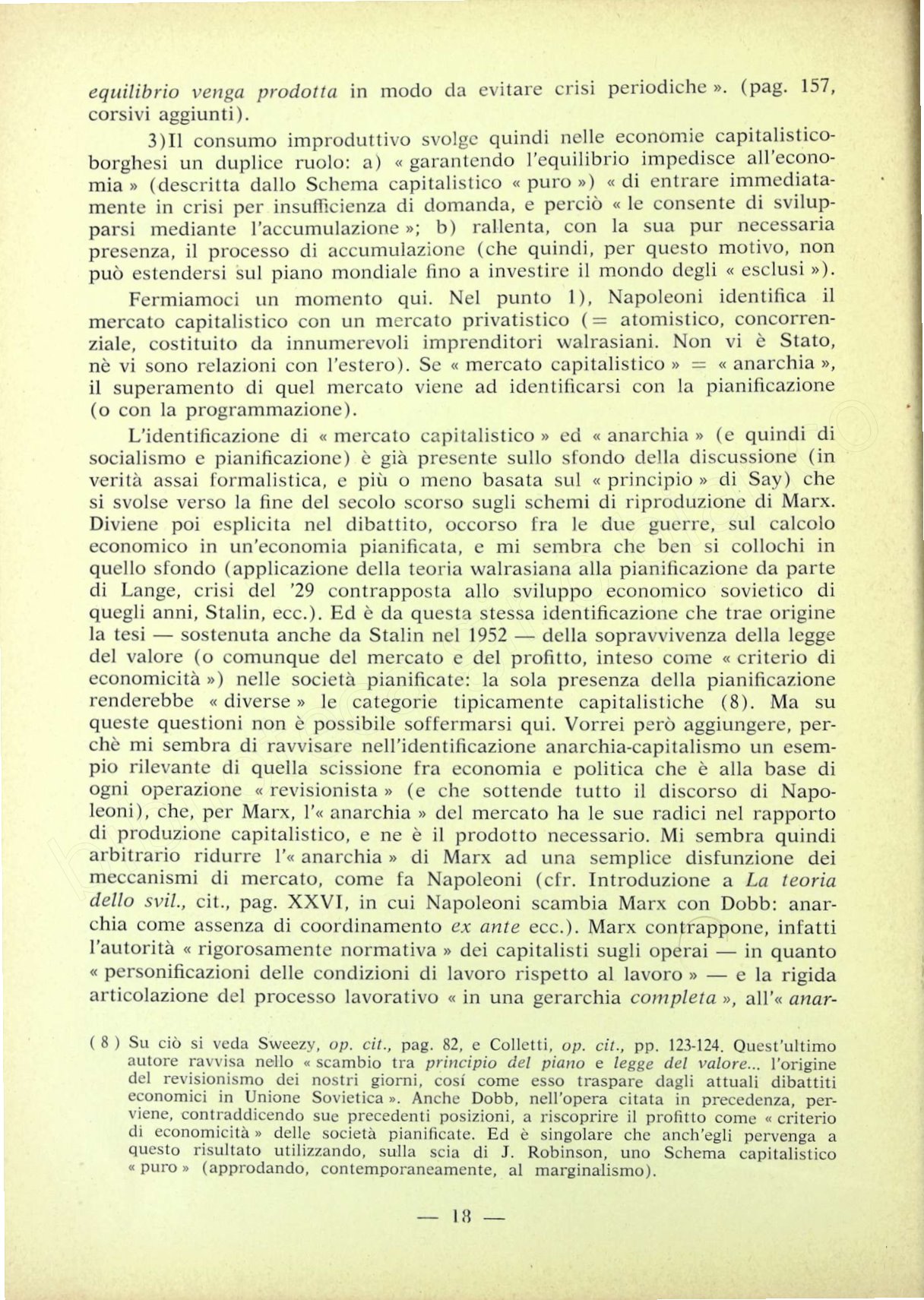
equilibrio venga prodotta
in modo da evitare crisi periodiche ». (pag. 157,
corsivi aggiunti).
3)11 consumo improduttivo svolge quindi nelle economie capitalistico-
borghesi un duplice ruolo: a ) «garantendo l'equilibrio impedisce all'econo-
mia » (descritta dallo Schema capitalistico « puro ») « di entrare immediata-
mente in crisi per insufficienza di domanda, e perciò «le consente di svilup-
parsi mediante l'accumulazione »; b ) rallenta, con l a sua pur necessaria
presenza, i l processo di accumulazione (che quindi, per questo motivo, non
può estendersi Sul piano mondiale fino a investire il mondo degli « esclusi »).
Fermiamoci un momento qui . Ne l punto 1 ) , Napoleoni identifica i l
mercato capitalistico con un mercato privatistico ( = atomistico, concorren-
ziale, costituito da innumerevoli imprenditori walrasiani. Non v i è Stato,
nè vi sono relazioni con l'estero). Se « mercato capitalistico » = « anarchia »,
il superamento di quel mercato viene ad identificarsi con la pianificazione
(o con la programmazione).
L'identificazione di « mercato capitalistico » ed «anarchia » ( e quindi di
socialismo e pianificazione) è già presente sullo sfondo della discussione ( in
verità assai formalistica, e più o meno basata sul « principio » di Say) che
si svolse verso la fine del secolo scorso sugli schemi di riproduzione di Marx.
Diviene poi esplicita nel dibattito, occorso f ra l e due guerre, sul calcolo
economico in un'economia pianificata, e mi sembra che ben si collochi i n
quello sfondo (applicazione della teoria walrasiana alla pianificazione da parte
di Lange, crisi del '29 contrapposta allo sviluppo economico sovietico d i
quegli anni, Stalin, ecc.). Ed è da questa stessa identificazione che trae origine
la tesi — sostenuta anche da Stalin nel 1952 — della sopravvivenza della legge
del valore (o comunque del mercato e del profitto, inteso come «criterio di
economicità ») nelle società pianificate: l a sola presenza della pianificazione
renderebbe « diverse)) l e categorie tipicamente capitalistiche ( 8 ) . M a su
queste questioni non è possibile soffermarsi qui. Vorrei però aggiungere, per-
chè mi sembra di ravvisare nell'identificazione anarchia-capitalismo un esem-
pio rilevante di quella scissione fra economia e politica che è alla base di
ogni operazione « revisionista » ( e che sottende tutto i l discorso d i Napo-
leoni), che, per Marx, l'« anarchia » del mercato ha le sue radici nel rapporto
di produzione capitalistico, e ne è i l prodotto necessario. Mi sembra quindi
arbitrario ridurre l '« anarchia» d i Marx ad una semplice disfunzione dei
meccanismi d i mercato, come f a Napoleoni (cf r. Introduzione a
La teoria
dello svil.,
cit., pag. XXVI , in cui Napoleoni scambia Marx con Dobb: anar-
chia come assenza di coordinamento
ex ante
ecc.). Marx contrappone, infatti
l'autorità « rigorosamente normativa » dei capitalisti sugli operai — in quanto
«personificazioni delle condizioni di lavoro rispetto al lavoro » — e la rigida
articolazione del processo lavorativo « in una gerarchia
completa»,
all'«
anar-
( 8 ) Su ciò si veda Sweezy,
op. cit.,
pag. 82, e Colletti,
op. cit.,
pp. 123-124. Quest'ultimo
autore ravvisa nello « scambio tra
principio del piano
e
legge del valore..,
l'origine
del revisionismo dei nostri giorni, cosí come esso traspare dagli attuali dibattiti
economici in Unione Sovietica ». Anche Dobb, nell'opera citata in precedenza, per-
viene, contraddicendo sue precedenti posizioni, a riscoprire i l profitto come « criterio
di economicità> delle società pianificate. Ed è singolare che anch'egli pervenga a
questo risultato utilizzando, sulla scia d i J . Robinson, uno Schema capitalistico
«puro » (approdando, contemporaneamente, a l marginalismo).
18 —
















