
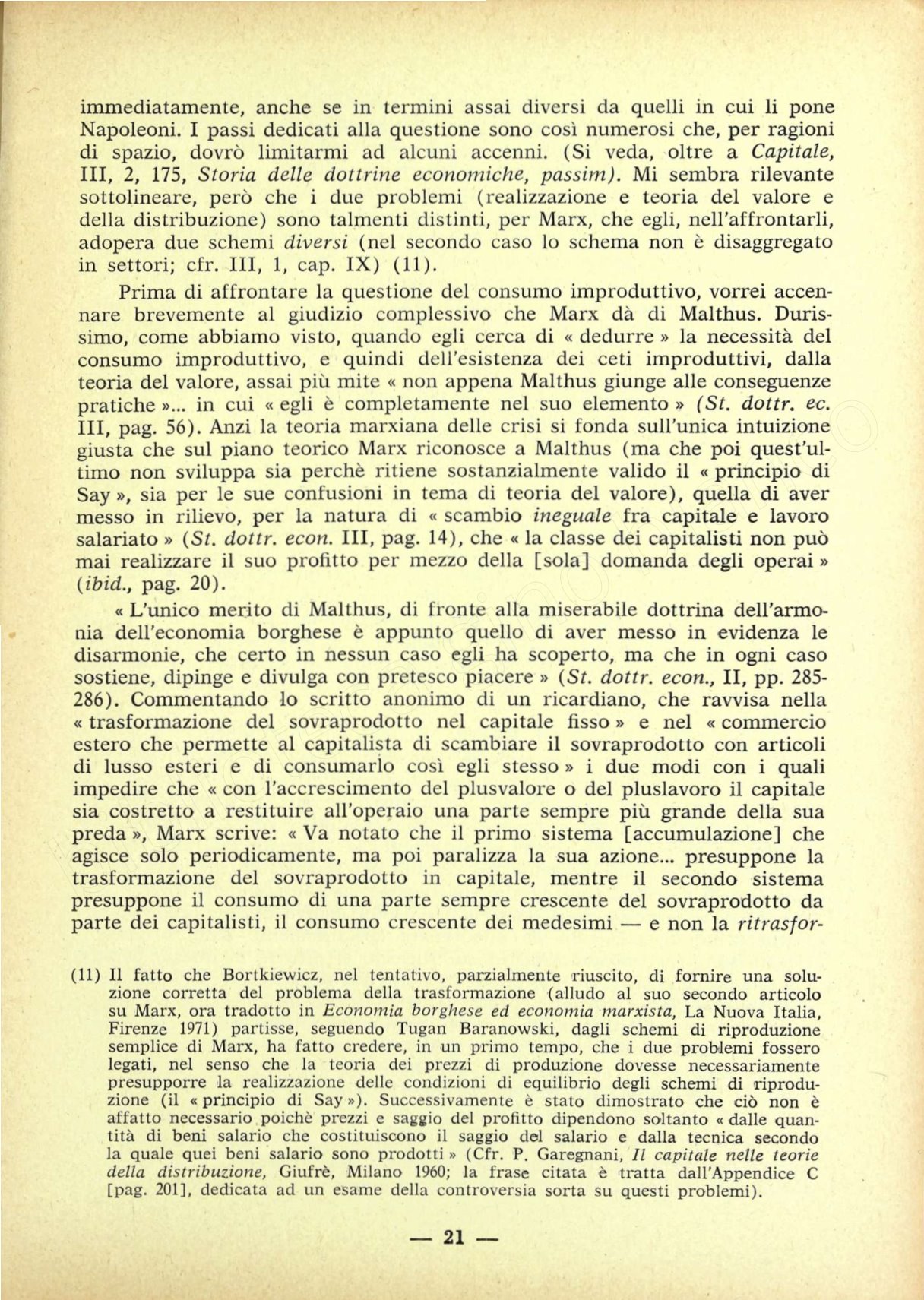
immediatamente, anche se in termini assai diversi da quelli in cui l i pone
Napoleoni. I passi dedicati alla questione sono così numerosi che, per ragioni
di spazio, dovrò limitarmi ad alcuni accenni. ( S i veda, oltre a
Capitale,
I I I , 2, 175, Storia delle dottrine economiche, passim). M i sembra rilevante
sottolineare, però che i due problemi (realizzazione e teoria del valore e
della distribuzione) sono talmenti distinti, per Marx, che egli, nell'affrontarli,
adopera due schemi
diversi
(nel secondo caso lo schema non è disaggregato
in settori; cfr. I I I , 1, cap. I X ) (11) .
Prima di affrontare la questione del consumo improduttivo, vorrei accen-
nare brevemente a l giudizio complessivo che Marx dà d i Malthus. Duris-
simo, come abbiamo visto, quando egli cerca di « dedurre » la necessità del
consumo improduttivo, e quindi dell'esistenza dei ceti improduttivi, dalla
teoria del valore, assai più mite « non appena Malthus giunge alle conseguenze
pratiche »... in cui « egli è completamente nel suo elemento »
(St. dottr. ec.
I I I , pag. 56). Anzi la teoria marxiana delle crisi si fonda sull'unica intuizione
giusta che sul piano teorico Marx riconosce a Malthus (ma che poi quest'ul-
timo non sviluppa sia perchè ritiene sostanzialmente valido i l « principio di
Say », sia per le sue confusioni in tema di teoria del valore), quella di aver
messo in rilievo, per la natura di « scambio
ineguale
f ra capitale e lavoro
salariato »
(St. dottr. econ. I I I ,
pag. 14), che « la classe dei capitalisti non può
mai realizzare i l suo profitto per mezzo della [sola] domanda degli operai »
(ibid.,
pag. 20).
«L'unico merito di Malthus, di fronte alla miserabile dottrina dell'armo-
nia dell'economia borghese è appunto quello d i aver messo i n evidenza le
disarmonie, che certo in nessun caso egli ha scoperto, ma che in ogni caso
sostiene, dipinge e divulga con pretesco piacere))
d o t t r . econ.,
I I , pp. 285-
286). Commentando lo scritto anonimo di un ricardiano, che ravvisa nella
« trasformazione del sovraprodotto nel capitale fisso » e nel « commercio
estero che permette al capitalista di scambiare i l sovraprodotto con articoli
di lusso esteri e d i consumarlo così egli stesso » i due modi con i quali
impedire che « con l'accrescimento del plusvalore o del pluslavoro il capitale
sia costretto a restituire all'operaio una parte sempre più grande della sua
preda », Marx scrive: « Va notato che i l primo sistema [accumulazione] che
agisce solo periodicamente, ma poi paralizza la sua azione... presuppone la
trasformazione de l sovraprodotto i n capitale, mentre i l secondo sistema
presuppone i l consumo di una parte sempre crescente del sovraprodotto da
parte dei capitalisti, i l consumo crescente dei medesimi e non la
ritrasfor-
(11) I l fatto che Bortkiewicz, nel tentativo, parzialmente riuscito, d i fornire una solu-
zione corretta del problema della trasformazione (alludo a l suo secondo articolo
su Marx, ora tradotto in
Economia borghese ed economia marxista,
La Nuova Italia,
Firenze 1971) partisse, seguendo Tugan Baranowski, dagli schemi d i riproduzione
semplice di Marx, ha fatto credere, in un primo tempo, che i due problemi fossero
legati, nel senso che l a teoria dei prezzi d i produzione dovesse necessariamente
presupporre l a realizzazione delle condizioni d i equilibrio degli schemi d i riprodu-
zione ( i l « principio d i Say »). Successivamente è stato dimostrato che ciò non è
affatto necessario ,poichè prezzi e saggio del profitto dipendono soltanto « dalle quan-
tità di beni salario che costituiscono i l saggio del salario e dalla tecnica secondo
la quale quei beni salario sono prodotti » (Cfr. P. Garegnani,
11 capitale nelle teorie
della distribuzione,
Giufrè, Milano 1960; l a frase citata è tratta dall'Appendice C
[pag. 201], dedicata ad un esame della controversia sorta su questi problemi).
21
















