
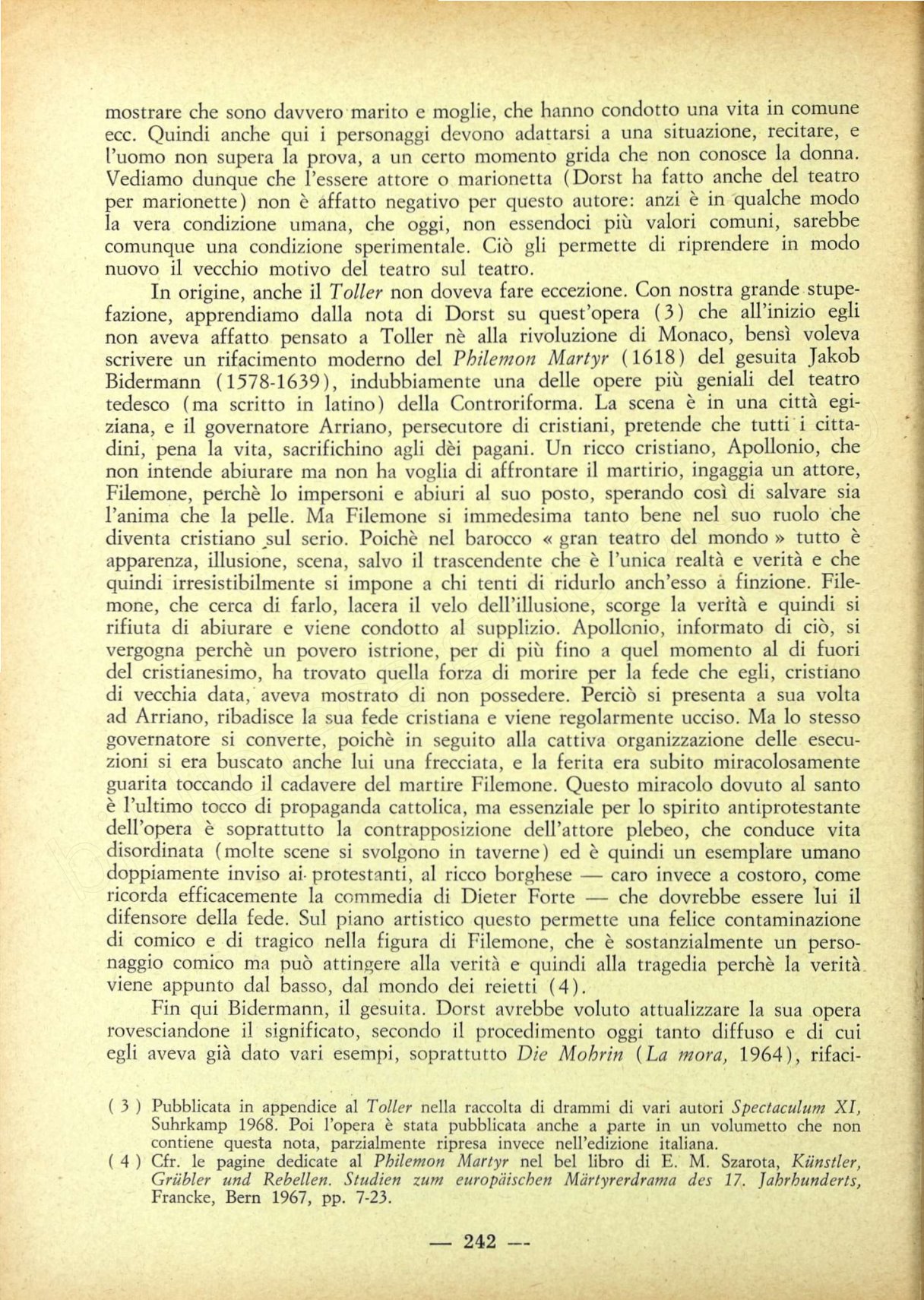
mostrareche sono davvero•marito e moglie, che hanno condotto una vita in comune
ecc. Quindi anche qui i personaggi devono adattarsi a una situazione, recitare, e
l'uomo non supera la prova, a un certo momento grida che non conosce la donna.
Vediamo dunque che l'essere attore o marionetta (Dorst ha fatto anche del teatro
per marionette) non è affatto negativo per questo autore: anzi è in -qualchemodo
la vera condizione umana, che oggi, non essendoci più valori comuni, sarebbe
comunque una condizione sperimentale. Ciò gli permette di riprendere in modo
nuovo i l vecchio motivo del teatro sul teatro.
In origine, anche il
Toller
non doveva fare eccezione. Con nostra grande stupe-
f azione, apprendiamo dalla nota di Dorst su quest'opera (3) che all'inizio egli
non aveva affatto pensato a Toller nè alla rivoluzione di Monaco, bensì voleva
scrivere un rifacimento moderno del
Philemon Martyr
(1618) del gesuita Jakob
Bidermann (1578-1639), indubbiamente una delle opere più geniali del teatro
tedesco (ma scritto in latino) della Controriforma. La scena è in una città egi-
ziana, e i l governatore Arriano, persecutore di cristiani, pretende che tutti- i citta-
dini, •pena la vita, sacrifichino agli dèi pagani. Un ricco cristiano, Apollonio, che
non intende abiurarema non ha voglia di affrontare il martirio, ingaggia un attore,
Filemone, perchè lo impersoni e abiuri al suo posto, sperando così di salvare sia
l'anima che la pelle. Ma Filemone si immedesima tanto bene nel suo ruolo the
diventa cristiano _sul serio. Poichè nel barocco « gran teatro del mondo » tutto è
apparenza, illusione, scena, salvo i l trascendente che è l'unica realtà e verità e che
quindi irresistibilmente si impone a chi tenti di ridurlo anch'esso à finzione. File-
mone, che cerca di farlo, lacera i l velo dell'illusione, scorge la verità e quindi si
rifiuta di abiurare e viene condotto al supplizio. Apollonio, informato di ciò, si
vergognaperchè un povero istrione, per di più fino a quel momento al di fuori
del cristianesimo, ha trovato quella forza di morire per la fede che egli, cristiano
di vecchia data: avevamostrato di non possedere. Perciò si presenta a sua volta
adArriano, ribadisce la sua fede cristiana e viene regolarmente ucciso. Ma lo stesso
governatore si converte, poichè in seguito alla cattiva organizzazione delle esecu-
zioni si era buscato anche lui una frecciata, e la ferita era subito miracolosamente
guarita toccando il cadavere del martire Filemone. Questo miracolo dovuto al santo
è l'ultimo tocco di propaganda cattolica, maessenziale per lo spirito antiprotestante
dell'opera è soprattutto la contrapposizione dell'attore plebeo, che conduce vita
disordinata (molte scene si svolgono in taverne) ed è quindi un esemplare umano
doppiamente inviso ai- protestanti, al ricco borghese — caro invece a costoro, come
ricorda efficacemente la commedia di Dieter Forte — che dovrebbe essere lui i l
difensore della fede. Sul piano artistico questo permette una felice contaminazione
di comico e di tragico nella figura di Filemone, che è sostanzialmente un perso-
naggio comico ma può attingere alla verità e quindi alla tragedia perchè la verità_
viene appunto dal basso, dal mondo dei reietti (4).
Fin qui Bidermann, i l gesuita. Dorst avrebbe voluto attualizzare la sua opera
rovesciandone i l significato, secondo i l procedimento oggi tanto diffuso e di cui
egli aveva già dato vari esempi, soprattutto
Die Mohrin (La mora,
1964), rifaci-
( 3 ) Pubblicata in appendice al
Toller
nella raccolta di drammi di vari autori
Spectaculum XI ,
Suhrkamp 1968. Poi l'opera è stata pubblicata anche a parte in un volumetto che non
contiene questa nota, parzialmente ripresa invece nell'edizione italiana.
( 4 ) Cfr. le pagine dedicate al
Philemon Martyr
nel bel libro d i E. M. Szarota,
Kiinstler,
Griibler und Rebellen. Studien zum europiiischen Miirtyrerdrama des 17. Jahrhunderts,
Francke, Bern 1967, pp. 7-23.
242
















