
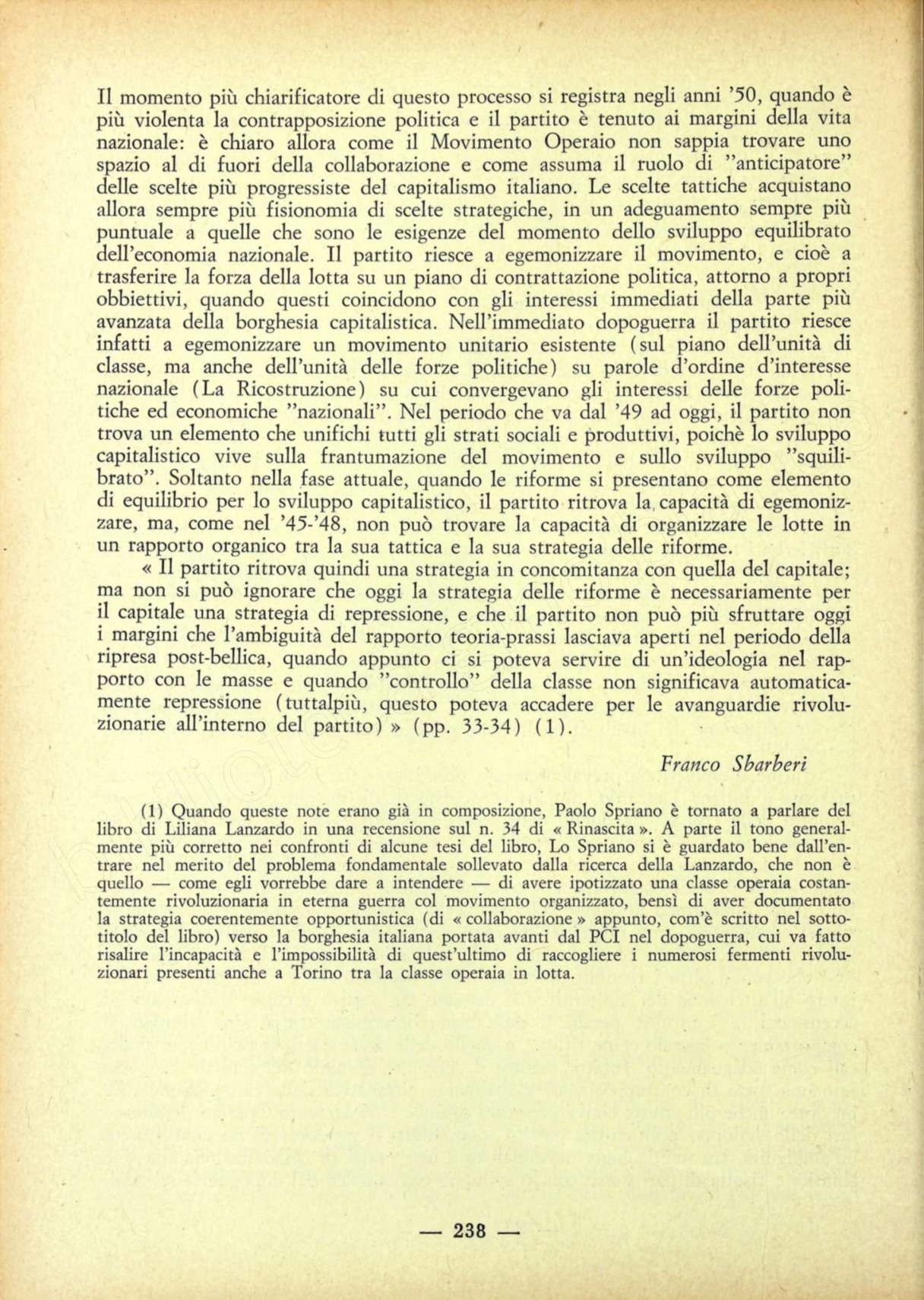
Il momento più chiarificatore di questoprocesso si registra negli anni '50, quando è
più violenta la contrapposizione politica e i l partito è tenuto ai margini della vita
nazionale: è chiaro allora come i l Movimento Operaio non sappia trovare uno
spazio al di fuori della collaborazione e comeassuma i l ruolo di "anticipatore"
delle scelte più progressiste del capitalismo italiano. Le scelte tattiche acquistano
allorasempre più fisionomia di scelte strategiche, in un adeguamentosempre più
puntuale a quelle che sono le esigenze del momento dello sviluppo equilibrato
dell'economianazionale. I l partito riesce a egemonizzare i l movimento, e cioè a
trasferire la forza della lotta su un piano di contrattazione politica, attorno a propri
obbiettivi, quando questi coincidono con gli interessi immediati della parte più
avanzatadella borghesia capitalistica. Nell'immediato dopoguerra i l partito riesce
infatti a egemonizzare un movimento unitario esistente (sul piano dell'unità di
classe, ma anche dell'unità delle forze politiche) su parole d'ordine d'interesse
nazionale (La Ricostruzione) su cui convergevano gli interessi delle forze poli-
tiche edeconomiche "nazionali". Nel periodo che va dal '49 ad oggi, il partito non
trova un elementoche unifichi tutti gli strati sociali e produttivi, poichè lo sviluppo
capitalistico vive sulla frantumazione del movimento e sullo sviluppo "squili-
brato". Soltanto nella fase attuale, quando le riforme si presentanocomeelemento
di equilibrio per lo sviluppo capitalistico, il partito ritrova la, capacità di egemoniz-
zare,ma, come nel '45-'48, non può trovare la capacità di organizzare le lotte in
un rapporto organico tra la sua tattica e la suastrategia delle riforme.
« Il partito ritrova quindi unastrategia in concomitanzaconquella del capitale;
manon si può ignorare che oggi la strategia delle riforme è necessariamente per
il capitale una strategia di repressione, e che i l partito non può più sfruttare oggi
i margini che l'ambiguità del rapporto teoria-prassi lasciava aperti nel periodo della
ripresa post-bellica, quando appunto ci si poteva servire di un'ideologia nel rap-
porto con le masse e quando "controllo" della classe non significava automatica-
menterepressione (tuttalpiù, questo poteva accadere per le avanguardie rivolu-
zionarie all'interno del partito) » (pp. 33-34) ( 1).
FrancoSbarberi
(1) Quando queste note erano già in composizione, Paolo Spriano è tornato a parlare del
libro di Liliana Lanzardo in una recensione sul n. 34 di « Rinascita ». A parte i l tono general-
mente più corretto nei confronti di alcune tesi del libro, Lo Spriano si è guardato bene dall'en-
trare nel merito del problema fondamentale sollevato dalla ricerca della Lanzardo, che non è
quello — come egli vorrebbe dare a intendere — di avere ipotizzato una classe operaia costan-
temente rivoluzionaria in eterna guerra col movimento organizzato, bensì di aver documentato
la strategia coerentemente opportunistica (di « collaborazione » appunto, com'è scritto nel sotto-
titolo del libro) verso la borghesia italiana portata avanti dal PCI nel dopoguerra, cui va fatto
risalire l'incapacità e l'impossibilità di quest'ultimo di raccogliere i numerosi fermenti rivolu-
zionari presenti anche a Torino tra la classe operaia in lotta.
















