
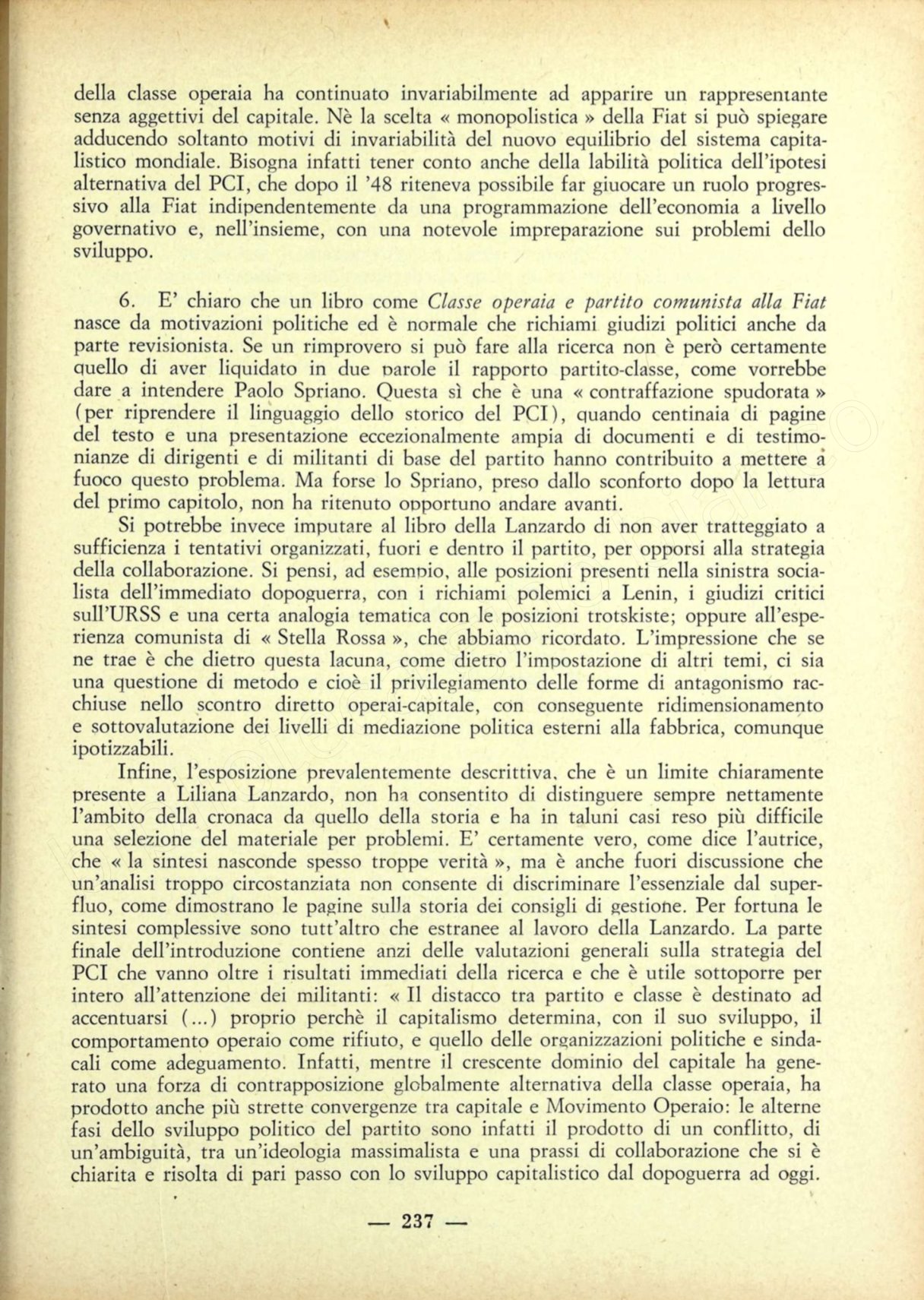
dellaclasse operaia ha continuato invariabilmente ad apparire un rappresentante
senzaaggettivi del capitale. Nè la scelta «monopolistica » della Fiat si puòspiegare
adducendosoltanto motivi di invariabilità del nuovo equilibrio del sistema capita-
listicomondiale. Bisogna infatti tener contoanche della labilità politica dell'ipotesi
alternativa del PCI, chedopo il '48 riteneva possibile far giuocare un molo progres-
sivo alla Fiat indipendentemente da una programmazione dell'economia a livello
governativo e, nell'insieme, con una notevole impreparazione sui problemi dello
sviluppo.
6. E ' chiaro che un libro comeClasseoperaia e partito comunista alla Fiat
nasceda motivazioni politiche ed è normale che richiami giudizi politici anche da
parte revisionista. Se un rimprovero si può fare alla ricerca non è però certamente
quello di aver liquidato in due parole i l rapporto partito-classe, come vorrebbe
dare a intendere Paolo Spriano. Questa sì che è una « contraffazione spudorata»
(per riprendere i l linguaggio dello storico del PCI), quando centinaia di pagine
del testo e una presentazioneeccezionalmente ampia di documenti e di testimo-
nianze di dirigenti e di militanti di base del partito hanno contribuito a mettere à
fuocoquesto problema. Ma forse lo Spriano, preso dallo sconforto dopo la lettura
del primo capitolo, non ha ritenuto opportunoandareavanti.
Sipotrebbe invece imputare al libro della Lanzardo di non aver tratteggiato a
sufficienza i tentativi organizzati, fuori e dentro il partito, per opporsi alla strategia
dellacollaborazione. Si pensi, adesempio, alle posizioni presenti nella sinistra socia-
lista dell'immediato dopoguerra, con i richiami polemici a Lenin, i giudizi critici
sull'URSSe una certaanalogia tematica con le posizioni trotskiste; oppure all'espe-
rienzacomunista di « StellaRossa», che abbiamo ricordato. L'impressione che se
ne trae è che dietro questa lacuna, come dietro l'impostazione di altri temi, ci sia
unaquestione di metodo e cioè il privilegiamento delle forme di antagonismo rac-
chiuse nello scontro diretto operai-capitale, con conseguente ridimensionamento
esottovalutazione dei livelli di mediazione politica esterni alla fabbrica, comunque
ipotizzabili.
Infine, l'esposizioneprevalentemente descrittiva, che è un limite chiaramente
presente a Liliana Lanzardo, non ha consentito di distinguere semprenettamente
l'ambito della cronaca da quello della storia e ha in taluni casi reso più difficile
unaselezione del materiale per problemi. E' certamente vero, come dice l'autrice,
che « la sintesi nascondespesso troppe verità », ma è anche fuori discussione che
un'analisi troppo circostanziata non consente di discriminare l'essenziale dal super-
fluo, comedimostrano le pagine sulla storia dei consigli di gestione. Per fortuna le
sintesi complessivesono tutt'altro cheestranee al lavoro della Lanzardo. La parte
finale dell'introduzione contiene anzi delle valutazioni generali sulla strategia del
PCI che vanno oltre i risultati immediati della ricerca e che è utile sottoporre per
intero all'attenzione dei militanti: « Il distacco tra partito e classe è destinato ad
accentuarsi ( ...) proprio perchè i l capitalismo determina, con i l suo sviluppo, i l
comportamentooperaiocome rifiuto, e quello delle organizzazioni politiche e sinda-
cali comeadeguamento. Infatti, mentre i l crescente dominio del capitale ha gene-
rato una forza di contrapposizioneglobalmente alternativa della classeoperaia, ha
prodottoanche più stretteconvergenze tra capitale eMovimentoOperaio: le alterne
fasi dello sviluppo politico del partito sono infatti i l prodotto di un conflitto, di
un'ambiguità, tra un'ideologiamassimalista e una prassi di collaborazione che si è
chiarita e risolta di pari passocon lo sviluppo capitalistico dal dopoguerra ad oggi.
•
- 237 -
















