
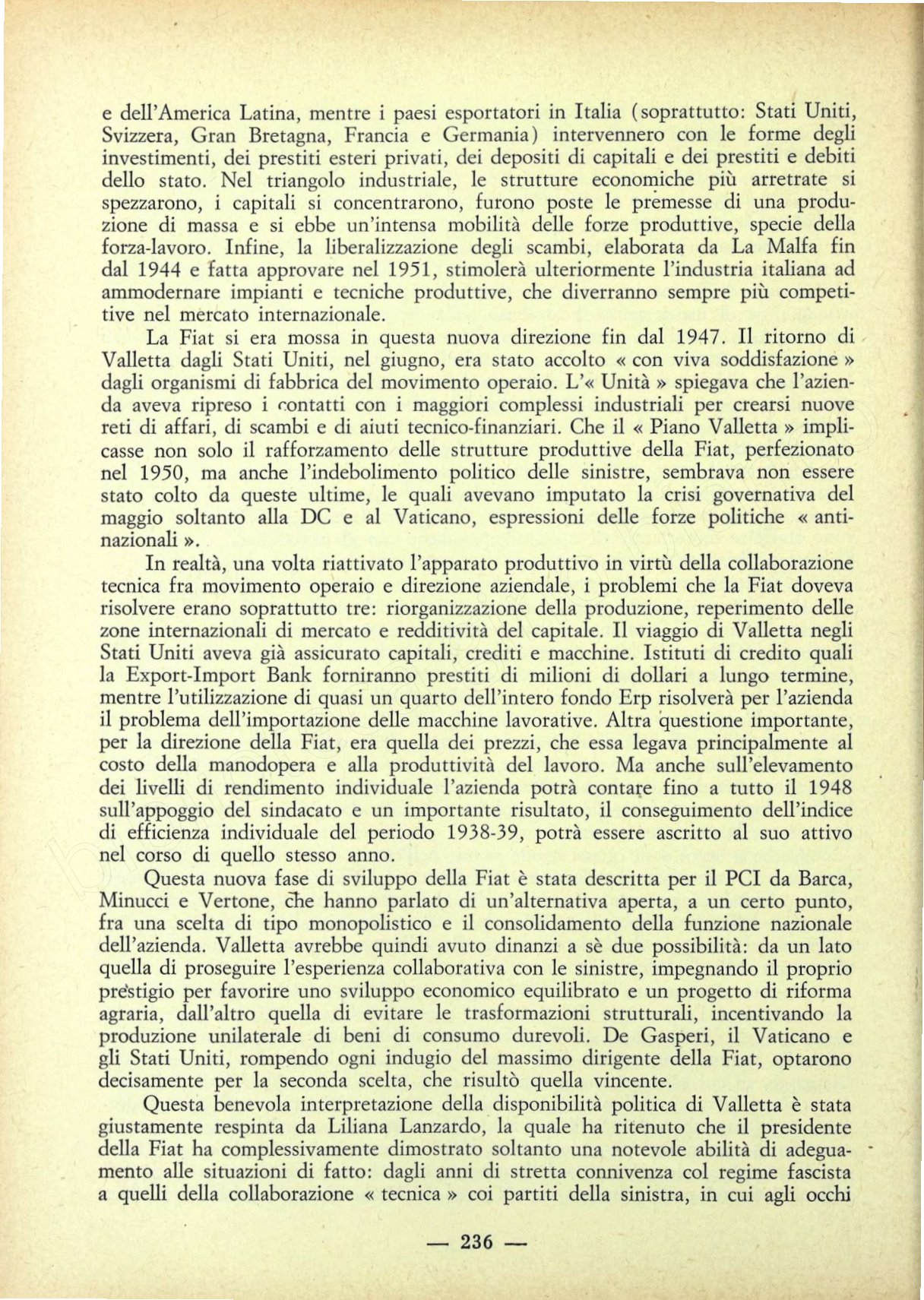
edell'America Latina, mentre i paesi esportatori in Italia ( soprattutto: Stati Uniti,
Svizzera, Gran Bretagna, Francia e Germania) intervennero con le forme degli
investimenti, dei prestiti esteri privati, dei depositi di capitali e dei prestiti e debiti
dello stato. Nel triangolo industriale, le strutture economiche più arretrate si
spezzarono, i capitali si concentrarono, furono poste le premesse di una produ-
zione di massa e si ebbe un'intensa mobilità delle forze produttive, specie della
forza-lavoro. Infine, la liberalizzazione degli scambi, elaborata da La Malfa f in
dal 1944 e fatta approvare nel 1951, stimolerà ulteriormente l'industria italiana ad
ammodernare impianti e tecniche produttive, che diverranno sempre più competi-
tive nel mercato internazionale.
La Fiat si era mossa in questa nuova direzione fin dal 1947. I l ritorno di
Valletta dagli Stati Uniti, nel giugno, era stato accolto « con viva soddisfazione »
dagli organismi di fabbrica del movimento operaio. L< Unità » spiegavache l'azien-
daaveva ripreso i contatti con i maggiori complessi industriali per crearsi nuove
reti di affari, di scambi e di aiuti tecnico-finanziari. Che il « Piano Valletta » impli-
cassenon solo i l rafforzamento delle strutture produttive della Fiat, perfezionato
nel 1950, ma anche l'indebolimento politico delle sinistre, sembrava non essere
stato colto da queste ultime, le quali avevano imputato la crisi governativa del
maggio soltanto alla DC e al Vaticano, espressioni delle forze politiche « anti-
nazionali ».
In realtà, una volta riattivato l'apparato produttivo in virtù della collaborazione
tecnica fra movimento operaio e direzione aziendale, i problemi che la Fiat doveva
risolvere erano soprattutto tre: riorganizzazione della produzione, reperimento delle
zone internazionali di mercato e redditività del capitale. I l viaggio di Valletta negli
Stati Uniti aveva già assicurato capitali, crediti e macchine. Istituti di credito quali
la Export-Import Bank forniranno prestiti di milioni di dollari a lungo termine,
mentre l'utilizzazione di quasi un quarto dell'intero fondo Erp risolverà per l'azienda
il problema dell'importazione dellemacchine lavorative. Altra 'questione importante,
per la direzione della Fiat, era quella dei prezzi, cheessa legava principalmente al
costo della manodopera e alla produttività del lavoro. Ma anche sull'elevamento
dei livelli di rendimento individuale l'azienda potrà contare fino a tutto i l 1948
sull'appoggio del sindacato e un importante risultato, i l conseguimento dell'indice
di efficienza individuale del periodo 1938-39, potrà essere ascritto al suo attivo
nel corso di quello stesso anno.
Questanuova fase di sviluppo della Fiat è stata descritta per il PCI da Barca,
Minucci e Vertone, Chehanno parlato di un'alternativa aperta, a un certo punto,
fra una scelta di tipo monopolistico e i l consolidamento della funzione nazionale
dell'azienda. Valletta avrebbe quindi avuto dinanzi a sè due possibilità, da un lato
quella di proseguire l'esperienza collaborativa con le sinistre, impegnando il proprio
prdstigio per favorire uno sviluppo economico equilibrato e un progetto di riforma
agraria, dall'altro quella di evitare le trasformazioni strutturali, incentivando la
produzione unilaterale di beni di consumo durevoli. De Gasperi, i l Vaticano e
gli Stati Uniti, rompendo ogni indugio del massimo dirigente della Fiat, optarono
decisamente per la seconda scelta, che risultò quella vincente.
Questabenevola interpretazione della disponibilità politica di Valletta è stata
giustamente respinta da Liliana Lanzardo, la quale ha ritenuto che i l presidente
della Fiat ha complessivamente dimostrato soltanto una notevole abilità di adegua-
mento alle situazioni di fatto: dagli anni di stretta connivenza col regime fascista
aquelli della collaborazione « tecnica » coi partiti della sinistra, in cui agli occhi
236
















