
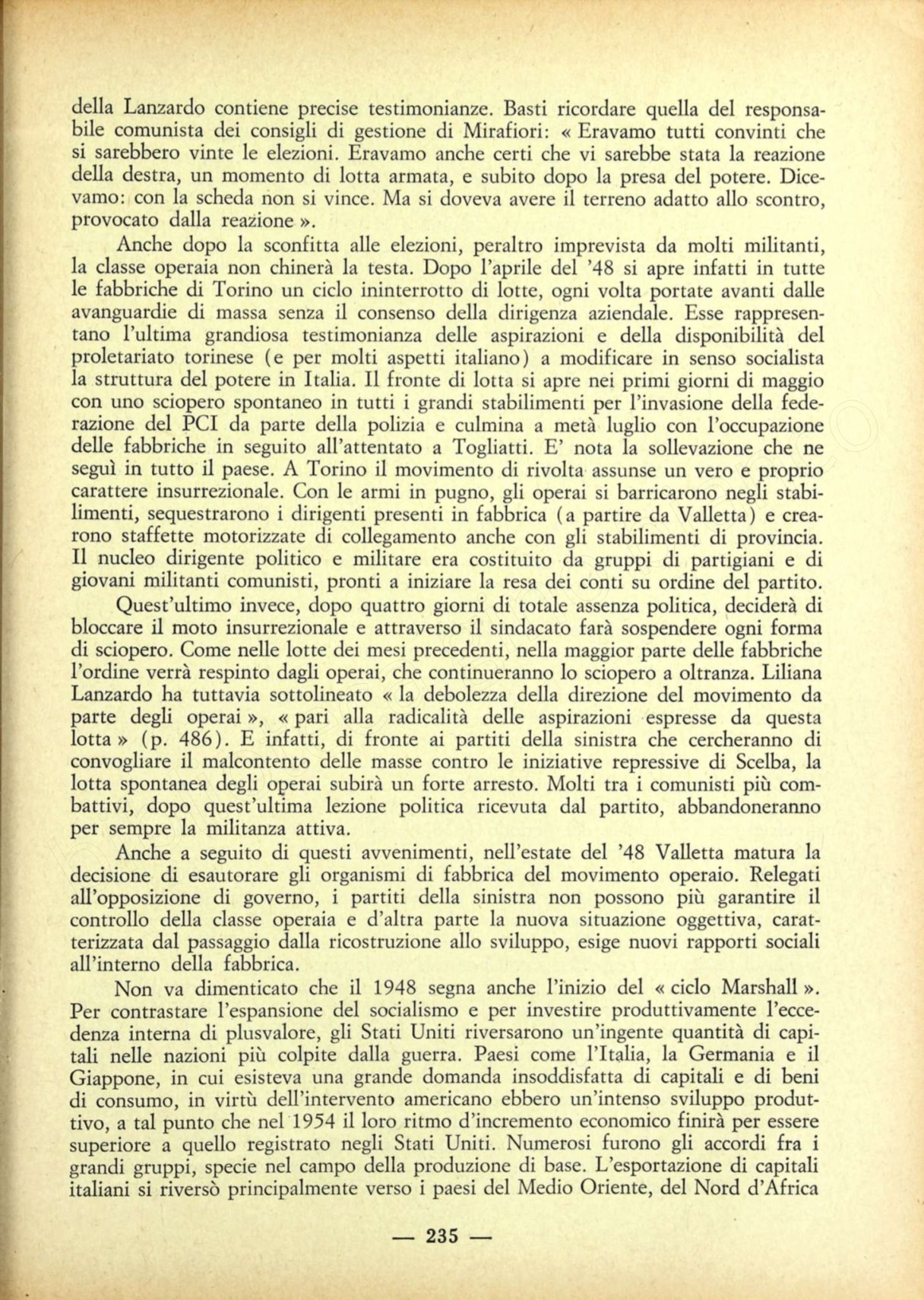
dellaLanzardocontieneprecisetestimonianze.Basti ricordarequella del responsa-
bilecomunistadei consigli di gestione di Mirafiori: « Eravamo tutti convinti che
sisarebberovinte le elezioni.Eravamoanchecerti che vi sarebbestata la reazione
delladestra, unmomentodi lottaarmata, e subitodopo lapresadel potere.Dice-
vamo:con laschedanonsi vince.Ma sidovevaavere il terrenoadattoalloscontro,
provocatodalla reazione».
Anchedopo la sconfittaalle elezioni, peraltro imprevista da molti militanti,
laclasseoperaianonchinerà la testa.Dopo l'aprile del '48 si apre infatti in tutte
lefabbriche di Torino unciclo ininterrotto di lotte, ogni voltaportateavanti dalle
avanguardie di massasenza il consensodelladirigenzaaziendale.Esserappresen-
tanol'ultima grandiosatestimonianzadelle aspirazioni e della disponibilità del
proletariatotorinese (e per molti aspetti italiano) a modificare insensosocialista
lastrutturadel potere in Italia. Il fronte di lotta si aprenei primi giorni dimaggio
conunoscioperospontaneo in tutti i grandistabilimenti per l'invasionedella fede-
razionedel PCI da parte della polizia e culmina a metà luglioconl'occupazione
dellefabbriche in seguitoall'attentato a Togliatti. E' nota la sollevazioneche ne
seguì in tutto il paese. A Torino il movimentodi rivoltaassunseunveroe proprio
carattereinsurrezionale.Con le armi inpugno, gli operai sibarricarononegli stabi-
limenti,sequestrarono i dirigentipresenti in fabbrica ( apartiredaValletta) e crea-
ronostaffettemotorizzate di collegamentoanchecon gli stabilimenti di provincia.
Il nucleodirigentepolitico e militare era costituito da gruppi di partigiani e di
giovanimilitanti comunisti,pronti a iniziare la resadei contisuordinedel partito.
Quest'ultimoinvece,dopoquattrogiorni di totaleassenzapolitica,decideràdi
bloccare il motoinsurrezionaleeattraverso il sindacatofaràsospendereogni forma
disciopero.Comenelle lottedeimesiprecedenti,nellamaggiorpartedellefabbriche
l'ordineverràrespintodaglioperai,checontinuerannoloscioperoaoltranza. Liliana
Lanzardoha tuttaviasottolineato « ladebolezzadelladirezionedelmovimentoda
partedegli operai », « pari alla radicalità delle aspirazioniespresse da questa
lotta» (p. 486). E infatti, di fronte ai partiti della sinistrachecercheranno di
convogliare il malcontentodellemassecontro le iniziativerepressive di Scelba, la
lottaspontaneadegli operaisubiràun fortearresto. Molti tra i comunistipiùcom-
battivi, dopoquest'ultima lezione politica ricevuta dal partito, abbandoneranno
persempre la militanza attiva.
Anchea seguito di questiavvenimenti,nell'estate del '48 Vallettamatura la
decisionedi esautorare gli organismi di fabbrica delmovimentooperaio.Relegati
all'opposizione di governo, i partiti della sinistra nonpossonopiù garantire i l
controllodellaclasseoperaia e d'altra parte la nuovasituazioneoggettiva, carat-
terizzatadalpassaggiodallaricostruzioneallosviluppo,esigenuovi rapportisociali
all'internodella fabbrica.
Nonva dimenticatoche il 1948segnaanche l'inizio del « cicloMarshall ».
Percontrastarel'espansionedel socialismo e per investireproduttivamentel'ecce-
denzainterna di plusvalore, gli Stati Uniti riversaronoun'ingentequantità di capi-
tali nelle nazioni più colpite dallaguerra. Paesicome l'Italia, la Germania e il
Giappone, in cui esistevaunagrandedomandainsoddisfatta di capitali e di beni
diconsumo, in virtù dell'interventoamericanoebberoun'intensosviluppoprodut-
tivo, a tal puntochenel 1954 il lororitmod'incrementoeconomicofiniràperessere
superiore a quelloregistratonegli Stati Uniti. Numerosi furono gli accordi fra i
grandigruppi,specienelcampodellaproduzionedi base.L'esportazione di capitali
italiani si riversòprincipalmenteverso i paesidelMedioOriente, del Nordd'Africa
235
















