
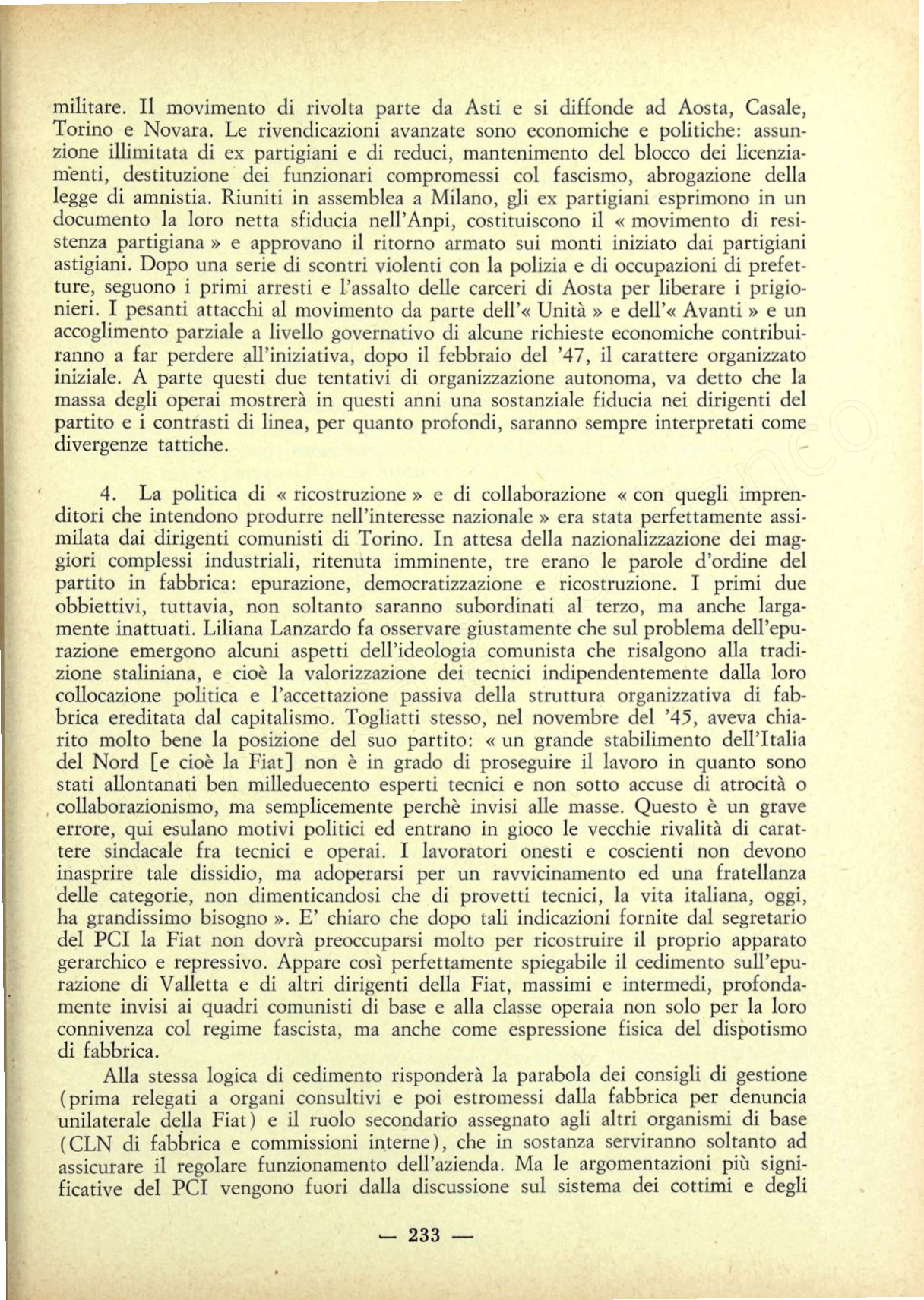
militare. I l movimento di rivolta parte da Asti e si diffonde ad Aosta, Casale,
Torino e Novara. Le rivendicazioni avanzate sonoeconomiche e politiche: assun-
zione illimitata di ex partigiani e di reduci, mantenimento del blocco dei licenzia-
destituzione dei funzionari compromessi col fascismo, abrogazione della
legge di amnistia. Riuniti in assembleaa Milano, gli ex partigiani esprimono in un
documento la loro netta sfiducia nell'Anpi, costituiscono i l « movimento di resi-
stenzapartigiana » e approvano i l ritorno armato sui monti iniziato dai partigiani
astigiani. Dopo una serie di scontri violenti con la polizia e di occupazioni di prefet-
ture, seguono i primi arresti e Passalto delle carceri di Aosta per liberare i prigio-
nieri. I pesanti attacchi al movimento da parte dell'« Unità » e dell'« Avanti » e un
accoglimentoparziale a livello governativo di alcune richiesteeconomiche contribui-
ranno a far perdere all'iniziativa, dopo i l febbraio del '47, i l carattere organizzato
iniziale. A parte questi due tentativi di organizzazioneautonoma, va detto che la
massadegli operai mostrerà in questi anni una sostanziale fiducia nei dirigenti del
partito e i contrasti di linea, per quanto profondi, sarannosempre interpretati come
divergenze tattiche.
4. L a politica di « ricostruzione » e di collaborazione « con quegli impren-
ditori che intendono produrre nell'interessenazionale»era stataperfettamenteassi-
milata dai dirigenti comunisti di Torino. In attesa della nazionalizzazione dei mag-
giori complessi industriali, ritenuta imminente, tre erano le parole d'ordine del
partito in fabbrica: epurazione, democratizzazione e ricostruzione. I primi due
obbiettivi, tuttavia, non soltanto saranno subordinati al terzo, ma anche larga-
mente inattuati. Liliana Lanzardo faosservaregiustamentechesul problemadell'epu-
razioneemergono alcuni aspetti dell'ideologia comunista che risalgono alla tradi-
zione staliniana, e cioè la valorizzazione dei tecnici indipendentemente dalla loro
collocazione politica e l'accettazione passiva della struttura organizzativa di fab-
brica ereditata dal capitalismo. Togliatti stesso, nel novembre del '45, aveva chia-
rito molto bene la posizione del suo partito: « un grande stabilimento dell'Italia
del Nord [e cioè la Fiat] non è in grado di proseguire i l lavoro in quanto sono
stati allontanati benmilleduecento esperti tecnici e non sottoaccuse di atrocità o
collaborazionismo, ma semplicementeperchè invisi allemasse.Questo è un grave
errore, qui esulano motivi politici ed entrano in gioco le vecchie rivalità di carat-
tere sindacale fra tecnici e operai. I lavoratori onesti e coscienti non devono
inasprire tale dissidio, ma adoperarsi per un ravvicinamento ed una fratellanza
delle categorie, non dimenticandosi che di provetti tecnici, la vita italiana, oggi,
hagrandissimobisogno ». E' chiaro che dopo tali indicazioni fornite dal segretario
del PCI la Fiat non dovrà preoccuparsi molto per ricostruire i l proprio apparato
gerarchico e repressivo.Appare cosi perfettamente spiegabile il cedimento sull'epu-
razione di Valletta e di altri dirigenti della Fiat, massimi e intermedi, profonda-
mente invisi ai quadri comunisti di base e alla classeoperaia non solo per la loro
connivenza col regime fascista, ma anche comeespressione fisica del disPotismo
di fabbrica.
Alla stessa logica di cedimento risponderà la parabola dei consigli di gestione
(prima relegati a organi consultivi e poi estromessi dalla fabbrica per denuncia
unilaterale della Fiat) e i l ruolo secondarioassegnato agli altri organismi di base
(CLN di fabbrica e commissioni interne), che in sostanzaserviranno soltanto ad
assicurare i l regolare funzionamento dell'azienda. Ma le argomentazioni più signi-
ficative del PCI vengono fuori dalla discussione sul sistema dei cottimi e degli
233
















