
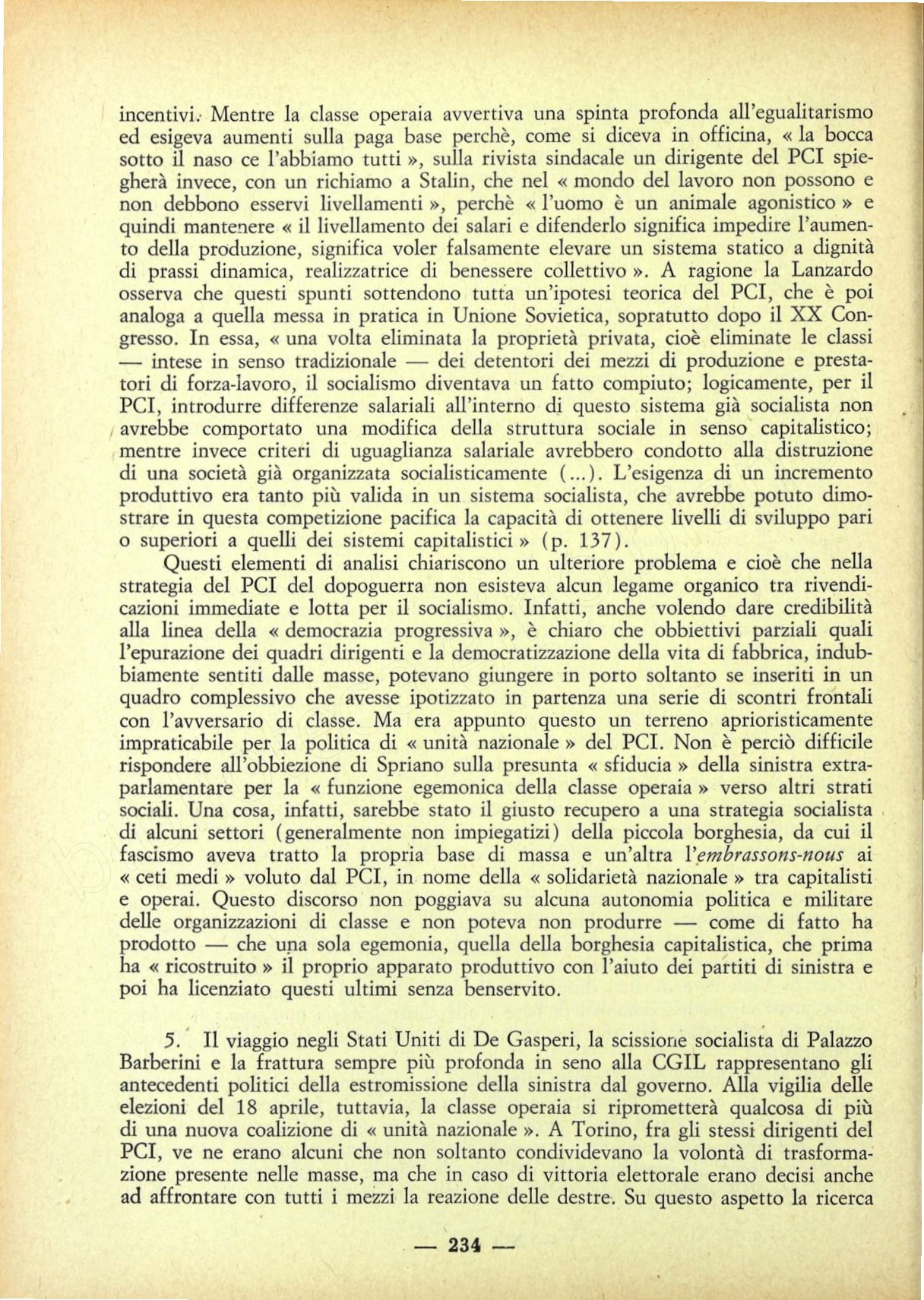
incentivi: Mentre la classe operaia avvertiva una spinta profonda all'egualitarismo
edesigeva aumenti sulla paga base perchè, come si diceva in officina, « la bocca
sotto i l naso ce l'abbiamo tutti », sulla rivista sindacale un dirigente del PCI spie-
gherà invece, con un richiamo a Stalin, che nel « mondo del lavoro non possono e
non debbono esservi livellamenti », perchè « l'uomo è un animale agonistico » e
quindi mantenere « il livellamento dei salari e difenderlo significa impedire l'aumen-
to della produzione, significa voler falsamente elevare un sistema statico a dignità
di prassi dinamica, realizzatrice di benessere collettivo ». A ragione la Lanzardo
osserva che questi spunti sottendono tutta un'ipotesi teorica del PCI, che è poi
analoga a quellamessa in pratica in Unione Sovietica, sopratutto dopo i l XX Con-
gresso. In essa, « una volta eliminata la proprietà privata, cioè eliminate le classi
intese in senso tradizionale — dei detentori dei mezzi di produzione e presta-
tori di forza-lavoro, i l socialismo diventava un fatto compiuto; logicamente, per i l
PCI, introdurre differenze salariali all'interno di questo sistema già socialista non
avrebbe comportato una modifica della struttura sociale in senso capitalistico;
mentre invece criteri di uguaglianza salariale avrebbero condotto alla distruzione
di una società già organizzata socialisticamente ( ...). L'esigenza di un incremento
produttivo era tanto più valida in un sistema socialista, che avrebbe potuto dimo-
strare in questa competizione pacifica la capacità di ottenere livelli di sviluppo pari
osuperiori a quelli dei sistemi capitalistici » ( p. 137).
•Questi elementi di analisi chiariscono un ulteriore problema e cioè che nella
strategia del PCI del dopoguerra non esisteva alcun legame organico tra rivendi-
cazioni immediate e lotta per i l socialismo. Infatti, anche volendo dare credibilità
alla linea della « democrazia progressiva », è chiaro che obbiettivi parziali quali
l'epurazione dei quadri dirigenti e la democratizzazione della vita di fabbrica, indub-
biamente sentiti dallemasse, potevano giungere in porto soltanto se inseriti in un
quadrocomplessivo che avesse ipotizzato in partenza una serie di scontri frontali
con l'avversario di classe. Ma era appunto questo un terreno aprioristicamente
impraticabile per la politica di « unità nazionale » del PCI. Non è perciò difficile
rispondere all'obbiezione di Spriano sulla presunta « sfiducia » della sinistra extra-
parlamentare per la « funzione egemonica della classe operaia » verso altri strati
sociali. Una cosa, infatti, sarebbe stato i l giusto recupero a una strategia socialista
di alcuni settori ( generalmente non impiegatizi) della piccola borghesia, da cui i l
fascismo aveva tratto la propria base di massa e un'altra
P.embrassons-nous
ai
«ceti medi » voluto dal PCI, in nome della « solidarietà nazionale » tra capitalisti
eoperai. Questo discorso non poggiava su alcuna autonomia politica e militare
delle organizzazioni di classe e non poteva non produrre — come di fatto ha
prodotto — che una sola egemonia, quella della borghesia capitalistica, che prima
ha< ricostruito » i l proprio apparato produttivo con l'aiuto dei partiti di sinistra e
poi ha licenziato questi ultimi senza benservito.
5. I l viaggio negli Stati Uniti di De Gasperi, la scissione socialista di Palazzo
Barberini e la frattura sempre più profonda in seno alla CGIL rappresentano gli
antecedenti politici della estromissione della sinistra dal governo. Alla vigilia delle
elezioni del 18 aprile, tuttavia, la classe operaia si riprometterà qualcosa di più
di una nuova coalizione di « unità nazionale ». A Torino, fra gli stessi dirigenti del
PCI, ve ne erano alcuni che non soltanto condividevano la volontà di trasforma-
zionepresente nellemasse,ma che in caso di vittoria elettorale erano decisi anche
adaffrontare con tutti i mezzi la reazione delle destre. Su questo aspetto la ricerca
234 - -
















