
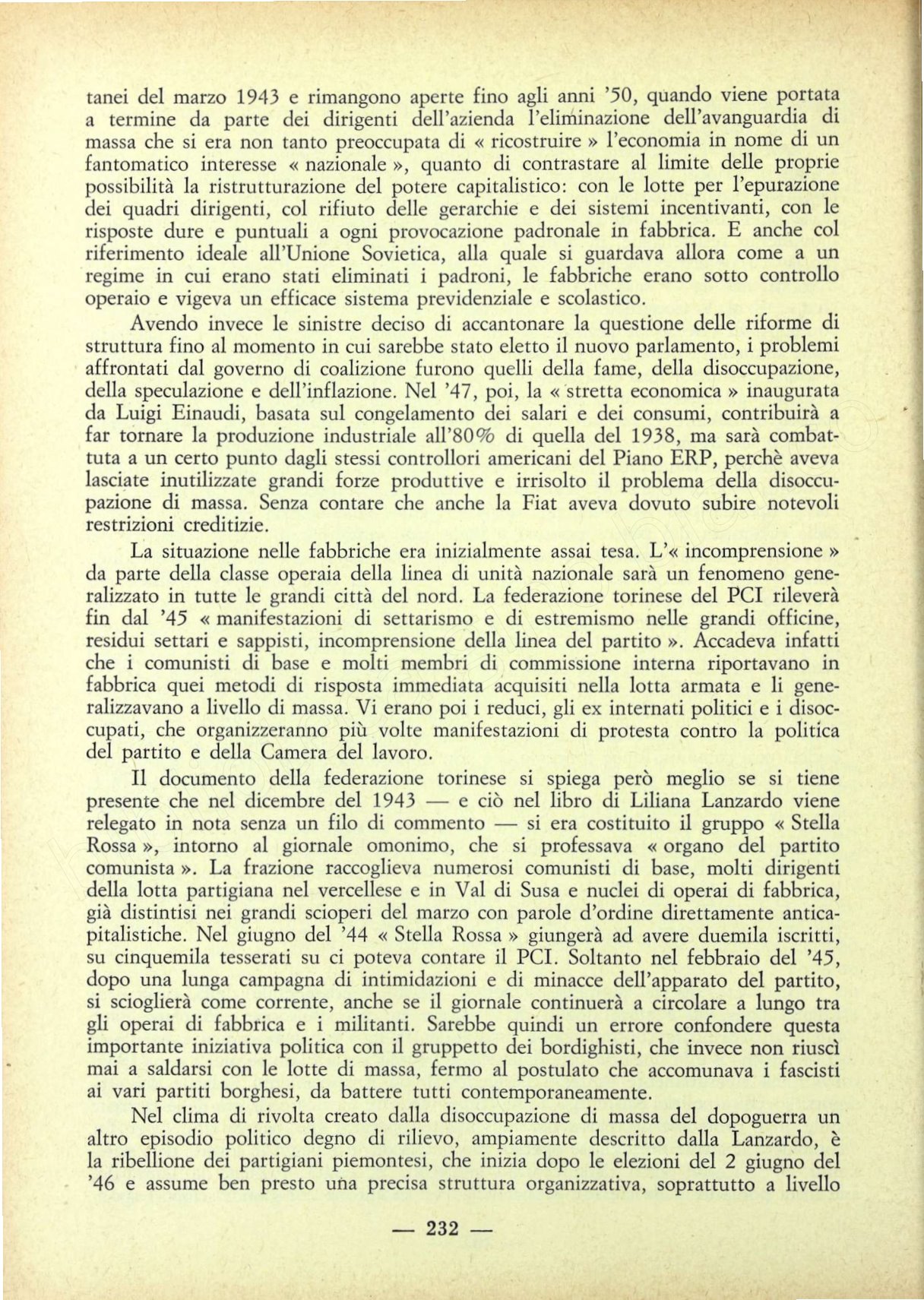
tanei del marzo 1943 e rimangono aperte fino agli anni '50, quando viene portata
atermine da parte dei dirigenti dell'azienda l'eliniinazione dell'avanguardia d i
massache si era non tanto preoccupata di « ricostruire » l'economia in nome di un
fantomatico interesse « nazionale», quanto di contrastare al limite delle proprie
possibilità la ristrutturazione del potere capitalistico: con le lotte per l'epurazione
dei quadri dirigenti, col rifiuto delle gerarchie e dei sistemi incentivanti, con le
risposte dure e puntuali a ogni provocazione padronale in fabbrica. E anche col
riferimento ideale all'Unione Sovietica, alla quale si guardava allora come a un
regime in cui erano stati eliminati i padroni, le fabbriche erano sotto controllo
operaioe vigeva un efficacesistemaprevidenziale e scolastico.
Avendo invece le sinistre deciso di accantonare la questione delle riforme di
struttura fino al momento in cui sarebbestato eletto il nuovoparlamento, i problemi
affrontati dal governo di coalizione furono quelli della fame, della disoccupazione,
dellaspeculazionee dell'inflazione. Nel '47, poi, la « strettaeconomica» inaugurata
da Luigi Einaudi, basata sul congelamento dei salari e dei consumi, contribuirà a
far tornare la produzione industriale all'80% di quella del 1938, ma sarà combat-
tuta a un certo punto dagli stessi controllori americani del Piano ERP, perchèaveva
lasciate inutilizzate grandi forze produttive e irrisolto i l problema della disoccu-
pazione di massa.Senza contare che anche la Fiat aveva dovuto subire notevoli
restrizioni creditizie.
Lasituazione nelle fabbriche era inizialmente assai tesa. L'« incomprensione»
daparte della classeoperaia della linea di unità nazionalesarà un fenomenogene-
ralizzato in tutte le grandi città del nord. La federazione torinese del PCI rileverà
fin dal '45 « manifestazioni di settarismo e di estremismo nelle grandi officine,
residui settari e sappisti, incomprensione della linea del partito ».Accadeva infatti
che i comunisti ch base e molti membri di commissione interna riportavano in
fabbrica quei metodi di risposta immediata acquisiti nella lotta armata e l i gene-
ralizzavanoa livello di massa. Vi erano poi i reduci, gli ex internati politici e i disoc-
cupati, che organizzeranno più volte manifestazioni di protesta contro la politica
del partito e dellaCamera del lavoro.
Il documento della federazione torinese si spiega però meglio se si tiene
presenteche nel dicembre del 1943 — e ciò nel libro di Liliana Lanzardo viene
relegato in nota senza un filo di commento — si era costituito i l gruppo « Stella
Rossa», intorno al giornale omonimo, che si professava « organo del partito
comunista». La frazione raccoglieva numerosi comunisti di base, molti dirigenti
della lotta partigiana nel vercellese e in Val di Susa e nuclei di operai di fabbrica,
già distintisi nei grandi scioperi del marzo con parole d'ordine direttamente antica-
pitalistiche. Nel giugno del '44 « StellaRossa»giungerà ad avere duemila iscritti,
sucinquemila tesserati su ci poteva contare i l PCI. Soltanto nel febbraio del '45,
dopouna lungacampagna di intimidazioni e di minacce dell'apparato del partito,
si scioglierà come corrente, anchese i l giornale continuerà a circolare a lungo tra
gli operai di fabbrica e i militanti. Sarebbe quindi un errore confondere questa
importante iniziativa politica con il gruppetto dei bordighisti, che invece non riuscì
mai a saldarsi con le lotte di massa, fermo al postulato cheaccomunava i fascisti
ai vari partiti borghesi, da battere tutti contemporaneamente.
Nel clima di rivolta creato dalla disoccupazione di massa del dopoguerra un
altro episodio politico degno di rilievo, ampiamente descritto dalla Lanzardo, è
la ribellione dei partigiani piemontesi, che inizia dopo le elezioni del 2 giugno del
'46 e assumeben presto utia precisa struttura organizzativa, soprattutto a livello
232
















