
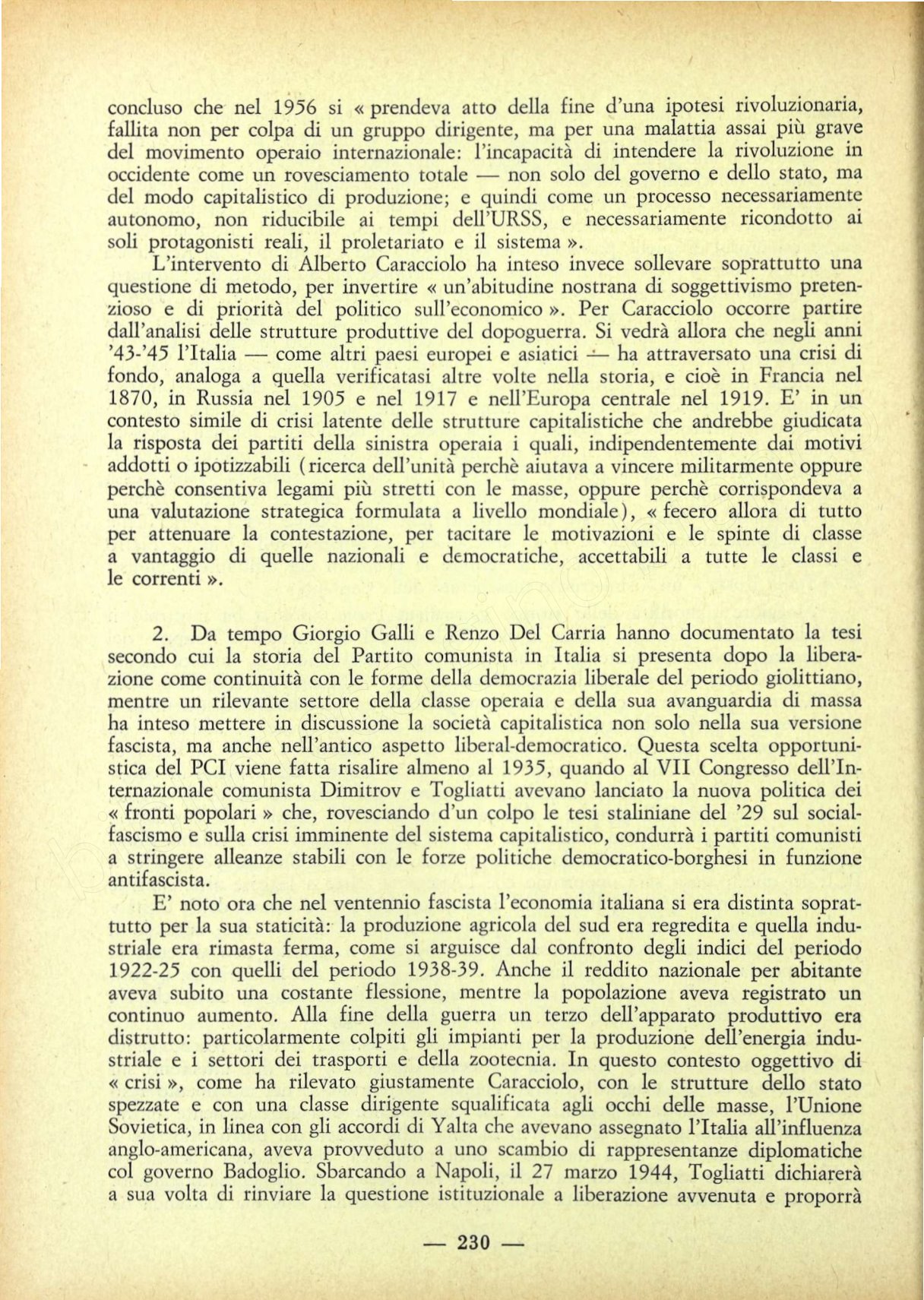
concluso che nel 1956 si « prendeva atto della fine d'una ipotesi rivoluzionaria,
fallita non per colpa di un gruppo dirigente, ma per una malattia assai più grave
del movimento operaio internazionale: l'incapacità di intendere la rivoluzione in
occidentecome un rovesciamento totale — non solo del governo e dello stato, ma
del modo capitalistico di produzione; e quindi come un processonecessariamente
autonomo, non riducibile ai tempi dell'URSS, e necessariamente ricondotto ai
soli protagonisti reali, i l proletariato e i l sistema ».
L'intervento di Alberto Caracciolo ha inteso invece sollevare soprattutto una
questione di metodo, per invertire « un'abitudine nostrana di soggettivismo preten-
zioso e di priorità del politico sull'economico ». Per Caracciolo occorre partire
dall'analisi delle strutture produttive del dopoguerra. Si vedrà allora che negli anni
'43-'45 l'Italia — come altri paesi europei e asiatici h a attraversato una crisi di
fondo, analoga a quella verificatasi altre volte nella storia, e cioè in Francia nel
1870, in Russia nel 1905 e nel 1917 e nell'Europa centrale nel 1919. E' in un
contesto simile di crisi latente delle strutture capitalistiche che andrebbe giudicata
la risposta dei partiti della sinistra operaia i quali, indipendentemente dai motivi
addotti o ipotizzabili (ricerca dell'unità perchè aiutava a vincere militarmente oppure
perchèconsentiva legami più stretti con le masse, oppure perchè corrispondeva a
una valutazione strategica formulata a livello mondiale), « fecero allora di tutto
per attenuare la contestazione, per tacitare le motivazioni e le spinte di classe
avantaggio d i quelle nazionali e democratiche, accettabili a tutte le classi e
le correnti ».
2. D a tempo Giorgio Galli e Renzo Del Carria hanno documentato la tesi
secondo cui la storia del Partito comunista in Italia si presenta dopo la libera-
zionecome continuità con le forme della democrazia liberale del periodo giolittiano,
mentre un rilevante settore della classe operaia e della sua avanguardia di massa
ha inteso mettere in discussione la società capitalistica non solo nella sua versione
fascista, ma anche nell'antico aspetto liberai-democratico. Questa scelta opportuni-
stica del PCI viene fatta risalire almeno al 1935, quando al VI I Congresso dell'In-
ternazionale comunista Dimitrov e Togliatti avevano lanciato la nuova politica dei
« fronti popolari » che, rovesciando d'un colpo le tesi staliniane del '29 sul social-
fascismoe sulla crisi imminente del sistema capitalistico, condurrà i partiti comunisti
astringere alleanze stabili con le forze politiche democratico-borghesi in funzione
antifascista.
E' noto ora che nel ventennio fascista l'economia italiana si era distinta soprat-
tutto per la sua staticità: la produzione agricola del sud era regredita e quella indu-
striale era rimasta ferma, come si arguisce dal confronto degli indici del periodo
1922-25 con quelli del periodo 1938-39. Anche i l reddito nazionale per abitante
aveva subito una costante flessione, mentre la popolazione aveva registrato un
continuo aumento. Al la fine della guerra un terzo dell'apparato produttivo era
distrutto: particolarmente colpiti gli impianti per la produzione dell'energia indu-
striale e i settori dei trasporti e della zootecnia. In questo contesto oggettivo di
«crisi », come ha rilevato giustamente Caracciolo, con le strutture dello stato
spezzate e con una classe dirigente squalificata agli occhi delle masse, l'Unione
Sovietica, in linea con gli accordi di Yalta cheavevanoassegnato l'Italia all'influenza
anglo-americana, aveva provveduto a uno scambio di rappresentanze diplomatiche
col governo Badoglio. Sbarcando a Napoli, i l 27 marzo 1944, Togliatti dichiarerà
asua volta di rinviare la questione istituzionale a liberazione avvenuta e proporrà
230
















