
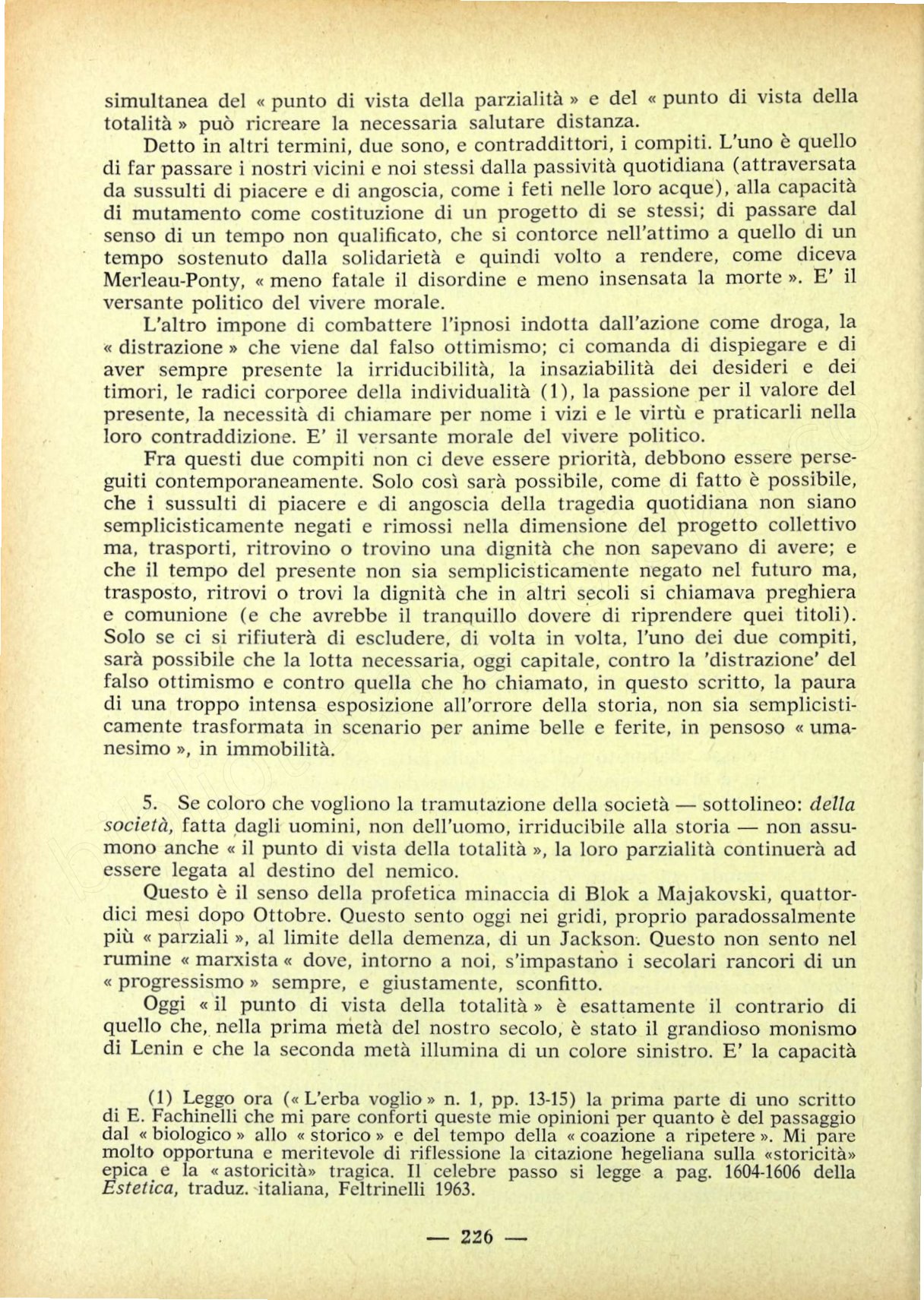
simultanea del « punto di vista della parzialità » e del « punto di vista della
totalità » può ricreare la necessaria salutare distanza.
Detto in altri termini, due sono, e contraddittori, i compiti. L'uno è quello
di far passare i nostri vicini e noi stessi dalla passività quotidiana (attraversata
da sussulti di piacere e di angoscia, come i feti nelle loro acque), alla capacità
di mutamento come costituzione di un progetto di se stessi; di passare dal
senso di un tempo non qualificato, che si contorce nell'attimo a quello di un
tempo sostenuto dalla solidarietà e quindi volto a rendere, come diceva
Merleau-Ponty, « meno fatale i l disordine e meno insensata la morte ». E' i l
versante politico del vivere morale.
L'altro impone di combattere l'ipnosi indotta dall'azione come droga, la
distrazione » che viene dal falso ottimismo; ci comanda di dispiegare e di
aver sempre presente l a irriducibilità, l a insaziabilità dei desideri e dei
timori, le radici corporee della individualità (1), la passione per il valore del
presente, la necessità di chiamare per nome i vizi e le virtù e praticarli nella
loro contraddizione. E' i l versante morale del vivere politico.
Fra questi due compiti non ci deve essere priorità, debbono essere perse-
guiti contemporaneamente. Solo così sarà possibile, come di fatto è possibile,
che i sussulti di piacere e di angoscia della tragedia quotidiana non siano
semplicisticamente negati e rimossi nella dimensione del progetto collettivo
ma, trasporti, ritrovino o trovino una dignità che non sapevano di avere; e
che i l tempo del presente non sia semplicisticamente negato nel futuro ma,
trasposto, ritrovi o trovi la dignità che in altri secoli si chiamava preghiera
e comunione (e che avrebbe i l tranquillo dovere di riprendere quei titoli).
Solo se ci si rifiuterà di escludere, di volta in volta, l'uno dei due compiti,
sarà possibile che la lotta necessaria, oggi capitale, contro la 'distrazione' del
falso ottimismo e contro quella che ho chiamato, in questo scritto, la paura
di una troppo intensa esposizione all'orrore della storia, non sia semplicisti-
camente trasformata in scenario per anime belle e ferite, in pensoso « uma-
nesimo », in immobilità.
5. S e coloro che vogliono la tramutazione della società sottol ineo:
della
società, fatta
dagli uomini, non dell'uomo, irriducibile alla storia — non assu-
mono anche « il punto di vista della totalità », la loro parzialità continuerà ad
essere legata al destino del nemico.
Questo è il senso della profetica minaccia di Blok a Majakovski, quattor-
dici mesi dopo Ottobre. Questo sento oggi nei gridi, proprio paradossalmente
più « parziali », al limite della demenza, di un Jackson. Questo non sento nel
rumine « marxista « dove, intorno a noi, s'impastario i secolari rancori di un
«progressismo » sempre, e giustamente, sconfitto.
Oggi « il punto di vista della totalità » è esattamente i l contrario d i
quello che, nella prima Metà del nostro secolo, è stato il grandioso monismo
di Lenin e che la seconda metà illumina di un colore sinistro. E' la capacità
(1) Leggo ora (« L'erba voglio» n. 1, pp. 13-15) la prima parte di uno scritto
di E. Fachinelli che mi pare conforti questemie opinioni per quanto è del passaggio
dal « biologico» allo « storico» e del tempo della «coazione a ripetere ». Mi pare
molto opportuna e meritevole di riflessione la citazione hegeliana sulla «storicità»
epica e la « astoricità» tragica. I l celebre passo si legge a pag. 1604-1606 della
Estetica,
traduz. F e l t r i n e l l i 1963.
226
















