
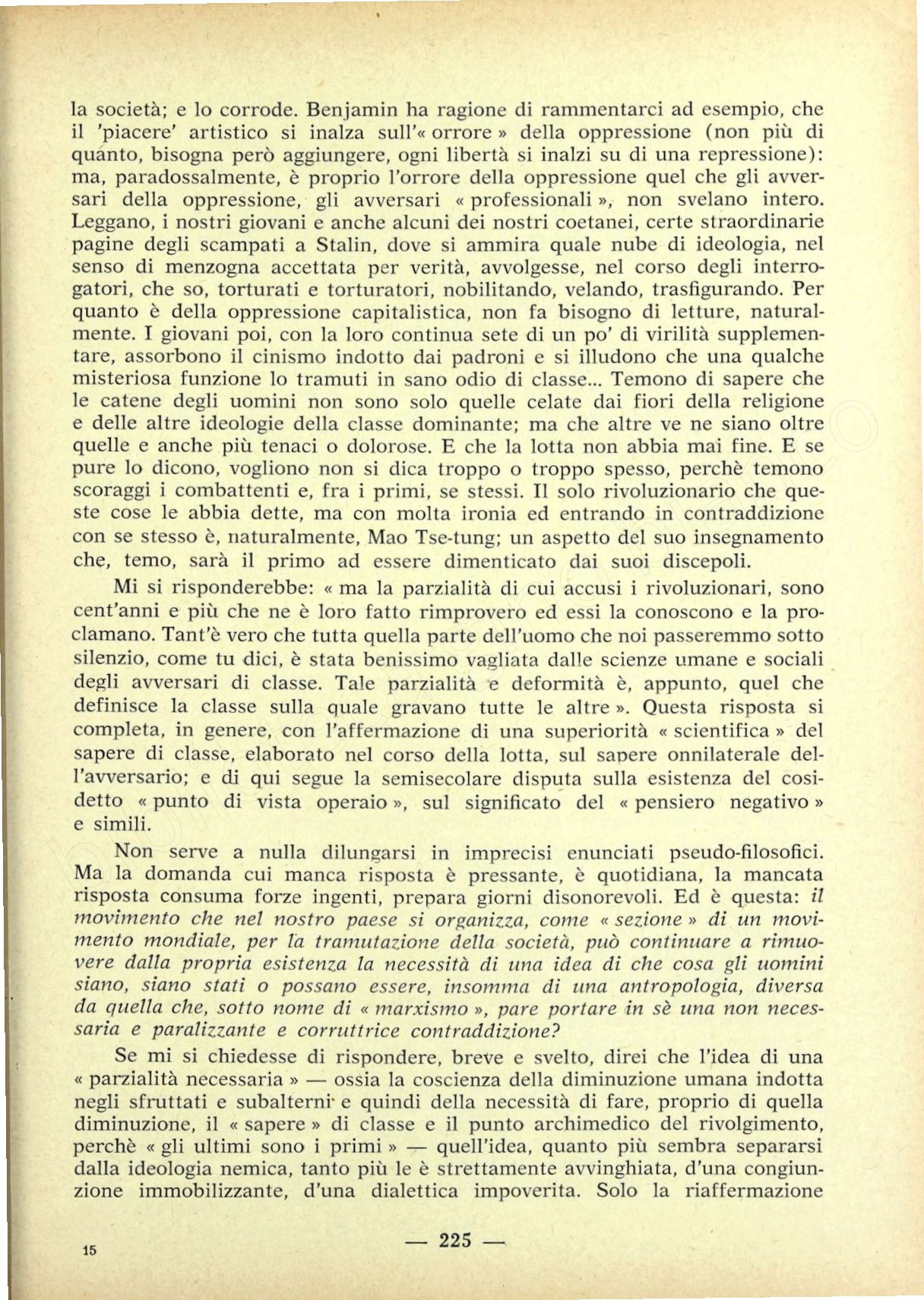
la società; e lo corrode. Benjamin ha ragione di rammentarci ad esempio, che
il 'piacere' artistico si inalza sull'« orrore » della oppressione (non più d i
quanto, bisogna però aggiungere, ogni libertà si inalzi su di una repressione):
ma, paradossalmente, è proprio l'orrore della oppressione quel che gli avver-
sari del la oppressione, gl i avversari « professionali », non svelano intero.
Leggano, i nostri giovani e anche alcuni dei nostri coetanei, certe straordinarie
pagine degli scampati a Stalin, dove si ammira quale nube di ideologia, nel
senso di menzogna accettata per verità, avvolgesse, nel corso degli interro-
gatori, che so, torturati e torturatori, nobilitando, velando, trasfigurando. Per
quanto è della oppressione capitalistica, non fa bisogno di letture, natural-
mente. I giovani poi, con la loro continua sete di un po' di virilità supplemen-
tare, assorbono i l cinismo indotto dai padroni e si illudono che una qualche
misteriosa funzione lo tramuti in sano odio di classe... Temono di sapere che
le catene degli uomini non sono solo quelle celate dai fiori della religione
e delle altre ideologie della classe dominante; ma che altre ve ne siano oltre
quelle e anche più tenaci o dolorose. E che la lotta non abbia mai fine. E se
pure lo dicono, vogliono non si dica troppo o troppo spesso, perchè temono
scoraggi i combattenti e, fra i primi, se stessi. I l solo rivoluzionario che que-
ste cose le abbia dette, ma con molta ironia ed entrando in contraddizione
con se stesso è, naturalmente, Mao Tse-tung; un aspetto del suo insegnamento
che, temo, sarà i l primo ad essere dimenticato dai suoi discepoli.
Mi si risponderebbe: «ma la parzialità di cui accusi i rivoluzionari, sono
cent'anni e più che ne è loro fatto rimprovero ed essi la conoscono e la pro-
clamano. Tant'è vero che tutta quella parte dell'uomo che noi passeremmo sotto
silenzio, come tu dici, è stata benissimo vagliata dalle scienze umane e sociali
degli avversari d i classe. Tale parzialità e deformità è, appunto, quel che
definisce l a classe sulla quale gravano tutte l e altre ». Questa risposta si
completa, in genere, con l'affermazione di una superiorità « scientifica » del
sapere di classe, elaborato nel corso della lotta, sul sapere onnilaterale del-
l'avversario; e di qui segue la semisecolare disputa sulla esistenza del cosi-
detto « punto d i vista operaio », sul significato de l «pensiero negativo »
e simili.
Non serve a nul la dilungarsi i n imprecisi enunciati pseudo-filosofici.
Ma l a domanda cui manca risposta è pressante, è quotidiana, l a mancata
risposta consuma forze ingenti, prepara giorni disonorevoli. Ed è questa:
i l
movimento che nel nostro paese si organizza, come « sezione » d i un movi-
mento mondiale, per la tramutazione della società, può continuare a rimuo-
vere dalla propria esistenza la necessità di una idea di che cosa gli uomini
siano, siano stati o possano essere, insomma d i una antropologia, diversa
da quella che, sotto nome di « marxismo », pare portare in sè una non neces-
saria e paralizzante e corruttrice contraddizione?
Se mi si chiedesse di rispondere, breve e svelto, direi che l'idea di una
«parzialità necessaria » — ossia la coscienza della diminuzione umana indotta
negli sfruttati e subalterni•e quindi della necessità di fare, proprio di quella
diminuzione, i l « sapere » di classe e i l punto archimedico del rivolgimento,
perchè « gli ultimi sono i primi » — quell'idea, quanto più sembra separarsi
dalla ideologia nemica, tanto più le è strettamente avvinghiata, d'una congiun-
zione immobilizzante, d'una dialettica impoverita. Solo l a riaffermazione
15
225
















