
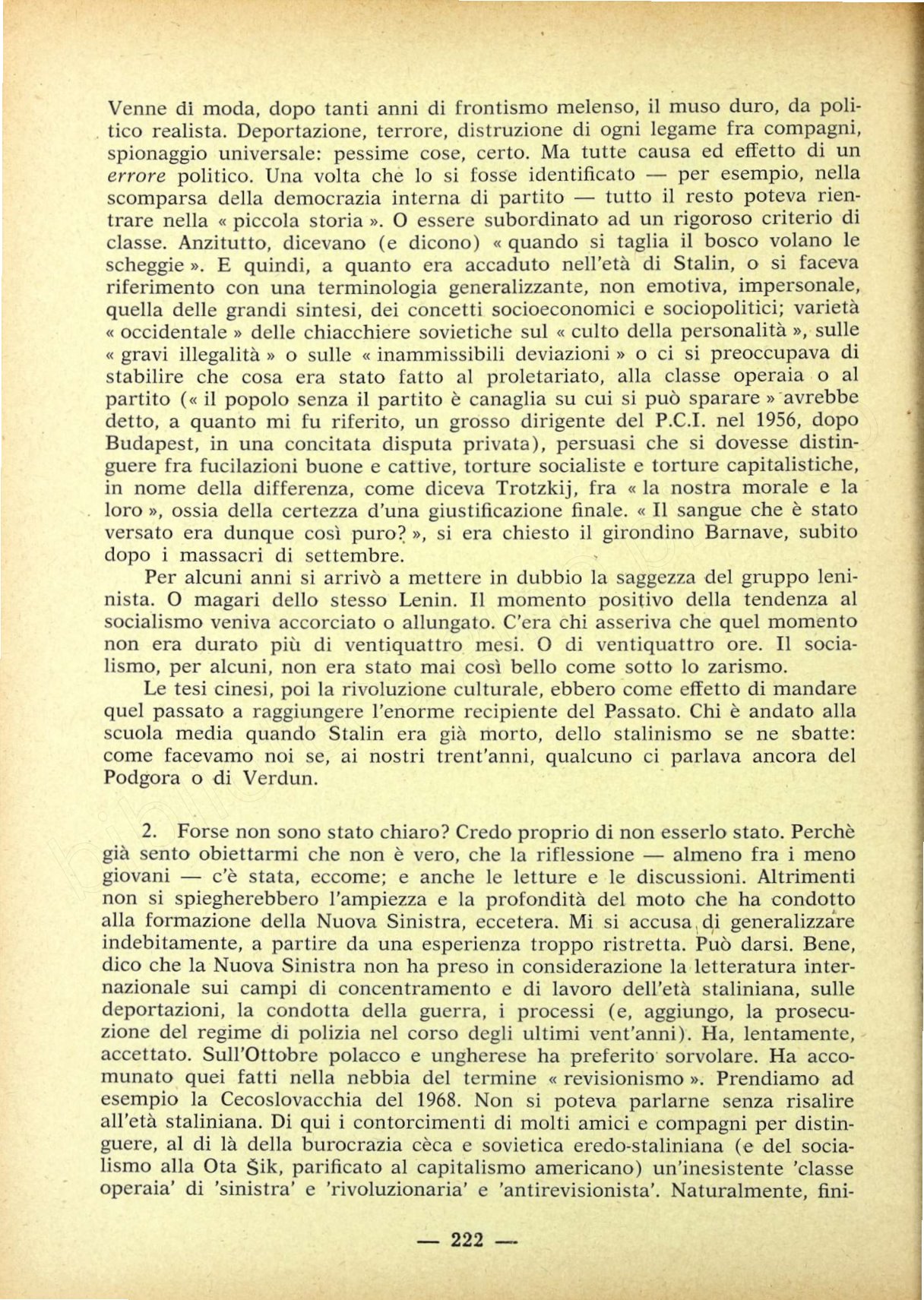
Venne dì moda, dopo tanti anni di frontismo melenso, i l muso duro, da poli-
tico realista. Deportazione, terrore, distruzione di ogni legame fra compagni,
spionaggio universale: pessime cose, certo. Ma tutte causa ed effetto di un
errore
politico. Una volta che lo si fosse identificato — per esempio, nella
scomparsa della democrazia interna di partito — tutto i l resto poteva rien-
trare nella « piccola storia ». O essere subordinato ad un rigoroso criterio di
classe. Anzitutto, dicevano ( e dicono) «quando si taglia i l bosco volano le
scheggie ». E quindi, a quanto era accaduto nell'età d i Stalin, o si faceva
riferimento con una terminologia generalizzante, non emotiva, impersonale,
quella delle grandi sintesi, dei concetti socioeconomici e sociopolitici; varietà
«occidentale » delle chiacchiere sovietiche sul « culto della personalità », sulle
«gravi illegalità » o sulle « inammissibili deviazioni » o ci si preoccupava di
stabilire che cosa era stato fatto a l proletariato, al la classe operaia o a l
partito (« il popolo senza il partito è canaglia su cui si può sparare » -avrebbe
detto, a quanto mi fu riferito, un grosso dirigente del P.C.I. nel 1956, dopo
Budapest, in una concitata disputa privata), persuasi che si dovesse distin-
guere fra fucilazioni buone e cattive, torture socialiste e torture capitalistiche,
in nome della differenza, come diceva Trotzkij, f ra « la nostra morale e la
loro », ossia della certezza d'una giustificazione finale. « I l sangue che è stato
versato era dunque così puro?. », si era chiesto i l girondino Barnave, subito
dopo i massacri di settembre.
Per alcuni anni si arrivò a mettere in dubbio la saggezza del gruppo leni-
nista. O magari dello stesso Lenin. I l momento positivo della tendenza a l
socialismo veniva accorciato o allungato. C'era chi asseriva che quel momento
non era durato più d i ventiquattro mesi. O d i ventiquattro ore. I l socia-
lismo, per alcuni, non era stato mai così bello come sotto lo zarismo.
Le tesi cinesi, poi la rivoluzione culturale, ebbero come effetto di mandare
quel passato a raggiungere l'enorme recipiente del Passato. Chi è andato alla
scuola media quando Stalin era già morto, dello stalinismo se ne sbatte:
come facevamo noi se, ai nostri trent'anni, qualcuno ci parlava ancora del
Podgora o di Verdun.
2. Forse non sono stato chiaro? Credo proprio di non esserlo stato. Perchè
già sento obiettarmi che non è vero, che la riflessione — almeno fra i meno
giovani — c'è stata, eccome; e anche le letture e le discussioni. Altrimenti
non si spiegherebbero l'ampiezza e la profondità del moto che ha condotto
alla formazione della Nuova Sinistra, eccetera. Mi si accusa; di generalizzare
indebitamente, a partire da una esperienza troppo ristretta. Può darsi. Bene,
dico che la Nuova Sinistra non ha preso in considerazione la letteratura inter-
nazionale sui campi di concentramento e di lavoro dell'età staliniana, sulle
deportazioni, l a condotta della guerra, i processi (e, aggiungo, l a prosecu-
zione del regime di polizia nel corso degli ultimi vent'anni). Ha, lentamente,
accettato. Sull'Ottobre polacco e ungherese ha preferito' sorvolare. Ha acco-
munato quei fatti nella nebbia del termine « revisionismo ». Prendiamo ad
esempio l a Cecoslovacchia del 1968. Non si poteva parlarne senza risalire
all'età staliniana. Di qui i contorcimenti di molti amici e compagni per distin-
guere, al di là della burocrazia cèca e sovietica eredo-staliniana (e del socia-
lismo alla Ota Sik, parificato al capitalismo americano) un'inesistente 'classe
operaia' di 'sinistra' e 'rivoluzionaria' e 'antirevisionista'. Naturalmente, fini-
222 —
















