
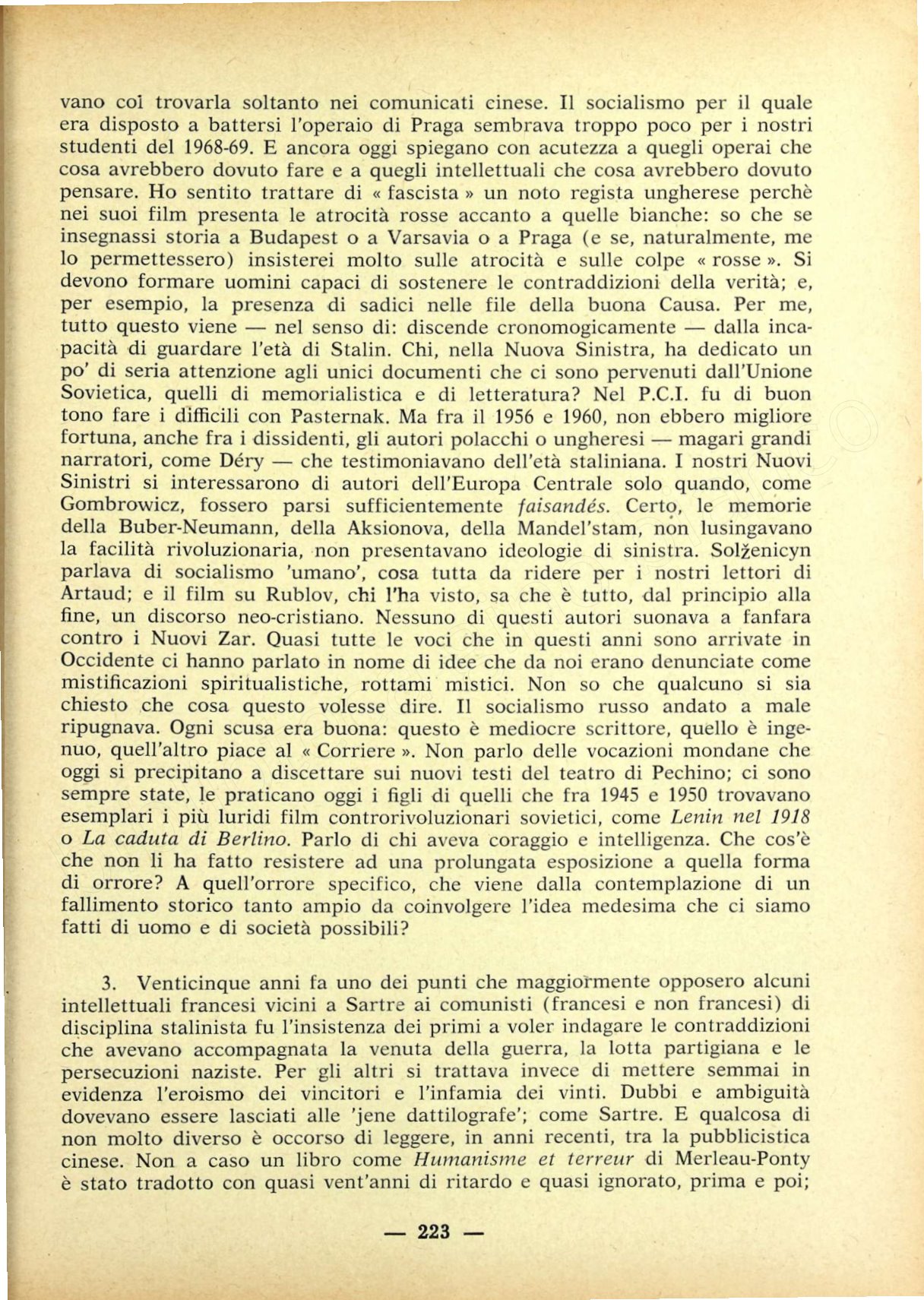
vano col trovarla soltanto nei comunicati cinese. I l socialismo per i l quale
era disposto a battersi l'operaio di Praga sembrava troppo poco per i nostri
studenti del 1968-69. E ancora oggi spiegano con acutezza a quegli operai che
cosa avrebbero dovuto fare e a quegli intellettuali che cosa avrebbero dovuto
pensare. Ho sentito trattare di «fascista » un noto regista ungherese perchè
nei suoi f i lm presenta le atrocità rosse accanto a quelle bianche: so che se
insegnassi storia a Budapest o a Varsavia o a Praga (e se, naturalmente, me
lo permettessero) insisterei molto sulle atrocità e sulle colpe « rosse ». Si
devono formare uomini capaci di sostenere le contraddizioni della verità; e,
per esempio, l a presenza d i sadici nelle f i le del la buona Causa. Per me,
tutto questo viene — nel senso di: discende cronomogicamente — dalla inca-
pacità di guardare l'età di Stalin. Chi, nella Nuova Sinistra, ha dedicato un
po' di seria attenzione agli unici documenti che ci sono pervenuti dall'Unione
Sovietica, quelli d i memorialistica e d i letteratura? Nel P.C.I. f u d i buon
tono fare i difficili con Pasternak. Ma fra i l 1956 e 1960, non ebbero migliore
fortuna, anche fra i dissidenti, gli autori polacchi o ungheresi — magari grandi
narratori, come Déry — che testimoniavano dell'età staliniana. I nostri Nuovi
Sinistri si interessarono di autori dell'Europa Centrale solo quando, come
Gombrowicz, fossero parsi sufficientemente
faisandés.
Certo, l e membrie
della Buber-Neumann, della Aksionova, della Mandel'stam, non lusingavano
la facilità rivoluzionaria, non presentavano ideologie di sinistra. Sollenicyn
parlava d i socialismo 'umano', cosa tutta da ridere per i nostri lettori d i
Artaud; e i l fi lm su Rublov, chi l'ha visto, sa che è tutto, dal principio alla
fine, un discorso neo-cristiano. Nessuno di questi autori suonava a fanfara
contro i Nuovi Zar. Quasi tutte le voci che in questi anni sono arrivate in
Occidente ci hanno parlato in nome di idee che da noi erano denunciate come
mistificazioni spiritualistiche, rottami mistici. Non so che qualcuno si sia
chiesto iche cosa questo volesse dire. I l socialismo russo andato a male
ripugnava. Ogni scusa era buona: questo è mediocre scrittore, quello è inge-
nuo, quell'altro piace al « Corriere ». Non parlo delle vocazioni mondane che
oggi si precipitano a discettare sui nuovi testi del teatro di Pechino; ci sono
sempre state, •le praticano oggi i figli di quelli che fra 1945 e 1950 trovavano
esemplari i più luridi film controrivoluzionari sovietici, come
Lenin nel 1918
o
La caduta di Berlino.
Parlo di chi aveva coraggio e intelligenza. Che cos'è
che non l i ha fatto resistere ad una prolungata esposizione a quella forma
di orrore? A quell'orrore specifico, che viene dalla contemplazione d i un
fallimento storico tanto ampio da coinvolgere l'idea medesima che ci siamo
fatti di uomo e di società possibili?
3. Venticinque anni fa uno dei punti che maggiormente opposero alcuni
intellettuali francesi vicini a Sartre ai comunisti (francesi e non francesi) di
disciplina stalinista fu l'insistenza dei primi a voler indagare le contraddizioni
che avevano accompagnata l a venuta della guerra, la lotta partigiana e le
persecuzioni naziste. Per gli al tri si trattava invece d i mettere semmai i n
evidenza l'eroismo dei vincitori e l'infamia dei vinti. Dubbi e ambiguità
dovevano essere lasciati alle 'jene dattilografe'; come Sartre. E qualcosa di
non molto diverso è occorso di leggere, in anni recenti, tra la pubblicistica
cinese. Non a caso un libro come
Humanisme et terreur
di Merleau-Ponty
è stato tradotto con quasi vent'anni di ritardo e quasi ignorato, prima e poi;
223 —
















