
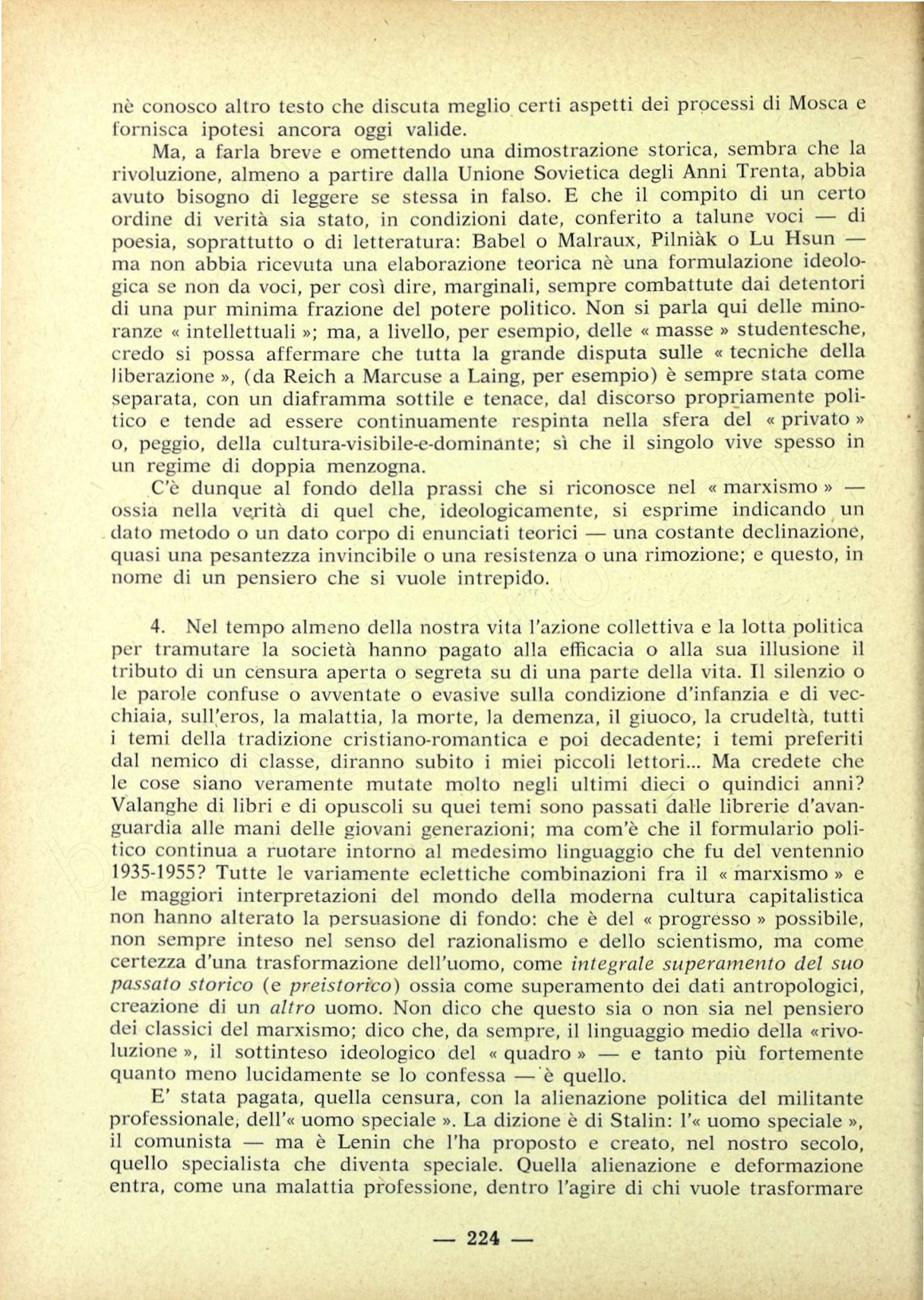
nè conosco al tro testo che discuta meglio. certi aspetti dei prpcessi di Mosca e
fornisca ipotesi ancora oggi val ide.
Ma, a far la breve e omettendo una dimostrazione storica, sembra che la
rivoluzione, almeno a part ire dalla Unione Sovietica degli Anni Trenta, abbia
avuto bisogno d i leggere se stessa i n falso. E che i l compi to d i un cer to
ordine d i ver i tà sia stato, i n condizioni date, confer i to a talune voci — d i
poesia, soprattutto o d i letteratura: Babel o Malraux, Pi lniàk o Lu Hsun
ma non abbia ricevuta una elaborazione teorica nè una formulazione ideolo-
gica se non da voci, per così dire, marginali, sempre combattute dai detentori
di una pur minima frazione del potere politico. Non si parla qui delle mino-
ranze «intel lettual i »; ma, a livello, per esempio, delle « masse » studentesche,
credo s i possa affermare che tut ta l a grande disputa sul le «tecniche del la
liberazione », (da Reich a Marcuse a Laing, per esempio) è sempre stata come
separata, con un diaframma sotti le e tenace, dal discorso propriamente pol i-
tico e tende ad essere continuamente respinta nel la sfera de l « privato»
o, peggio, del la cul tura-visibile-e-dominante; s ì che i l singolo vive spesso i n
un regime d i doppia menzogna.
C'è dunque a l fondo del la prassi che s i riconosce nel « marxismo »
ossia nel la ve,rità d i que l che, ideologicamente, s i espr ime indicando u n
, dato metodo o un dato corpo di enunciati teorici — una costante declinazione,
quasi una pesantezza invincibile o una resistenza o una rimozione; e questo, in
nome d i un pensiero che si vuole intrepido.
4.
N e l tempo almeno della nostra vita l'azione collettiva e la lotta politica
per tramutare l a società hanno pagato al la efficacia o al la sua i l lusione i l
tributo di un censura aperta o segreta su di una parte della vita. I l silenzio o
le parole confuse o avventate o evasive sul la condizione d' infanzia e d i vec-
chiaia, sull:eros, la malattia, la morte, la demenza, i l giuoco, la crudeltà, tut t i
i temi del la tradizione crist iano-romantica e po i decadente; i temi prefer i t i
dal nemico d i classe, di ranno subi to i miei piccol i lettori... Ma credete che
le cose siano veramente mutate mo l to negl i u l t imi dieci o quindici anni?
Valanghe di l ibr i e di opuscoli su quei temi sono passati dalle l ibrerie d'avan-
guardia alle mani delle giovani generazioni; ma com'è che i l formular io pol i-
tico continua a ruotare intorno al medesimo linguaggio che f u del ventennio
1935-1955? Tut te le variamente eclettiche combinazioni f r a i l « marxismo » e
le maggior i interpretazioni de l mondo del la moderna cul tura capi tal ist ica
non hanno alterato la persuasione di fondo: che è del « progresso » possibile,
non sempre inteso nel senso del razionalismo e del lo scientismo, ma come
certezza d'una trasformazione dell'uomo, come
integrale superamento del suo
passato storico
(e
preistoritco)
ossia come superamento dei dati antropologici,
creazione di un
al t ro
uomo. Non dico che questo sia o non sia nel pensiero
dei classici del marxismo; dico che, da sempre, i l linguaggio medio della «rivo-
luzione », i l sottinteso ideologico de l « quadro » — e tanto p i ù fortemente
quanto meno lucidamente se lo confessa —'è quello.
E' stata pagata, quel la censura, con la alienazione pol i t ica del mi l i tante
professionale, dell'« uomo speciale ». La dizione è di Stalin: l'« uomo speciale »,
i l comunista — ma è Lenin che l 'ha proposto e creato, nel nost ro secolo,
quello specialista che diventa speciale. Quel la alienazione e deformazione
entra, come una malattia pl'ofessione, dentro l'agire d i chi vuole trasformare
— 224
















