
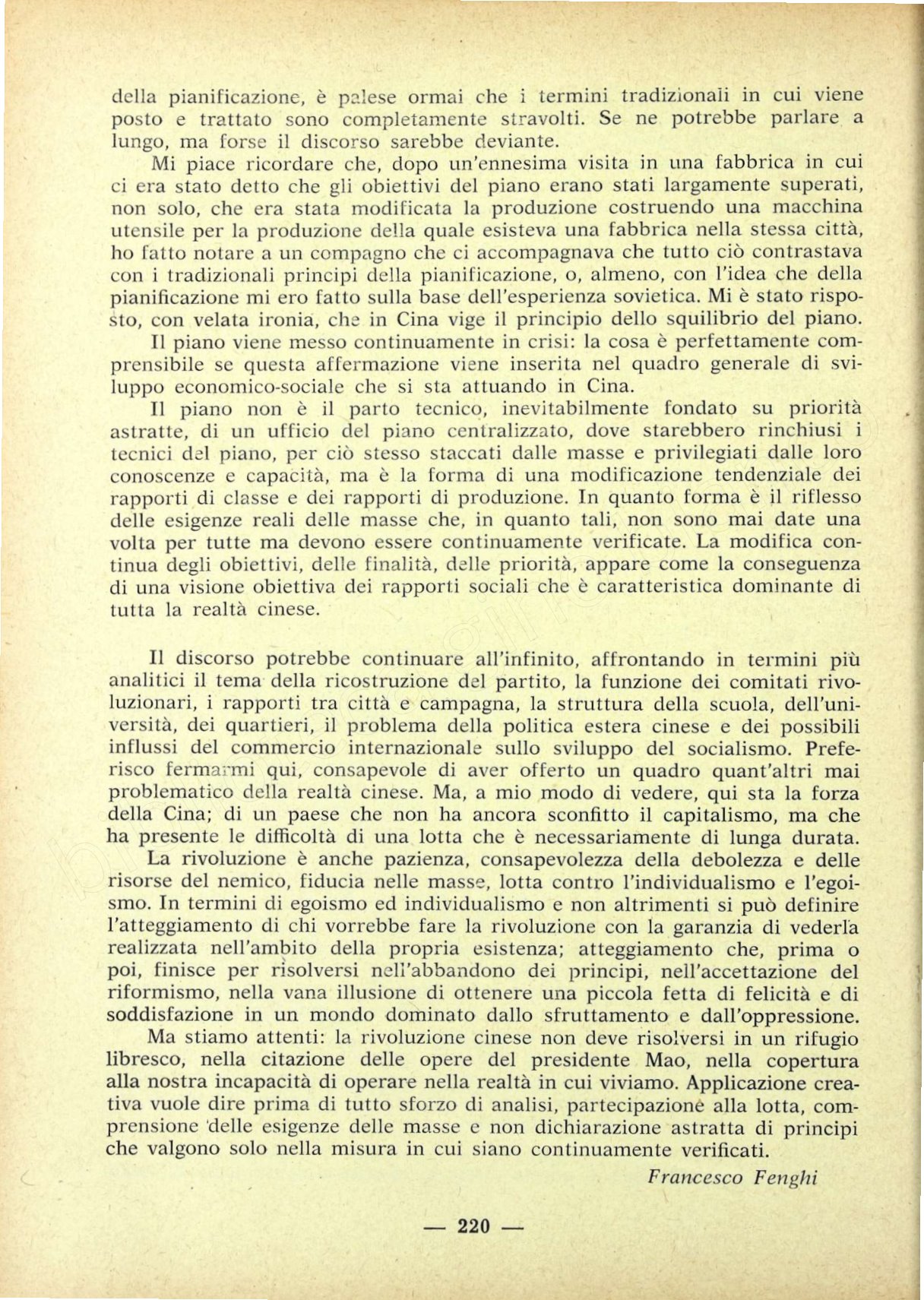
della pianificazione, è palese ormai che i termi n i tradizional i i n cu i viene
posto e t rat tato sono completamente stravol t i . Se ne potrebbe par lare a
lungo, ma forse i l discorso sarebbe deviante.
Mi piace ricordare che, dopo un'ennesima visi ta i n una fabbr ica i n cu i
ci era stato detto che gl i obiett ivi del piano erano stat i largamente superati,
non solo, che era stata modi f icata l a produzione costruendo una macchina
utensile per la produzione della quale esisteva una fabbrica nella stessa città,
ho fatto notare a un compagno che ci accompagnava che tut to ciò contrastava
con i tradizionali pr incipi della pianificazione, o, almeno, con l ' idea che della
pianificazione mi ero fatto sulla base dell'esperienza sovietica. Mi è stato rispo-
àto, con velata ironia, che in Cina vige i l principio del lo squi l ibr io del piano.
I l piano viene messo continuamente in crisi: la cosa è perfettamente com-
prensibile se questa affermazione viene inseri ta nel quadro generale d i svi-
luppo economico-sociale che si sta attuando i n Cina.
I l p i ano non è i l par t o tecnico, inevi tabi lmente fondato s u p r i o r i t à
astratte, d i un uf f i c io de l piano centralizzato, dove starebbero r inchiusi i
tecnici del piano, per ciò stesso staccati dal le masse e privi legiat i dal le loro
conoscenze e capacità, ma è l a forma d i una modificazione tendenziale dei
rapporti di classe e dei rapport i d i produzione. I n quanto forma è i l riflesso
delle esigenze real i delle masse che, i n quanto tal i , non sono ma i date una
volta per tut te ma devono essere continuamente verificate. La modifica con-
tinua degli obiettivi, delle final ità, delle priori tà, appare come la conseguenza
di una visione obiettiva dei rapport i sociali che è caratteristica dominante d i
tutta la realtà cinese.
I l discorso potrebbe continuare al l ' inf ini to, aff rontando i n termi n i p i ù
analitici i l tema della ricostruzione del part i to, la funzione dei comi tat i rivo-
luzionari, i rapport i t ra ci t tà e campagna, la st rut tura della scuola, del l 'uni-
versità, dei quart ieri , i l problema del la pol i t ica estera cinese e dei possibi l i
influssi de l commercio internazionale sul lo svi luppo de l socialismo. Prefe-
risco fermarmi qui , consapevole d i aver offer to un quadro quant 'al t r i ma i
problematico della realtà cinese. Ma, a mio modo d i vedere, qui sta la forza
della Cina; d i un paese che non ha ancora sconfitto i l capitalismo, ma che
ha presente le difficoltà d i una lot ta che è necessariamente d i lunga durata.
La rivoluzione è anche pazienza, consapevolezza del la debolezza e del le
risorse del nemico, fiducia nelle masse, lot ta contro l ' individual ismo e l'egoi-
smo. In termini di egoismo ed individualismo e non al tr iment i si può definire
l'atteggiamento di chi vorrebbe fare la rivoluzione con la garanzia d i vederla
realizzata nel l 'ambi to del la propr ia esistenza; atteggiamento che, p r ima o
poi, f inisce pe r risolversi nell'abbandono de i pr incipi , nell'accettazione de l
riformismo, nella vana illusione d i ottenere una piccola fet ta d i fel ici tà e d i
soddisfazione i n un mondo dominato dal lo sfruttamento e dall'oppressione.
Ma stiamo attenti: l a rivoluzione cinese non deve risolversi i n un r i fugio
libresco, ne l l a citazione del le opere de l presidente Mao, ne l l a coper tura
alla nostra incapacità di operare nella realtà in cui viviamo. Applicazione crea-
tiva vuole dire pr ima di tut to sforzo di analisi, partecipazione alla lotta, com-
prensione 'delle esigenze delle masse e non dichiarazione astratta d i pr incipi
che valgono solo nella misura in cui siano continuamente verificati.
Francesco Fenghi
220
















