
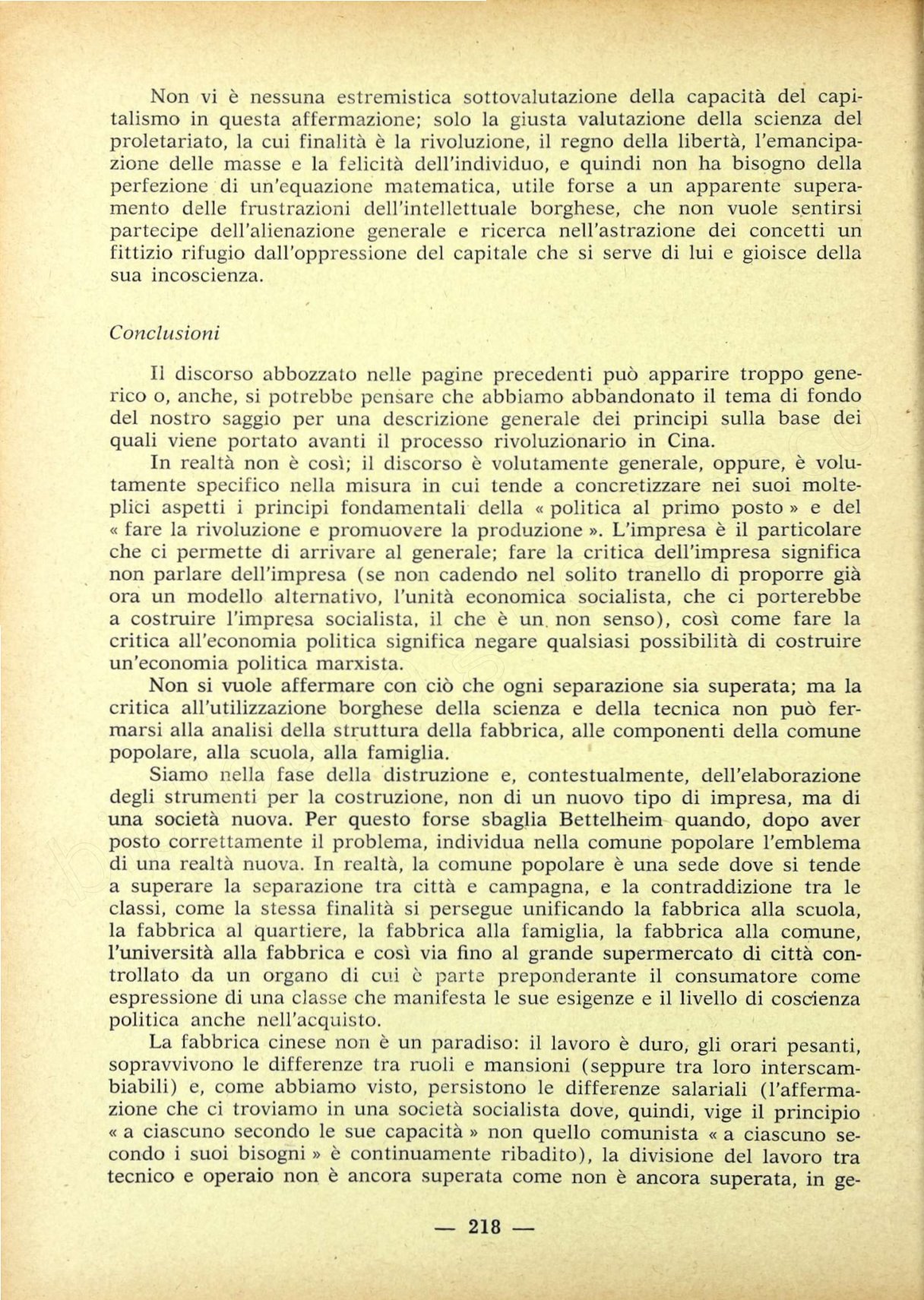
Non v i è nessuna estremistica sottovalutazione del la capacità del capi-
talismo i n questa affermazione; solo l a giusta valutazione del la scienza del
proletariato, la cui f inal i tà è la rivoluzione, i l regno della l ibertà, l'emancipa-
zione delle masse e l a fel ici tà dell ' individuo, e quindi non ha bisogno del la
perfezione d i un'equazione matematica, ut i le forse a un apparente supera-
mento del le frustrazioni del l ' intel lettuale borghese, che non vuole s.entirsi
partecipe dell'alienazione generale e r icerca nell'astrazione de i concet t i u n
f i tt izio r i fugio dall'oppressione del capitale che si serve d i l u i e gioisce della
sua incoscienza.
Conclusioni
I l discorso abbozzato nelle pagine precedenti può apparire t roppo gene-
rico o, anche, si potrebbe penare che abbiamo abbàndonato i l tema di fondo
del nost ro saggio per una descrizione generale de i pr inc ipi sul la base de i
quali viene portato avant i i l processo rivoluzionario i n Cina.
In realtà non è così; i l discorso è volutamente generale, oppure, è volu-
tamente specifico nel la misura i n cui tende a concretizzare nei suoi molte-
plici aspetti i pr incipi fondamental i del la « politica a l p r imo posto» e de l
« fare la rivoluzione e promuovere la produzione ». L' impresa è i l particolare
che ci permette d i arrivare al generale; fare la cr i t ica dell'impresa significa
non parlare dell'impresa (se non cadendo nel sol i to tranel lo d i proporre già
ora un model lo alternativo, l 'uni tà economica socialista, che c i porterebbe
a costruire l ' impresa socialista, i l che è un. non senso), così come fare l a
critica all'economia pol itica significa negare qualsiasi possibilità d i costruire
un'economia pol itica marxista.
Non si vuole affermare con ciò che ogni separazione sia superata; ma la
critica all'utilizzazione borghese del la scienza e del la tecnica non può fer -
marsi alla analisi della struttura della fabbrica, alle componenti della comune
popolare, al la scuola, al la famiglia.
Siamo nel la fase del la distruzione e, contestualmente, dell'elaborazione
degli strument i per la costruzione, non d i un nuovo t ipo d i impresa, ma d i
una società nuova. Per questo forse sbaglia Bettelheim quando, dopo aver
posto correttamente i l problema, individua nella comune popolare l'emblema
di una realtà nuova. I n realtà, la comune popolare è una sede dove si tende
a superare l a separazione t r a c i t tà e campagna, e l a contraddizione t r a l e
classi, come la stessa f inal i tà s i persegue unificando l a fabbrica al la scuola,
la fabbrica a l quartiere, l a fabbrica al la famigl ia, l a fabbr ica al la comune,
l'università al la fabbrica e così via fino a l grande supermercato d i ci t tà con-
trollato da un organo d i cu i è par te preponderante i l consumatore come
espressione di una classe che manifesta le sue esigenze e i l livello di coscienza
politica anche nell'acquisto.
La fabbrica cinese non è un paradiso: i l lavoro è duro, gl i orar i pesanti,
sopravvivono le differenze t ra ruol i e mansioni (seppure t ra loro interscam-
biabi l i) e, come abbiamo visto, persistono l e differenze salarial i ( l 'afferma-
zione che ci troviamo i n una società socialista dove, quindi , vige i l pr incipio
«a ciascuno secondo le sue capacità » non quello comunista « a ciascuno se-
condo i suoi bisogni » è continuamente r ibadi to), la divisione del lavoro t r a
tecnico e operaio non è ancora superata come non è ancora superata, i n ge-
218
















