
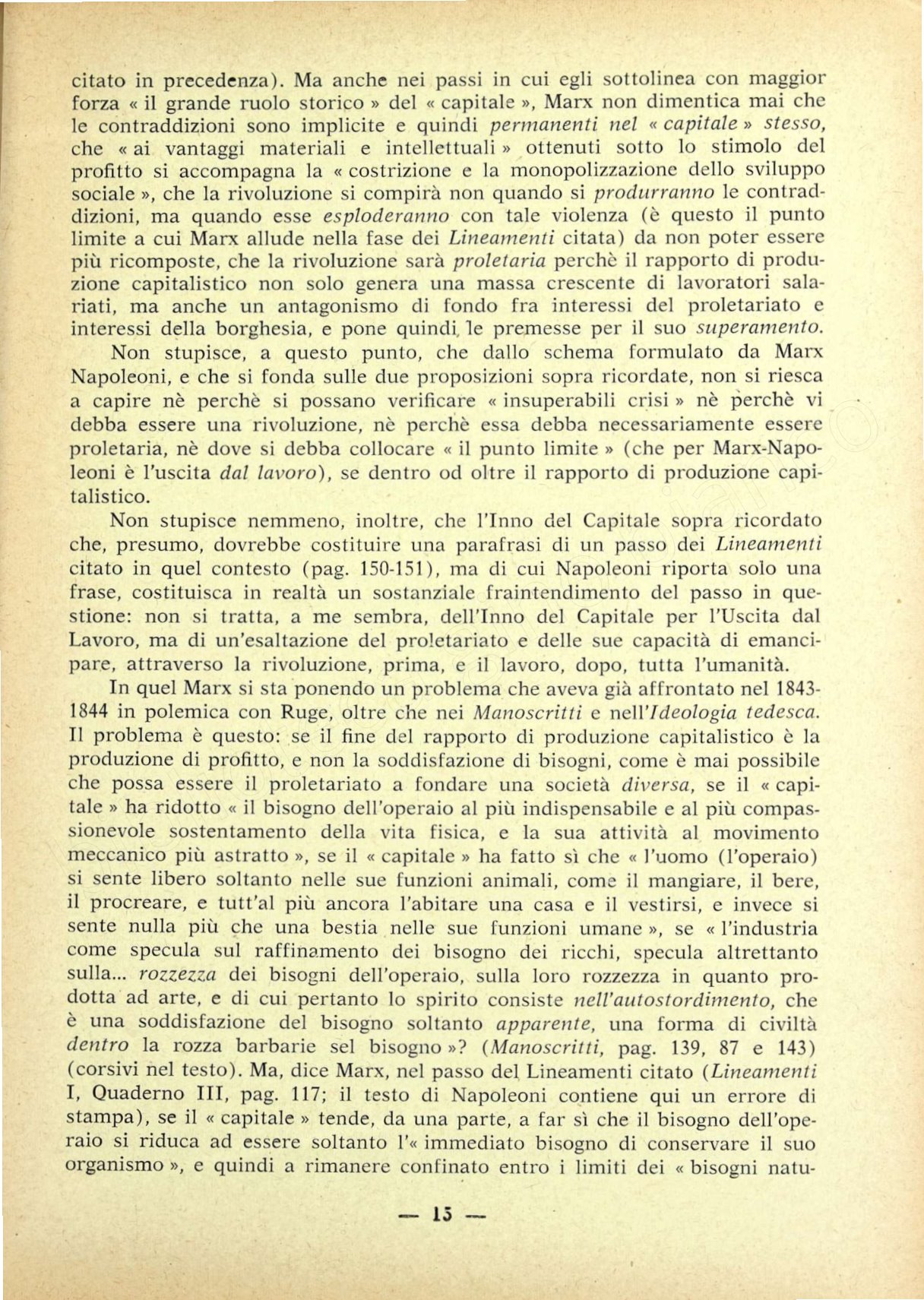
citato i n precedenza). Ma anche nei passi i n cui egl i sottolinea con maggior
forza « i l grande mo l o storico » del «capitale », Marx non dimentica mai che
le contraddizioni sono impl ici te e quindi
permanenti nel
«
capitale
»
stesso,
che « ai vantaggi mater ial i e intel let tual i » ot tenut i sot to l o st imolo de l
profitto s i accompagna la « costrizione e l a monopolizzazione del lo svi luppo
sociale », che la rivoluzione si compirà non quando si
produrranno
le contrad-
dizioni, ma quando esse
esploderanno
con tale violenza ( è questo i l punto
l imite a cui Marx allude nella fase dei
Lineamenti
citata) da non poter essere
più ricomposte, che la rivoluzione sarà
proletaria
perchè i l rapporto di produ-
zione capital istico non solo genera una massa crescente d i lavorator i sala-
riati, ma anche u n antagonismo d i fondo f r a interessi de l proletar iato e
interessi della borghesia, e pone quindi, le premesse per i l suo
superamento.
Non stupisce, a questo punto, che da l l o schema formulato d a Ma r x
Napoleoni, e che si fonda sulle due proposizioni sopra ricordate, non si riesca
a capire nè perchè s i possano verificare « insuperabili cr i s i » nè i ierchè v i
debba essere una rivoluzione, nè perchè essa debba necessariamente essere
proletaria, nè dove si debba collocare « i l punto l imi te » (che per Marx-Napo-
leoni è l 'uscita
dal lavoro),
se dentro od oltre i l rapporto di produzione capi-
talistico.
Non stupisce nemmeno, inol tre, che l ' Inno del Capitale sopra r icordato
che, presumo, dovrebbe costituire una parafrasi d i un passo dei
Lineamenti
citato i n quel contesto (pag. 150-151), ma d i cui Napoleoni r ipor ta solo una
frase, costituisca i n real tà un sostanziale fraintendimento del passo i n que-
stione: non s i t rat ta, a me sembra, del l ' Inno del Capitale per l 'Usci ta da l
Lavoro, ma d i un'esaltazione del proletariato e delle sue capacità d i emanci-
pare, attraverso l a rivoluzione, pr ima, e i l lavoro, dopo, tut ta l 'umanità.
In quel Marx si sta ponendo un problema che aveva già affrontato nel 1843-
1844 i n polemica con Ruge, ol tre che nei
Manoscritti
e
nell'Ideologia tedesca.
I l problema è questo: se i l fine del rapporto d i produzione capitalistico è la
produzione di profitto, e non la soddisfazione di bisogni, come è mai possibile
che possa essere i l proletariato a fondare una società
diversa,
se i l « capi-
tale» ha ridotto « i l bisogno dell'operaio al più indispensabile e al più compas-
sionevole sostentamento del la v i t a f isica, e l a sua at t i v i tà a l movimento
meccanico più astratto », se i l « capitale » ha fat to sì che « l'uomo (l 'operaio)
si sente l ibero soltanto nelle sue funzioni animali, come i l mangiare, i l bere,
i l procreare, e tut t 'al p i ù ancora l 'abitare una casa e i l vestirsi, e invece s i
sente nul la p i ù che una bestia nel le sue funzioni umane », se « l ' industria
come specula su l raff inamento de i bisogno de i r icchi , specula al t ret tanto
sulla.., rozzezza dei bisogni dell'operaio, sul la l oro rozzezza i n quanto pro-
dotta• ad arte, e d i cui pertanto l o spi r i to consiste
nell'autostordimento,
che
è una soddisfazione de l bisogno sol tanto
apparente,
una f orma d i c i v i l tà
dentro
l a rozza barbar ie sel bisogno »?
(Manoscr i t t i ,
pag. 139, 87 e 143)
(corsivi nel testo). Ma, dice Marx, nel passo del, Lineamenti citato
(Lineamenti
I,
Quaderno I I I , pag. 117; i l testo d i Napoleoni contiene qu i un errore d i
stampa), se i l « capitale» tende, da una parte, a far sì che i l bisogno dell'ope-
raio s i r iduca ad essere soltanto l '« immediato bisogno d i conservare i l suo
organismo », e quindi a rimanere confinato ent ro i l imi t i dei «bisogni natu-
















