
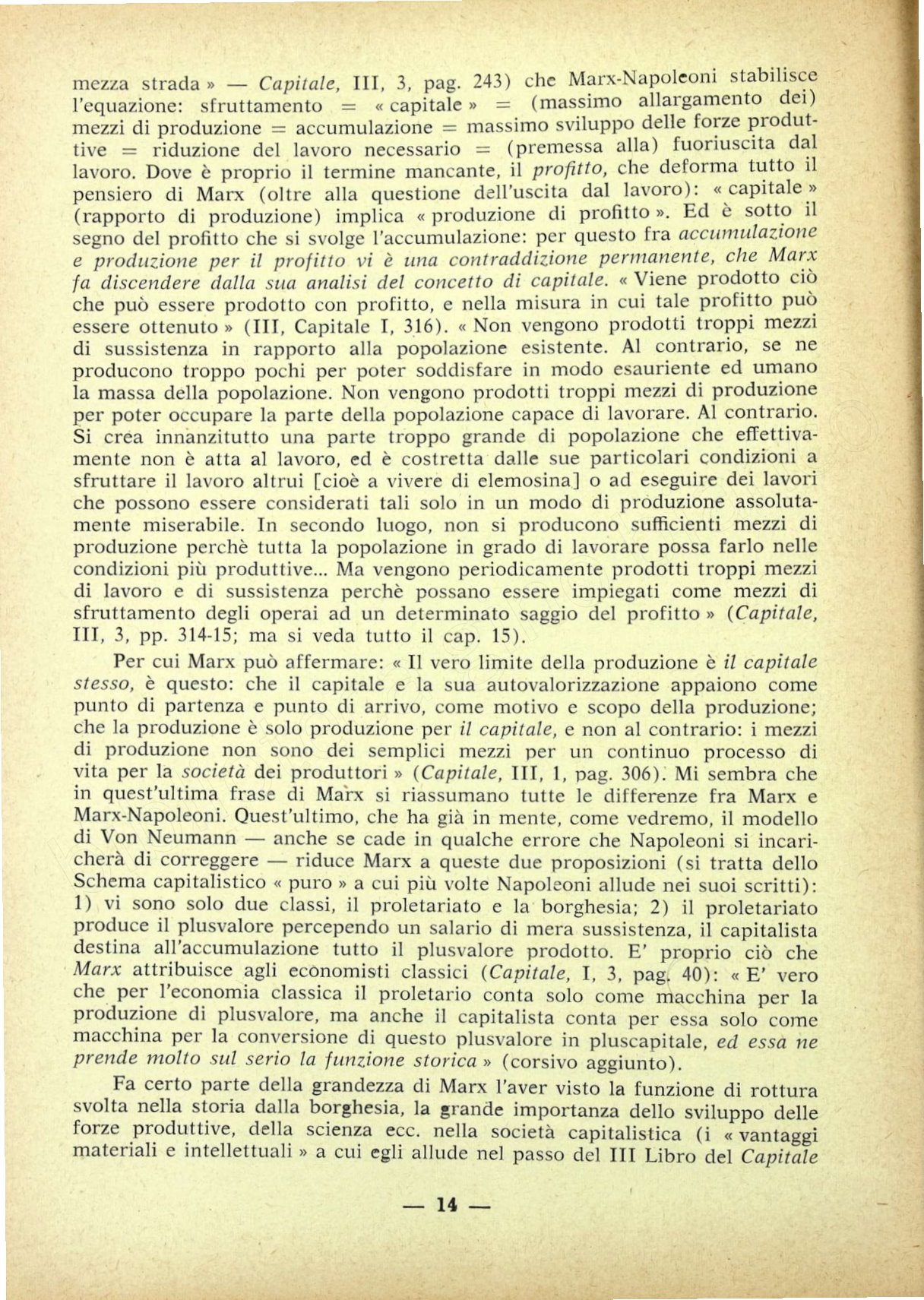
mezza strada »
C a p i t a l e ,
I I I , 3, pag. 243) che Marx-Napoleoni stabilisce
l'equazione: sf rut tamento = « capitale)) = (mass imo al largamento de i )
mezzi di produzione = accumulazione = massimo sviluppo delle forze produt-
tive = r iduzione de l lavoro necessario = (premessa al la) fuor iusci ta da l
lavoro. Dove è propr io i l termine mancante, i l
profitto,
che deforma tut to i l
pensiero d i Mar x (o l t re al la questione del l 'uscita da l lavoro) : « capitale »
(rapporto d i produzione) impl i ca « produzione d i prof i t to ». E d è sot to i l
segno del profitto che si svolge l'accumulazione: per questo fra
accumulazione
e produzione per i l prof i t to v i è una contraddizione permanente, che Marx
fa discendere dalla sua analisi del concetto d i capitale. « Viene prodot to ciò
che può essere prodotto con prof i tto, e nella misura in cui tale prof i t to può
essere ottenuto » ( I I I , Capitale I , 316). « Non vengono prodot t i t roppi mezzi
di sussistenza i n rappor to al la popolazione esistente. A l contrar io, se ne
producono troppo pochi per poter soddisfare i n modo esauriente ed umano
la massa della popolazione. Non vengono prodott i troppi mezzi di produzione
per poter occupare la parte della popolazione capace di lavorare. Al contrario.
Si crea innànzitutto una parte t roppo grande d i popolazione che effettiva-
mente non è atta al lavoro, ed è costretta dalle sue part icolari condizioni a
sfruttare i l lavoro al trui [cioè a vivere di elemosina] o ad eseguire dei lavori
che possono essere considerati tal i solo i n un modo d i produzione assoluta-
mente miserabile. I n secondo luogo, non s i producono sufficienti mezzi d i
produzione perchè tut ta la popolazione in grado di lavorare possa farlo nelle
condizioni più produttive... Ma vengono periodicamente prodot t i troppi mezzi
di lavoro e d i sussistenza perchè possano essere impiegat i come mezzi d i
sfruttamento degli operai ad un determinato saggio del prof i t to »
(Capitale,
I I I , 3, pp. 314-15; ma si veda tut to i l cap. 15).
Per cui Marx può affermare: « I l vero l imi te della produzione è
i l capitale
stesso,
è questo: che i l capitale e l a sua autovalorizzazione appaiono come
punto di partenza e punto di arrivo, come mot ivo e scopo della produzione;
che la produzione è solo produzione per
i l capitale,
e non al contrario: i mezzi
di produzione non sono de i sempl ici mezzi pe r u n cont inuo processo d i
vita per
la società
dei produttori »
(Capitale, I I I ,
1, pag. 306): Mi sembra che
in quest'ultima frase d i Mdrx si riassumano tut te le differenze f r a Marx e
Marx-Napoleoni. Quest'ultimo, che ha già in mente, come vedremo, i l modello
di Von Neumann — anche se cade in qualche errore che Napoleoni si incari-
cherà di correggere — riduce Marx a queste due proposizioni (s i t rat ta dello
Schema capitalistico « puro » a cui più volte Napoleoni allude nei suoi scr i tt i ):
1) v i sono solo due classi, i l proletariato e l a borghesia; 2 ) i l proletariato
produce i l plusvalore percependo un salario di mera sussistenza, i l capitalista
destina all'accumulazione t u t t o i l plusvalore prodotto. E ' propr io c i ò che
Marx
attribuisce agl i economisti classici
(Capitale,
I , 3, pag, 40): « E ' vero
che per l'economia classica i l proletario conta solo come macchina per l a
produzione d i plusvalore, ma anche i l capitalista conta per essa solo come
macchina per la conversione di questo plusvalore i n pluscapitale,
ed essa ne
prende molto sul serio la funzione storica)) (corsivo aggiunto).
Fa certo parte della grandezza di Marx l'aver visto la funzione di rot tura
svolta nella storia dalla borghesia, la grande importanza dello sviluppo delle
forze produtt ive, del la scienza ecc, nel la società capital istica ( i « vantaggi
materiali e intellettuali)) a cui egli allude nel passo del I I I Libro del
Capitale
14
















