
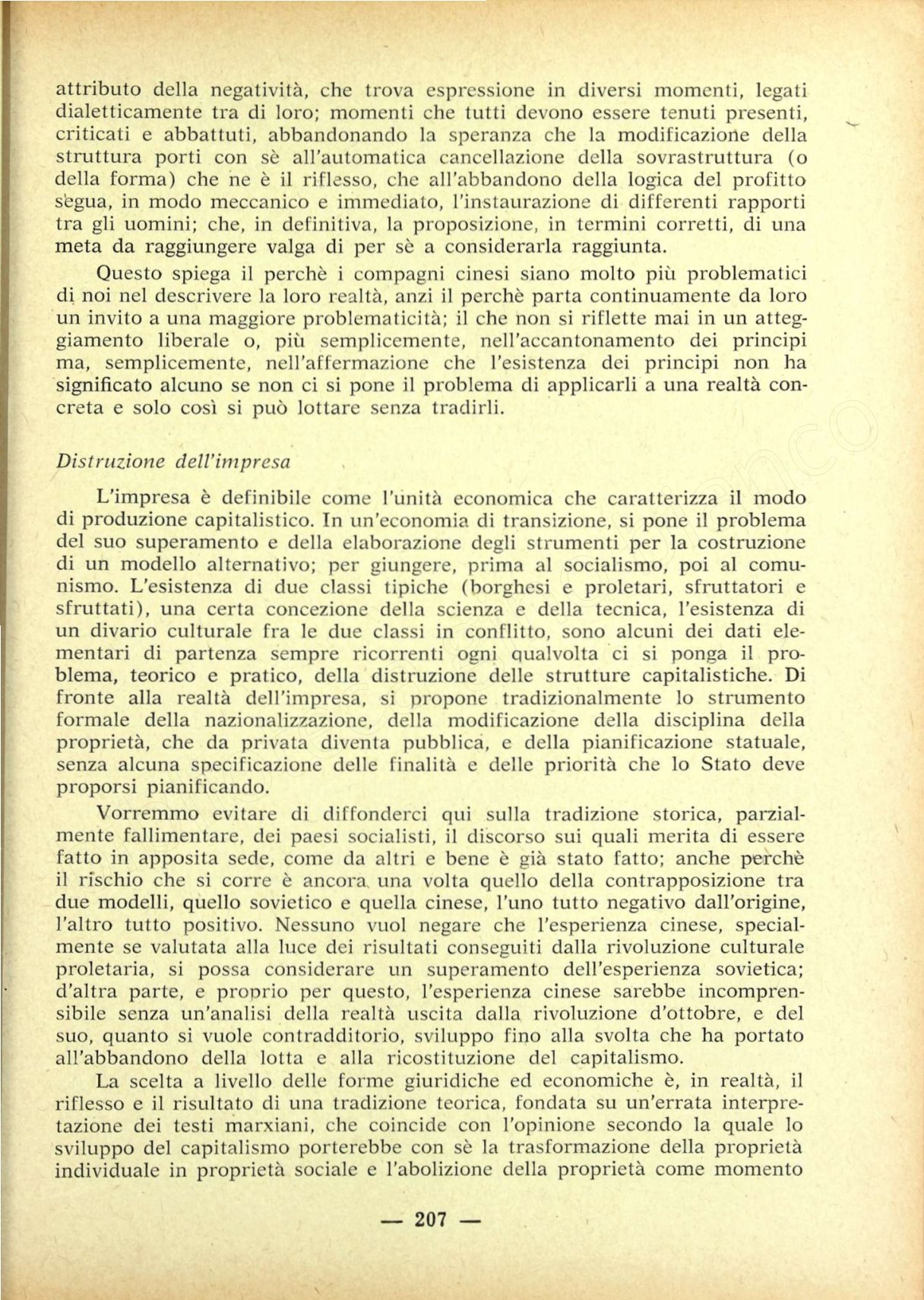
attributo del la negatività, che t rova espressione i n diversi moment i , legat i
dialetticamente t ra di loro; moment i che t u t t i devono essere tenut i presenti,
criticati e abbattut i , abbandonando l a speranza che l a modificazione del la
struttura po r t i con sè al l 'automatica cancellazione del la sovrastruttura ( o
della forma) che ne è i l riflesso, che all'abbandono del la logica del prof i t to
s'egua, in modo meccanico e immediato, l'instaurazione d i di fferent i rapport i
tra gl i uomini ; che, i n definitiva, l a proposizione, i n termini corrett i , d i una
meta da raggiungere valga d i per sè a considerarla raggiunta.
Questo spiega i l perchè i compagni cinesi siano mol to p i ù problematici
di noi nel descrivere la loro realtà, anzi i l perché parta continuamente da loro
•un invito a una maggiore problematicità; i l che non si ri f lette mai in un atteg-
giamento l iberale o , p i ù semplicemente, nell'accantonamento de i pr i nc i p i
ma, semplicemente, nell 'affermazione che l'esistenza de i pr i nc i p i n o n h a
significato alcuno se non ci si pone i l problema di appl icarl i a una realtà con-
creta e solo così si può lottare senza t radi r l i .
Distruzione dell'impresa
L'impresa è def inibi le come l 'uni tà economica che caratterizza i l modo
di produzione capitalistico I n un'economia di transizione, si pone i l problema
del suo superamento e della elaborazione degli strument i per la costruzione
di un model lo alternativo; per giungere, pr ima a l socialismo, po i a l comu-
nismo. L'esistenza d i due classi t ipiche (borghesi e proletari , sf rut tator i e
sfruttat i), una certa concezione del la scienza e del la tecnica, l'esistenza d i
un divar io cul turale f r a le due classi i n conf l i tto, sono alcuni dei dat i ele-
mentari d i partenza sempre r icor rent i ogn i qualvol ta .ci s i ponga i l pro-
blema, teor ico e prat ico, del la distruzione del le st rut ture capitalistiche. D i
fronte a l l a real tà dell ' impresa, s i propone tradizionalmente l o st rumento
formale de l l a nazionalizzazione, del la modificazione de l l a discipl ina del la
proprietà, che da pr ivata diventa pubbl icà, e del la pianificazione statuale,
senza alcuna specificazione del le f inal i tà e del le pr ior i tà che l o Stato deve
proporsi pianificando.
Vorremmo evi tare d i di ffonderci q u i sul la tradizione storica, parzial-
mente fallimentare, dei paesi socialisti, i l discorso sui qual i meri ta d i essere
fatto in apposita sede, come da al t r i e bene è già stato fatto; anche pei-chè
il r ischio che s i corre è ancora una vol ta quel lo del la contrapposizione t r a
due modelli, qùello sovietico e quella cinese, l 'uno tut to negativo dall'origine,
l 'altro t u t t o positivo. Nessuno vuol negare che l'esperienza cinese, special-
mente se valutata alla luce dei r isul tat i conseguiti dalla rivoluzione culturale
proletaria, s i possa considerare u n superamento dell'esperienza sovietica;
d'altra parte, e propr io per questo, l'esperienza cinese sarebbe incompren-
sibile senza un'anal isi del la real tà uscita dal la rivoluzione d'ottobre, e del
suo, quanto si vuole contradditorio, sviluppo f ino al la svolta che ha portato
all'abbandono del la l o t t a e a l l a ricostituzione de l capitalismo.
La scelta a l ivel lo delle forme giuridiche ed economiche è, i n realtà, i l
riflesso e i l risultato di una tradizione teorica, fondata su un'errata interpre-
tazione dei test i ni‘ arxiani, che coincide con l 'opinione secondo l a quale l o
sviluppo del capitalismo porterebbe con sè la trasformazione della proprietà
individuale i n proprietà sociale e l'abolizione della proprietà come momento
— 207 —
















