
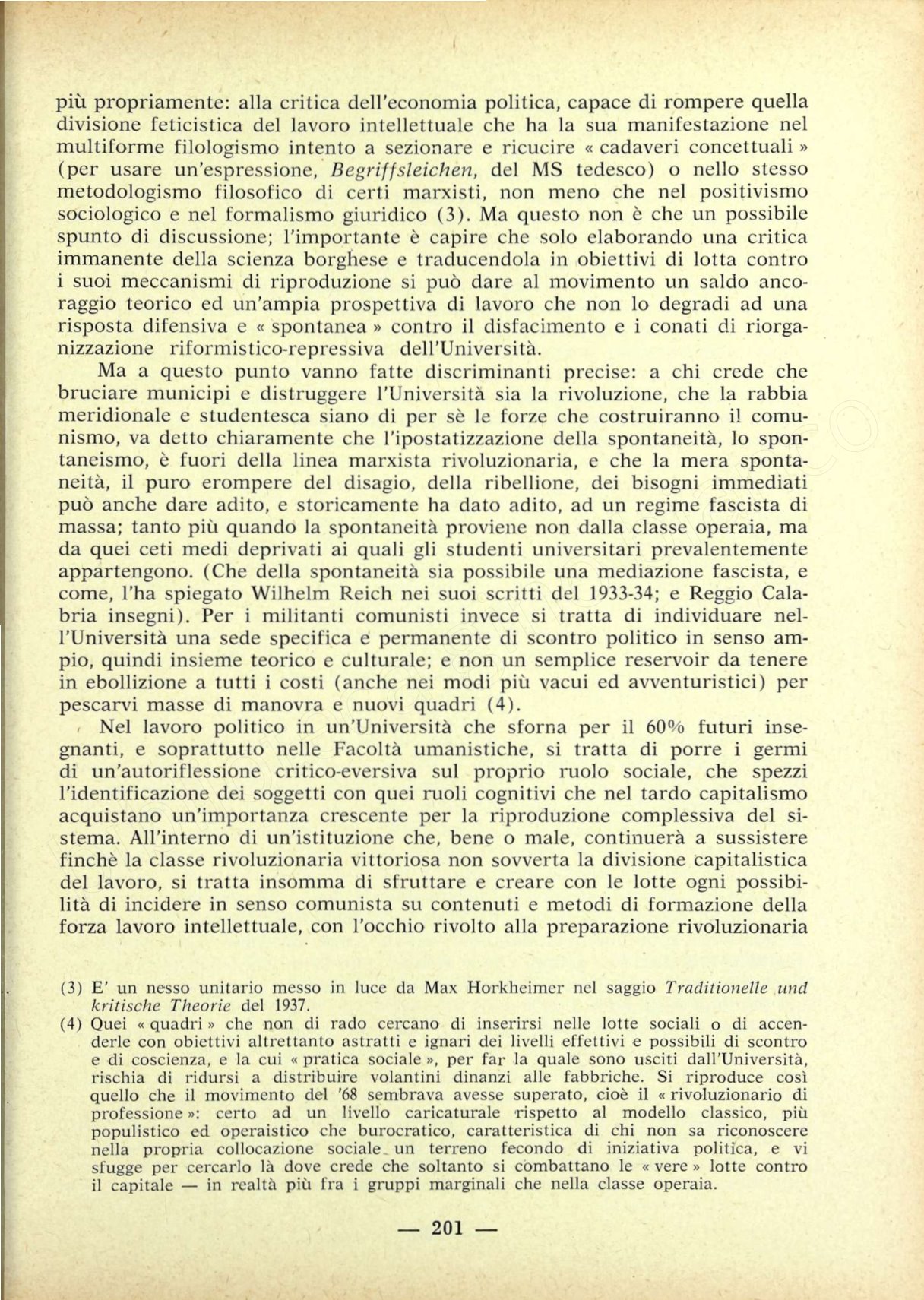
più propriamente: al la critica dell'economia politica, capace di rompere quella
divisione feticistica del lavoro intellettuale che ha la sua manifestazione nel
mul t i forme filologismo intento a sezionare e ricucire « cadaveri concettuali>'
(per usare un'espressione,.
Begriffsleichen,
de l MS tedesco) o nel lo stesso
metodologismo f i losof ico d i cer t i marxist i , non meno che ne l posi t ivismo
sociologico e nel formalismo giuridico (3). Ma questo non è che un possibile
spunto d i discussione; l ' importante è capire che solo elaborando una cr i t ica
immanente della scienza borghese e traducendola i n obiett ivi d i lot ta contro
i suoi meccanismi d i riproduzione si può dare al movimento un saldo anco-
raggio teorico ed un'ampia prospettiva d i lavoro che non l o degradi ad una
risposta difensiva e « spontanea » contro i l disfacimento e i conati d i riorga-
nizzazione r i formi s t i co-repressiva del l 'Università.
Ma a questo punto vanno fat te discr iminant i precise: a ch i crede che
bruciare municipi e distruggere l 'Università sia la rivoluzione, che la rabbia
meridionale e studentesca siano d i per sè le forze che costruiranno i l comu-
nismo, va detto chiaramente che l'ipostatizzazione della spontaneità, lo spon-
taneismo, è fuor i del la l inea marxista rivoluzionaria, e che l a mera sponta-
neità, i l puro erompere del disagio, del la ribel l ione, dei bisogni immediat i
può anche dare adito, e storicamente ha dato adito, ad un regime fascista d i
massa; tanto più quando la spontaneità proviene non dalla classe operaia, ma
da quei ceti medi deprivati ai qual i gl i studenti universitari prevalentemente
appartengono. (Che della spontaneità sia possibile una mediazione fascista, e
come, l 'ha spiegato Wi lhelm Reich nei suoi scr i t t i del 1933-34; e Reggio Cala-
bria insegni). Per i mi l i tant i comunist i invece s i t rat ta d i individuare nel-
l'Università una sede specifica è permanente di scontro pol i t ico in senso am-
pio, quindi insieme teorico e culturale; e non un semplice reservoir da tenere
in ebollizione a tut t i i costi (anche nei modi più vacui ed avventuristici) per
pescarvi masse d i manovra e nuovi quadri (4) .
/ N e l lavoro pol i t ico i n un'Università che sforna per i l 60% f u t u r i inse-
gnanti, e soprat tut to nel le Facoltà umanistiche, s i t rat ta d i por re i germi
di un'autoriflessione c r i t i co -eversiva su l propr i o mo l o sociale, che spezzi
l'identificazione dei soggetti con quei ruol i cognitivi che nel tardo capitalismo
acquistano un'importanza crescente per l a riproduzione complessiva de l si -
stema. Al l ' interno d i un'istituzione che, bene o male, continuerà a sussistere
finche la classe rivoluzionaria vittoriosa non sovverta la divisione capitalistica
del lavoro, si t rat ta insomma d i sfruttare e creare con le lot te ogni possibi-
l ità di incidere in senso comunista su contenuti e metodi di formazione della
forza lavoro intellettuale, con l'occhio rivol to alla preparazione rivoluzionaria
(3)
(4)
E' un nesso uni tario messo i n luce da Max Horkheimer nel saggio
Traditionelle und
kritische Theorie del 1937.
Quei « quadri)> che non d i rado cercano d i inserirsi nel le lot te sociali o d i accen-
derle con obiettivi altrettanto astratti e ignari dei l ivel l i effettivi e possibili di scontro
e di coscienza, e la cui « pratica sociale », per far la quale sono usciti dall'Università,
rischia d i r idurs i a •distribuire volant ini dinanzi al le fabbriche. S i r iproduce così
quello che i l movimento del '68 sembrava avesse superato, cioè i l « rivoluzionario d i
professione »: ce r t o a d u n l i ve l l o caricaturale r ispet to a l model lo classico, p i ù
populistico ed operaistico che burocratico, caratteristica d i ch i non sa riconoscere
nella propr i a collocazione sociale_ un terreno fecondo d i iniziat iva pol i t ica, e v i
sfugge per cercarlo là dove crede che soltanto si ~ b a t t a n o le « vere » lot te contro
i l capitale — i n realtà più f ra i gruppi marginali che nella classe operaia.
201
















