
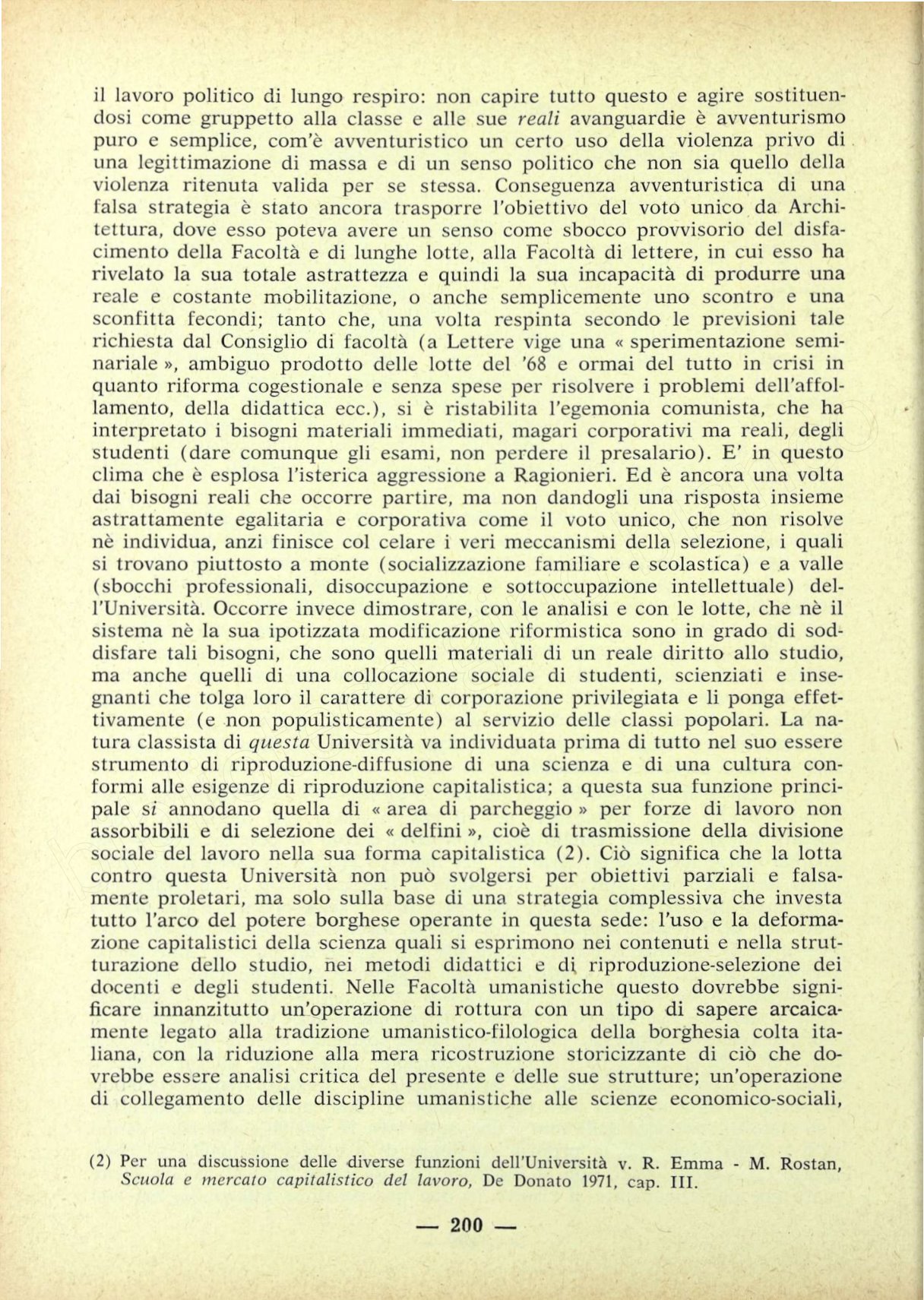
i l lavoro pol itico d i lungo respiro: non capire tut to questo e agire sostituen-
dosi come gruppetto al la classe e al le sue
real i
avanguardie è avventurismo
puro e semplice, com'è av-venturistico un certo uso del la violenza pr i vo d i
una legittimazione d i massa e d i un senso pol i t ico che non sia quel lo del la
violenza r i tenuta val ida pe r se stessa. Conseguenza avventuristica d i una
falsa strategia è stato ancora trasporre l 'obiett ivo del voto unico. da Archi -
tettura, dove esso poteva avere un senso come sbocco provvisorio del disfa-
cimento della Facoltà e di lunghe lotte, alla Facoltà di lettere, i n cui esso ha
rivelato la sua totale astrattezza e quindi la sua incapacità d i produrre una
reale e costante mobilitazione, o anche semplicemente uno scontro e una
sconfitta fecondi; t an t o che, una vol ta respinta secondo l e previsioni ta l e
richiesta dal Consiglio di facoltà (a Lettere vige una « sperimentazione semi-
nariale », ambiguo prodot to del le lot te del '68 e ormai del t u t t o i n cr i s i i n
quanto r i forma cogestionale e senza spese per risolvere i problemi del l 'affol-
lamento, del la didatt ica ecc.), s i è r istabi l i ta l'egemonia comunista, che ha
interpretato i bisogni material i immediati, magari corporat ivi ma real i, degli
studenti (dare comunque gl i esami, non perdere i l presalario). E ' i n questo
clima che è esplosa l'isterica aggressione a Ragionieri. Ed è ancora una volta
dai bisogni real i che occorre part ire, ma non dandogli una risposta insieme
astrattamente egalitaria e corporativa come i l voto unico, che non r isolve
nè individua, anzi finisce col celare i veri meccanismi della selezione, i qual i
si trovano piuttosto a monte (socializzazione fami l iare e scolastica) e a valle
(sbocchi professionali, disoccupazione e sottoccupazione intel let tuale) de l -
l'Università. Occorre invece dimostrare, con le analisi e con le lotte, che nè i l
sistema nè la sua ipotizzata modificazione r i formist ica sono i n grado d i sod-
disfare tal i bisogni, che sono quel l i material i d i un reale d i r i t t o al lo studio,
ma anche quel l i d i una collocazione sociale d i student i , scienziati e inse-
gnanti che tolga loro i l carattere di corporazione privilegiata e l i ponga effet-
tivamente (e non populisticamente) a l servizio del le classi popolari. La na-
tura classista di
questa
Università va individuata prima di tut to nel suo essere
strumento d i riproduzione-diffusione d i una scienza e d i una cul tura con-
formi alle esigenze di riproduzione capitalistica; a questa sua funzione princi-
pale s i annodano quel la d i « area d i parcheggio» pe r forze d i lavoro non
assorbibili e d i selezione dei « delfini », cioè d i trasmissione del la divisione
sociale del lavoro nella sua forma capitalistica (2) . Ciò significa che la lot ta
contro questa Universi tà non può svolgersi pe r obiet t ivi parzial i e falsa-
mente proletari, ma solo sulla base d i una strategia complessiva che investa
tutto l 'arco del potere borghese operante i n questa sede: l 'uso e la deforma-
zione capitalistici della scienza qual i si esprimono nei contenuti e nella strut-
turazione del lo studio, nei metodi didat t ici e d i riproduzione-selezione de i
docenti e degl i studenti. Nel le Facol tà umanistiche questo dovrebbe signi-
ficare innanzi tutto un'operazione d i rot tura con un t i po d i sapere arcaica-
mente legato al la tradizione umanistico-filologica del la borghesia col ta i ta-
liana, con l a riduzione al la mera ricostruzione storicizzante d i c i ò che do-
vrebbe essere analisi cri t ica del presente e delle sue strutture; un'operazione
di collegamento del le discipl ine umanistiche al le scienze economico-sociali,
(2) Per una discussione del le diverse funzioni dell'Università v. R. Emma -
M.
Rostan,
Scuola e mercato capitalistico del lavoro, De Donato 1971, cap. I I I .
200
















