
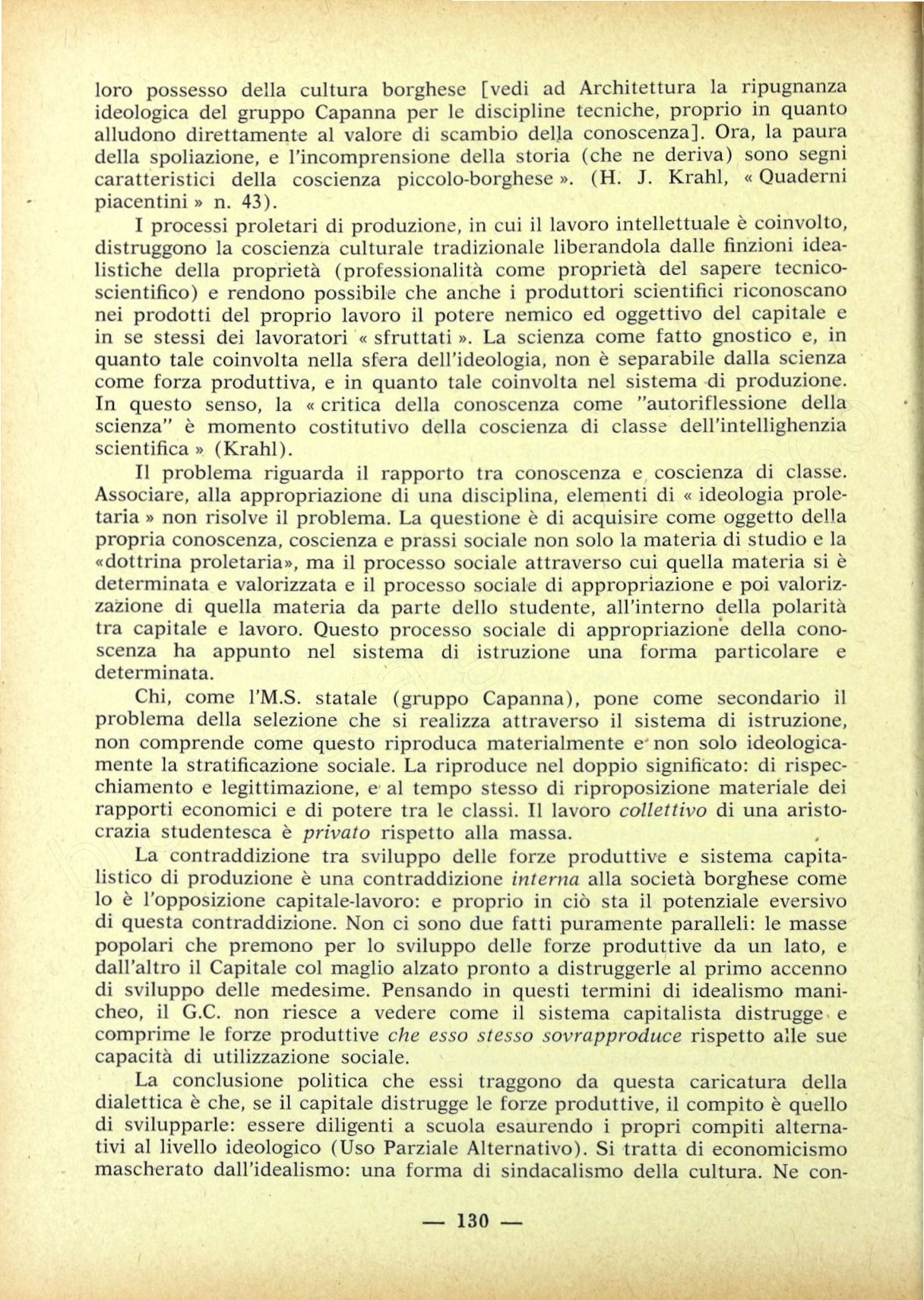
loro possesso del la cul tura borghese [ ved i ad Archi tet tura l a ripugnanza
ideologica del gruppo Capanna per le discipl ine tecniche, propr io i n quanto
alludono direttamente al valore d i scambio del la conoscenza]. Ora, la paura
della spoliazione, e l'incomprensione del la storia (che ne deriva) sono segni
caratteristici de l l a coscienza piccolo-borghese ».
( H .
J . Kr ah l , «Quaderni
piacentini » n. 43).
I processi proletari di produzione, in cui i l lavoro intellettuale è coinvolto,
distruggono la coscienza culturale tradizionale liberandola dalle finzioni idea-
listiche del la propr ietà (professional ità come propr ietà de l sapere tecnico-
scientifico) e rendono possibile che anche i produt tor i scientifici riconoscano
nei prodot t i del propr io lavoro i l potere nemico ed oggettivo del capitale e
in se stessi dei lavoratori I« sfruttat i ». La scienza come fat to gnostico e, i n
quanto tale coinvolta nella sfera dell'ideologia, non è separabile dal la scienza
come forza produttiva, e i n quanto tale coinvolta nel sistema -di produzione.
In questo senso, l a « critica del la conoscenza come "autoriflessione de l l a
scienza" è momento cost i tut ivo del la coscienza d i classe dell ' intellighenzia
scientifica » (Krahl ) .
I l problema riguarda i l rappor to t r a conoscenza e, coscienza d i classe.
Associare, alla appropriazione di una disciplina, elementi di « ideologia prole-
taria » non risolve i l problema. La questione è di acquisire come oggetto della
propria conoscenza, coscienza e prassi sociale non solo la materia di studio e la
«dottrina proletaria», ma i l processo sociale attraverso cui quella materia si è
determinata e valorizzata e i l processo sociale di appropriazione e poi valoriz-
zazione d i quel la materia da parte del lo studente, al l ' interno del la polar i tà
tra capitale e lavoro. Questo processo sociale d i appropriazione del la cono-
scenza h a appunto n e l sistema d i ist ruzione u n a f o rma par t icolare e
determinata.
Chi, come l 'M.S. statale (gruppo Capanna), pone come secondario i l
problema del la selezione che s i realizza attraverso i l sistema d i istruzione,
non comprende come questo riproduca materialmente e non solo ideologica-
mente la stratificazione sociale. La riproduce nel doppio signifitato: d i rispec-
chiamento e legittimazione, e al tempo stesso di riproposizione materiale dei
rapporti economici e di potere t ra le classi. I l lavoro
collettivo
d i una aristo-
crazia studentesca è
pr ivato
rispetto al la massa.
La contraddizione t r a svi luppo del le forze produt t ive e sistema capita-
listico di produzione è una contraddizione
interna
alla società borghese come
lo è l'opposizione capitale-lavoro: e propr io i n ciò sta i l potenziale eversivo
di questa contraddizione. Non ci sono due fat t i puramente paralleli: le masse
popolari che premono per l o svi luppo del le forze produt t ive da un lato, e
dall'altro i l Capitale col maglio alzato pronto a distruggerle al pr imo accenno
di svi luppo delle medesime. Pensando i n quest i termini d i ideal ismo mani-
cheo, i l G.C. non riesce a vedere come i l sistema capi tal ista distrugge e
comprime le forze produttive
che esso stesso sovrapproduce
rispetto alle sue
capacità d i utilizzazione sociale.
La conclusione pol i t i ca che essi traggono da questa car icatura de l l a
dialettica è che, se i l capitale distrugge le forze produttive, i l compito è gl i ello
di svilupparle: essere di l igent i a scuola esaurendo i propr i compi t i alterna-
t ivi al l ivel lo ideologico (Uso Parziale Alternativo). Si t rat ta di economicismo
mascherato dall'idealismo: una forma d i sindacalismo del la cultura. Ne con-
130
















