
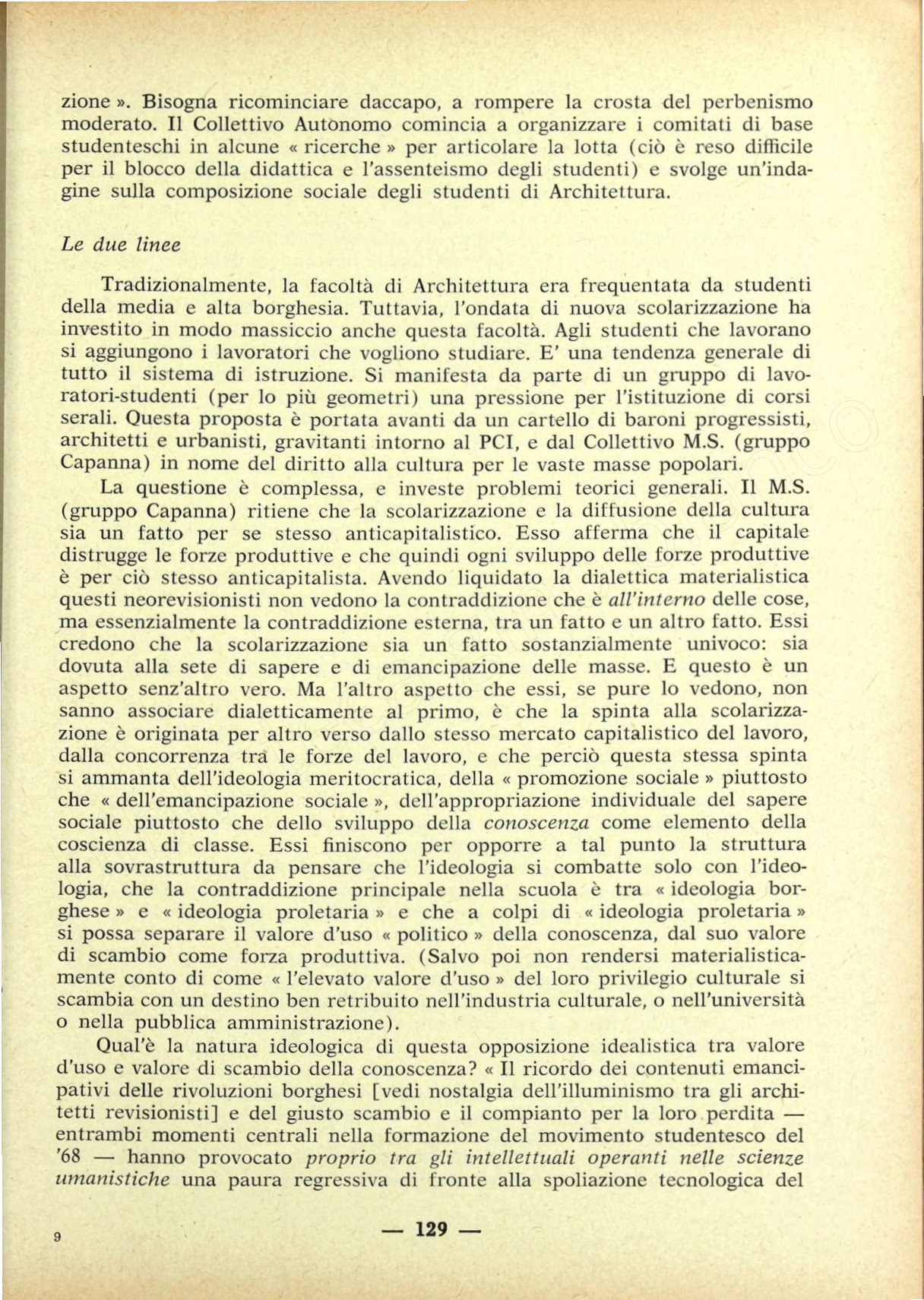
zione ». Bisogna ricominciare daccapo, a rompere l a crosta del perbenismo
moderato. I l Collettivo Autecomo comincia a organizzare i comitati di base
studenteschi in alcune « ricerche » per articolare la lotta (ciò è reso difficile
per i l blocco della didattica e l'assenteismo degli studenti) e svolge un'inda-
gine sulla composizione sociale degli studenti di Architettura.
Le due linee
Tradizionalmente, la facoltà di Architettura era frequentata da studenti
della media e alta borghesia. Tuttavia, l'ondata di nuova scolarizzazione ha
investito in modo massiccio anche questa facoltà. Agli studenti che lavorano
si aggiungono i lavoratori che vogliono studiare. E' una tendenza generale di
tutto i l sistema di istruzione. Si manifesta da parte di un gruppo di lavo-
ratori-studenti (per lo più geometri) una pressione per l'istituzione di corsi
serali. Questa proposta è portata avanti da un cartello di baroni progressisti,
architetti e urbanisti, gravitanti intorno al PCI, e dal Collettivo M.S. (gruppo
Capanna) in nome del diritto alla cultura per le vaste masse popolari.
La questione è complessa, e investe problemi teorici generali. I l M.S.
(gruppo Capanna) ritiene che la scolarizzazione e la diffusione della cultura
sia un fatto per se stesso anticapitalistico. Esso afferma che i l capitale
distrugge le forze produttive e che quindi ogni sviluppo delle forze produttive
è per ciò stesso anticapitalista. Avendo liquidato la dialettica materialistica
questi neorevisionisti non vedono la contraddizione che è
all'interno
delle cose,
ma essenzialmente la contraddizione esterna, tra un fatto e un altro fatto. Essi
credono che l a scolarizzazione sia un fat to sostanzialmente univoco: s i a
dovuta alla sete di sapere e di emancipazione delle masse. E questo è un
aspetto senz'altro vero. Ma l'altro aspetto che essi, se pure lo vedono, non
sanno associare dialetticamente a l primo, è che l a spinta al la scolarizza-
zione è originata per altro verso dallo stesso mercato capitalistico del lavoro,
dalla concorrenza trà le forze del lavoro, e che perciò questa stessa spinta
si ammanta dell'ideologia meritocratica, della « promozione sociale » piuttosto
che « dell'emancipazione sociale », dell'appropriazione individuale del sapere
sociale piuttosto che dello sviluppo della
conoscenza
come elemento della
coscienza d i classe. Essi finiscono per opporre a t a l punto l a struttura
alla sovrastruttura da pensare che l'ideologia si combatte solo con l'ideo-
logia, che l a contraddizione principale nella scuola è t r a « ideologia bor-
ghese » e « ideologia proletaria » e che a colpi d i « ideologia proletaria »
si possa separare i l valore d'uso « politico » della conoscenza, dal suo valore
di scambio come forza produttiva. (Salvo poi non rendersi materialistica-
mente conto di come « l'elevato valore d'uso » del loro privilegio culturale si
scambia con un destino ben retribuito nell'industria culturale, o nell'università
o nella pubblica amministrazione).
Qual'è la natura ideologica di questa opposizione idealistica tra valore
d'uso e valore di scambio della conoscenza? « I l ricordo dei contenuti emanci-
pativi delle rivoluzioni borghesi [vedi nostalgia dell'illuminismo tra gli archi-
tetti revisionisti] e del giusto scambio e i l compianto per la loro perdita
entrambi momenti centrali nella formazione del movimento studentesco del
'68 — hanno provocato proprio t ra gl i intellettuali operanti nelle scienze
umanistiche
una paura regressiva di fronte alla spoliazione tecnologica del
9
129
















