
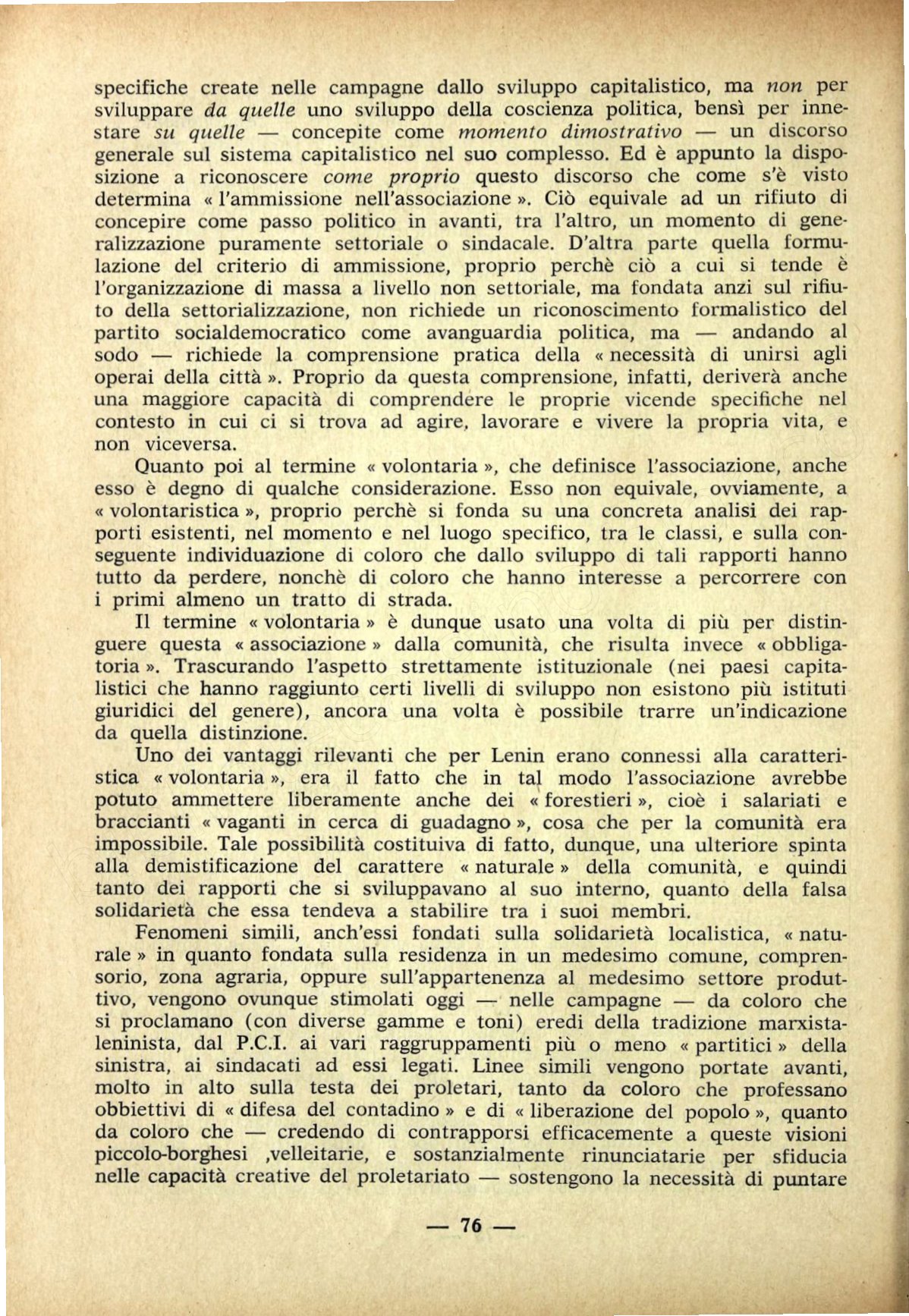
specifiche create nel le campagne dal lo svi luppo capitalistico, ma
non
pe r
sviluppare
da quelle
uno svi luppo del la coscienza pol i t ica, bensì pe r inne-
stare su quel le - concepite come momento dimostrat ivo - u n discorso
generale sul sistema capitalistico nel suo complesso. Ed è appunto la dispo-
sizione a riconoscere
come propr i o
questo discorso che come s ' è v i s t o
determina « l'ammissione nell'associazione ». Ciò equivale ad u n r i f i u t o d i
concepire come passo pol i t ico i n avanti, t r a l 'al t ro, un momento d i gene-
ralizzazione puramente settoriale o sindacale. D'al t ra par te quel la formu-
lazione de l cr i ter io d i ammissione, propr i o perchè c i ò a c u i s i tende è
l'organizzazione d i massa a l ivel lo non settoriale, ma fondata anzi sul r i f iu-
to del la settorializzazione, non richiede un riconoscimento formal ist ico del
partito socialdemocratico come avanguardia pol i t ica, m a — andando a l
sodo — richiede l a comprensione prat ica del la « necessità d i un i r s i ag l i
operai della ci t tà ». Proprio da questa comprensione, infat t i , deriverà anche
una maggiore capacità d i comprendere l e propr ie vicende specifiche ne l
contesto i n cu i c i s i t rova ad agire. lavorare e vivere l a propr ia v i ta, e
non viceversa.
Quanto poi a l termine « volontaria », che definisce l'associazione, anche
esso è degno d i qualche considerazione. Esso non equivale, ovviamente, a
«volontaristica », propr io perchè s i fonda su una concreta anal isi dei rap-
porti esistenti, nel momento e nel luogo specifico, t ra le classi, e sul la con-
seguente individuazione d i coloro che dal lo sviluppo d i ta l i rappor t i hanno
tutto da perdere, nonchè d i coloro che hanno interesse a percorrere con
i pr imi almeno un t rat to d i strada.
I l termine « volontaria» è dunque usato una vol ta d i p i ù pe r dist in-
guere questa « associazione » dal la comunità, che r i sul ta invece « obbliga-
toria». Trascurando l 'aspetto strettamente istituzionale ( ne i paesi capi ta-
listici che hanno raggiunto cert i l ivel l i d i sviluppo non esistono p i ù ist i tut i
giuridici de l genere), ancora una vo l ta è possibi le t r a r r e un' indicazione
da quel la distinzione.
Uno dei vantaggi r i levant i che per Lenin erano connessi al la caratteri-
stica « volontaria », e r a i l f a t t o che i n t a l modo l'associazione avrebbe
potuto ammettere l iberamente anche de i « forestieri », c ioè i salar iat i e
braccianti « vaganti i n cerca d i guadagno », cosa che pe r l a comuni tà era
impossibile. Tale possibilità costituiva d i fatto, dunque, una ul teriore spinta
alla demistificazione de l carat tere « naturale » de l l a comuni tà, e qu i nd i
tanto dei rappor t i che s i sviluppavano a l suo interno, quanto del la falsa
solidarietà che essa tendeva a stabi l ire t r a i suoi membr i .
Fenomeni simi l i , anch'essi fondat i sul la sol idarietà localistica, « natu-
rale » i n quanto fondata sulla residenza i n un medesimo comune, compren-
sorio, zona agraria, oppure sull'appartenenza a l medesimo settore produt -
tivo, vengono ovunque st imolat i oggi — nel le campagne — da coloro che
si proclamano (con diverse gamme e toni ) eredi del la tradizione marxista-
leninista, da l
P.C.I.
a i var i raggruppamenti p i ù •o meno « partitici » del la
sinistra, a i sindacati a d essi legati. Linee s imi l i vengono por tate avant i ,
molto i n a l t o su l l a testa de i proletar i , t an t o d a coloro che professano
obbiettivi d i « difesa del contadino)) e d i « liberazione del popolo », quanto
da coloro che — credendo d i contrapporsi efficacemente a queste visioni
piccolo-borghesi ,vel leitarie, e sostanzialmente r inunciatar ie p e r sf iduc ia
nelle capacità creative del proletariato s o s t e n g o n o la necessità d i puntare
76
















