
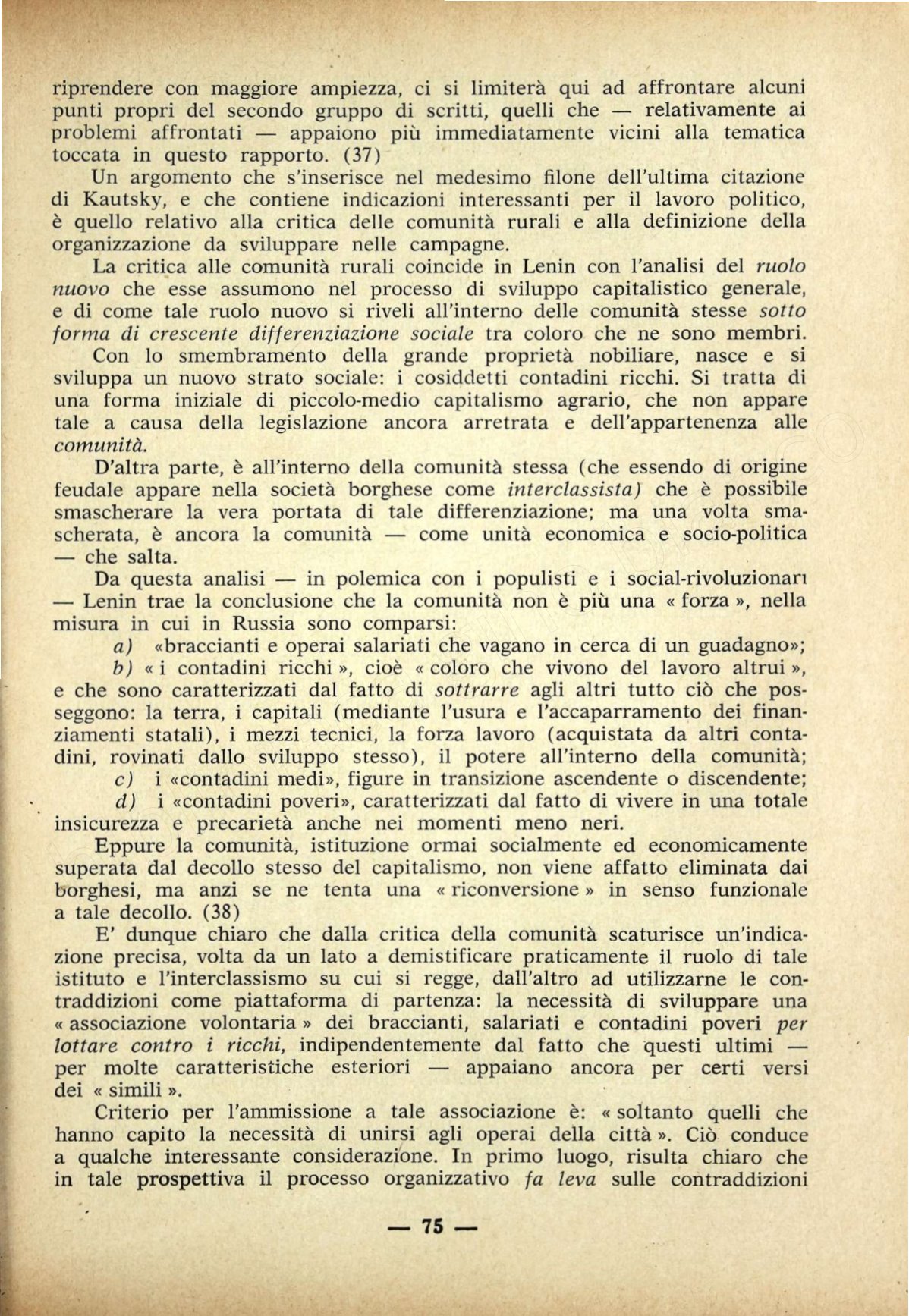
«.
riprendere con maggiore ampiezza, c i s i l imi terà qu i ad affrontare alcuni
punti propr i del secondo gruppo d i scr i t t i , quel l i che — relativamente a i
problemi af f rontat i — appaiono p i ù immediatamente v i c i n i a l l a temat ica
toccata i n questo rapporto. (37)
Un argomento che s'inserisce nel medesimo f i lone del l 'ul t ima citazione
di Kautsky, e che contiene indicazioni interessanti pe r i l lavoro pol i t ico,
è quel lo relat ivo al la cr i t ica del le comuni tà rural i e al la definizione del la
organizzazione da sviluppare nel le campagne.
La cri t ica al le comunità rural i coincide i n Lenin con l 'anal isi del
ruolo
nuovo
che esse assumono ne l processo d i svi luppo capital istico generale,
e d i come tale ruolo nuovo s i r ivel i al l ' interno delle comuni tà stesse
sot to
forma d i crescente differenziazione sociale t ra coloro che ne sono membri .
Con l o smembramento de l l a grande propr ietà nobi l iare, nasce e s i
sviluppa un nuovo strato sociale: i cosiddetti contadini r icchi . S i t rat ta d i
una forma iniziale d i piccolo-medio capital ismo agrario, che non appare
tale a causa del la legislazione ancora ar ret rata e dell'appartenenza a l l e
comunità.
D'altra parte, è al l ' interno della comunità stessa (che essendo d i origine
feudale appare nel la società borghese come
interclassista)
che è possibile
smascherare l a vera por tata d i t a l e differenziazione; m a una vo l ta sma-
scherata, è ancora l a comuni tà c o m e un i tà economica e socio-politica
che salta.
Da questa analisi i n polemica con i popul ist i e i social-rivoluzionari
Lenin trae la conclusione che l a comunità non è più una (( forza », nel la
misura i n cu i i n Russia sono comparsi:
a)
«bracciant i e operai salariati che vagano in cerca di un guadagno»;
b)
« i contadini r icchi », cioè « coloro che vivono del lavoro a l t ru i »,
e che sono caratterizzati dal fat to d i
sottrarre
agl i a l t r i tut to ciò che pos-
seggono: l a terra, i capital i (mediante l 'usura e l'accaparramento dei finan-
ziamenti statal i), i mezzi tecnici, l a forza lavoro (acquistata da a l t r i conta-
dini, rovinat i dal lo svi luppo stesso), i l potere al l ' interno del la comuni tà;
c)
i «contadini medi», figure i n transizione ascendente o discendente;
d)
i «contadini poveri», caratterizzati dal fat to di vivere in una totale
insicurezza e precarietà anche ne i moment i meno ner i .
Eppure l a comunità, istituzione ormai socialmente ed economicamente
superata dal decollo stesso del capitalismo, non viene affat to el iminata dai
«riconversione » i n senso funzionale
borghesi, ma anz i se ne tenta una
a tale decollo. (38)
E' dunque chiaro che dal la cr i t ica del la comuni tà scaturisce un'indica-
zione precisa, vol ta da un lato a demistificare praticamente i l ruolo d i tale
istituto e l'interclassismo su cu i s i regge, dal l 'al t ro ad uti l izzarne l e con-
traddizioni come piat taforma d i partenza: l a necessità d i svi luppare una
«associazione volontaria)> de i bracciant i , salar iat i e contadini pover i
pe r
lottare cont ro
i
r icchi ,
indipendentemente da l f a t t o che quest i u l t imi —
per mo l t e caratterist iche ester ior i — appaiano ancora p e r c e r t i ve r s i
dei « simi l i ».
Criterio pe r l'ammissione a ta l e associazione è : « soltanto que l l i che
hanno capi to l a necessità d i un i rs i agl i operai del la c i t t à ». Ci ò conduce
a qualche interessante considerazione. I n pr imo luogo, r isul ta chiaro che
in ta l e
prospettiva
i l processo organizzativo
f a leva
sul le contraddizioni
- 75 -
















