
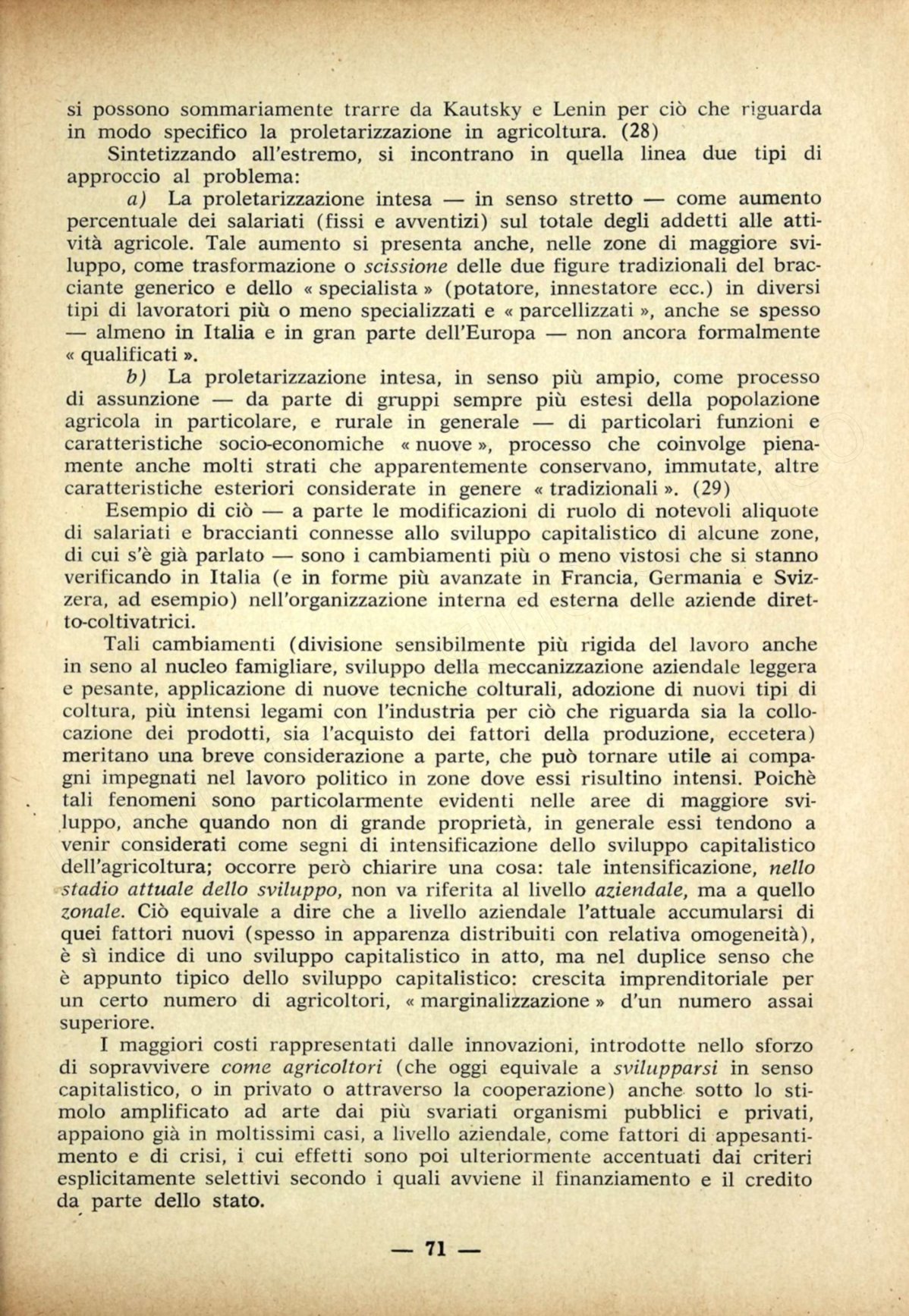
si possono sommariamente t rarre da Kautsky e Lenin per ciò che riguarda
in modo specifico l a proletarizzazione i n agricoltura. (28)
Sintetizzando al l 'estremo, s i incont rano i n que l l a l i nea due t i p i d i
approccio a l problema:
a)
L a proletarizzazione intesa — i n senso st ret to c o m e aumento
percentuale dei salariati ( f issi e avventizi) su l totale degl i addett i al le at t i -
vità agricole. Tale aumento s i presenta anche, nel le zone d i maggiore svi-
luppo, come trasformazione o
scissione
delle due figure tradizional i del brac-
ciante generico e del lo « specialista » (potatore, innestatore ecc.) i n diversi
tipi di lavoratori più o meno specializzati e «parcellizzati », anche se spesso
almeno i n I tal ia e i n gran parte dell'Europa n o n ancora formalmente
«qualificati ».
b)
L a proletarizzazione intesa, i n senso p i ù ampio, come processo
di assunzione — da par te d i gruppi sempre p i ù estesi del la popolazione
agricola i n particolare, e rura l e i n generale — d i par t icolar i funzioni e
caratteristiche socio-economiche « nuove », processo che coinvolge piena-
mente anche mo l t i st rat i che apparentemente conservano, immutate, al t re
caratteristiche esteriori considerate i n genere « tradizionali ». (29)
Esempio d i ciò — a parte le modificazioni d i ruolo d i notevoli aliquote
di salariati e braccianti connesse al lo svi luppo capitalistico d i alcune zone,
di cui s'è già parlato — sono i cambiamenti più o meno vistosi che si stanno
verificando i n I tal ia ( e i n forme p i ù avanzate i n Francia, Germania e
Sviz-
zera,
ad esempio) nell'organizzazione interna ed esterna delle aziende diret-
to-coltivatrici.
Tali cambiamenti (divisione sensibilmente p i ù r igida del lavoro anche
in seno al nucleo famigliare, sviluppo della meccanizzazione aziendale leggera
e pesante, applicazione d i nuove tecniche coltural i, adozione d i nuovi t i p i d i
coltura, più intensi legami con l ' industria per ciò che riguarda sia l a collo-
cazione de i prodot t i , s ia l 'acquisto de i f a t t or i del la produzione, eccetera)
meritano una breve considerazione a parte, che può tornare ut i le ai compa-
gni impegnati nel lavoro pol i t ico i n zone dove essi r isul t ino intensi. Poichè
tali fenomeni sono particolarmente evident i nel le aree d i maggiore sv i -
luppo, anche quando non d i grande proprietà, i n generale essi tendono a
venir considerati come segni d i intensificazione del lo svi luppo capitalistico
dell'agricoltura; occorre però chiar i re una cosa: tale intensificazione,
nel lo
•stadio attuale dello sviluppo, non va r i fer i ta al l ivel lo aziendale, ma a quello
zonale.
Ciò equivale a di re che a l ivel lo aziendale l 'attuale accumularsi d i
quei fat tor i nuovi (spesso i n apparenza distr ibui t i con relativa omogeneità),
è sì indice d i uno svi luppo capitalistico i n atto, ma nel dupl ice senso che
è appunto t i p i co del lo svi luppo capital istico: cresci ta imprendi toriale pe r
un cer to numero d i agr icol tor i , «marginalizzazione » d ' un numero assai
superiore.
I maggiori costi rappresentati dal le innovazioni, introdot te nel lo sforzo
di sopravvivere
come agricol tori
(che oggi equivale a
svi lupparsi
i n senso
capitalistico, o i n pr ivato o attraverso l a cooperazione) anche sot to l o st i -
molo ampl i f icato a d a r t e d a i p i ù svar iat i organismi pubb l i c i e pr i vat i ,
appaiono già in moltissimi casi, a l ivel lo aziendale, come fat tor i d i appesanti-
mento e d i cr isi , i cu i effet t i sono po i ulteriormente accentuati dai cr i ter i
esplicitamente selettivi secondo i qual i avviene i l finanziamento e i l credi to
da parte dello stato.
















