
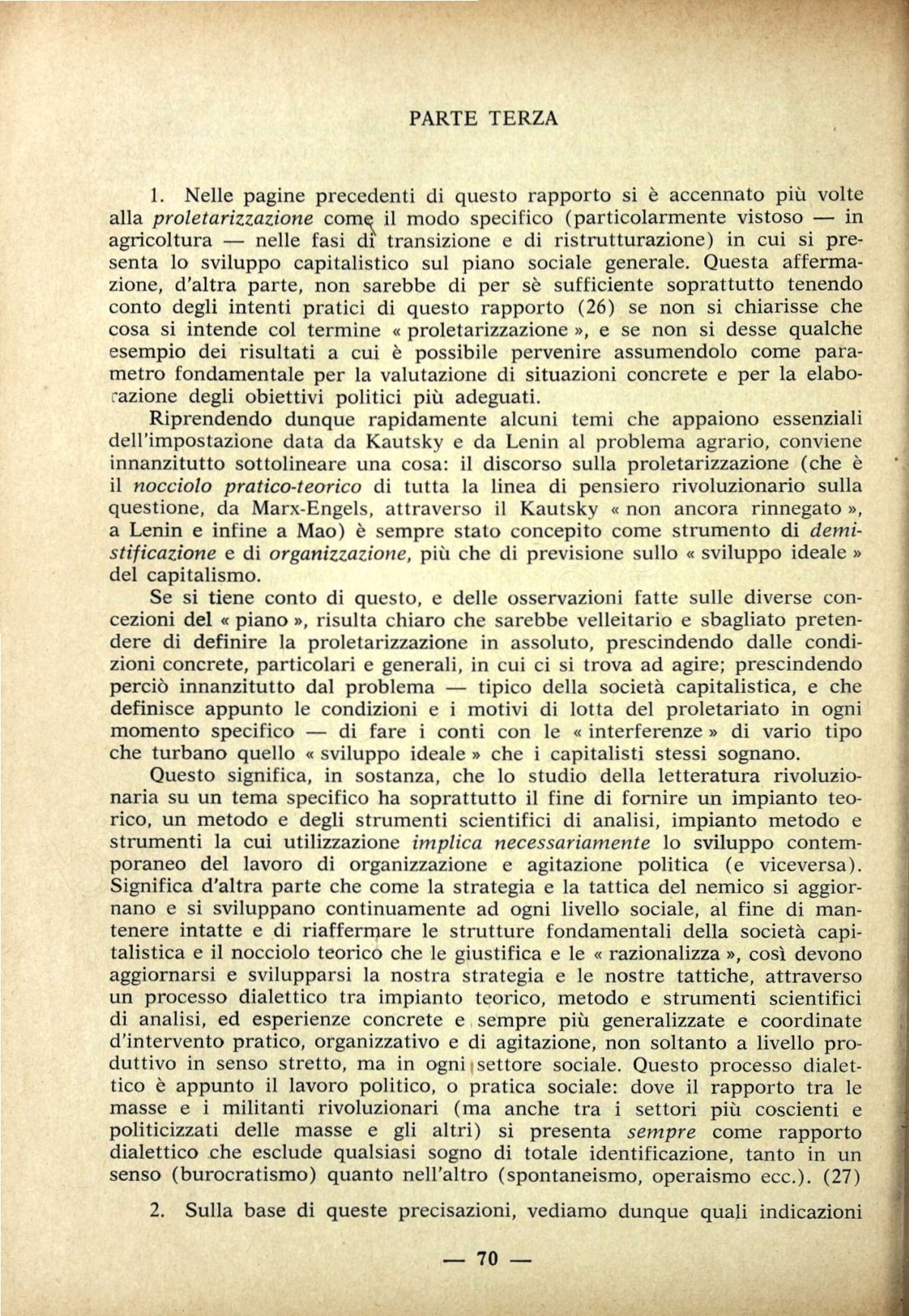
PARTE TERZA
1. Ne l l e pagine precedenti d i questo rapporto s i è accennato p i ù vol te
alla
proletarizzazione
com i l modo specifico (particolarmente vistoso — i n
agricoltura — nelle fasi d i transizione e d i ristrutturazione) i n cu i s i pre-
senta l o svi luppo capital istico su l piano sociale generale. Questa afferma-
zione, d'al t ra parte, non sarebbe d i per sè sufficiente soprat tut to tenendo
conto degl i intent i prat ici d i questo rapporto (26) se non s i chiarisse che
cosa s i intende col termine « proletarizzazione », e se non s i desse qualche
esempio dei r isul tat i a cu i è possibile pervenire assumendolo come para-
metro fondamentale per la valutazione d i situazioni concrete e per la elabo-
razione degl i obiet t ivi pol i t ici p i ù adeguati.
Riprendendo dunque rapidamente alcuni t emi che appaiono essenziali
dell'impostazione data da Kautsky e da Lenin al problema agrario, conviene
innanzitutto sottolineare una cosa: i l discorso sulla proletarizzazione (che è
il
nocciolo prat ico-teorico
d i tut ta l a l inea d i pensiero rivoluzionario sul la
questione, da Marx-Engels, attraverso i l Kautsky « non ancora rinnegato »,
a Lenin e inf ine a Mao) è sempre stato concepito come strumento d i
demi-
stificazione
e di
organizzazione,
più che di previsione sullo « sviluppo ideale))
del capitalismo.
Se si tiene conto di questo, e delle osservazioni fat te sul le diverse con-
cezioni del « piano », risulta chiaro che sarebbe velleitario e sbagliato preten-
dere d i def inire l a proletarizzazione i n assoluto, prescindendo dal le condi-
zioni concrete, particolari e generali, in cui ci si trova ad agire; prescindendo
perciò innanzitutto dal problema — t ipico del la società capitalistica, e che
definisce appunto le condizioni e i mot ivi d i lot ta del proletariato i n ogni
momento specifico — d i fare i cont i con l e « interferenze » d i var io t i po
che turbano quello « sviluppo ideale » che i capital isti stessi sognano.
Questo significa, i n sostanza, che l o studio del la letteratura rivoluzio-
naria su un tema specifico ha soprattutto i l f ine d i forni re un impianto teo-
rico, un metodo e degl i strument i scientifici d i analisi, impianto metodo e
strumenti l a cu i utilizzazione
impl ica necessariamente
l o svi luppo contem-
poraneo de l lavoro d i organizzazione e agitazione pol i t ica ( e viceversa).
Significa d'altra parte che come la strategia e la tattica del nemico si aggior-
nano e si sviluppano continuamente ad ogni l ivel lo sociale, a l f ine d i man-
tenere intatte e d i riaffermare le strut ture fondamentali del la società capi-
talistica e i l nocciolo teorico che le giustifica e le « razionalizza », così devono
aggiornarsi e svilupparsi l a nostra strategia e l e nostre tattiche, attraverso
un processo dialettico t r a impianto teorico, metodo e strument i scient i f ici
di analisi, ed esperienze concrete e sempre p i ù generalizzate e coordinate
d'intervento pratico, organizzativo e di agitazione, non soltanto a l ivel lo pro-
duttivo i n senso stretto, ma i n ogni !settore sociale. Questo processo dialet-
tico è appunto i l lavoro pol itico, o prat ica sociale: dove i l rappor to t r a l e
masse e i mi l i tant i rivoluzionari (ma anche t r a i set tor i p i ù coscienti e
politicizzati del le masse e g l i a l t r i ) s i presenta
sempre
come rappor to
dialettico che esclude qualsiasi sogno d i totale identificazione, tanto i n un
senso (burocratismo) quanto nel l 'altro (spontaneismo, operaismo ecc.). (27)
2. Su l l a base d i queste precisazioni, vediamo dunque qual i indicazioni
— 70 —
















