
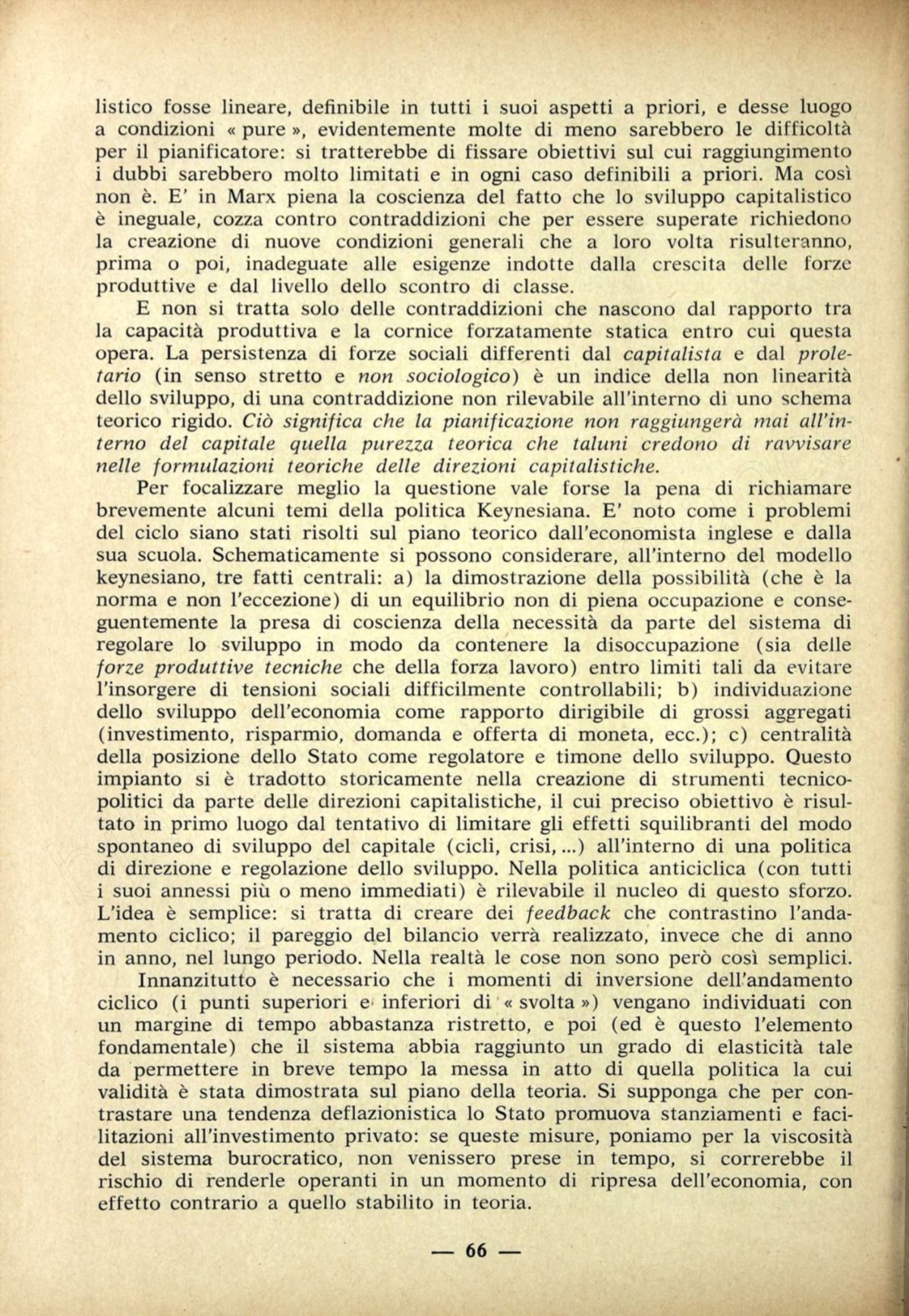
listico fosse lineare, definibile in tutti i suoi aspetti a priori, e desse luogo
a condizioni « pure », evidentemente molte di meno sarebbero le difficoltà
per il pianificatore: si tratterebbe di fissare obiettivi sul cui raggiungimento
i dubbi sarebbero molto limitati e in ogni caso definibili a priori. Ma così
non è. E' in Marx piena la coscienza del fatto che lo sviluppo capitalistico
è ineguale, cozza contro contraddizioni che per essere superate richiedono
la creazione d i nuove condizioni generali che a loro volta risulteranno,
prima o poi , inadeguate al le esigenze indotte dal la crescita del le forze
produttive e dal livello dello scontro di classe.
E non si tratta solo delle contraddizioni che nascono dal rapporto t ra
la capacità produttiva e l a cornice forzatamente statica entro cui questa
opera. La persistenza di forze sociali differenti dal
capitalista
e dal
prole-
tario
( i n senso stretto e
non sociologico)
è un indice della non linearità
dello sviluppo, di una contraddizione non rilevabile all'interno di uno schema
teorico rigido. Ciò significa che la pianificazione non raggiungerà mai all'in-
terno del capitale quella purezza teorica che taluni credono d i ravvisare
nelle formulazioni teoriche delle direzioni capitalistiche.
Per focalizzare meglio l a questione vale forse l a pena d i richiamare
brevemente alcuni temi della politica Keynesiana. E' noto come i problemi
del ciclo siano stati risolti sul piano teorico dall'economista inglese e dalla
sua scuola. Schematicamente si possono considerare, all'interno del modello
keynesiano, tre fatti centrali: a ) l a dimostrazione della possibilità (che è la
norma e non l'eccezione) di un equilibrio non di piena occupazione e conse-
guentemente l a presa di coscienza della necessità da parte del sistema di
regolare l o sviluppo i n modo da contenere l a disoccupazione (s i a delle
forze produttive tecniche
che della forza lavoro) entro limiti tali da evitare
l'insorgere d i tensioni sociali difficilmente controllabili; b ) individuazione
dello sviluppo dell'economia come rapporto dirigibile d i grossi aggregati
(investimento, risparmio, domanda e offerta di moneta, ecc.); c ) centralità
della posizione dello Stato come regolatore e timone dello sviluppo. Questo
impianto si è tradotto storicamente nella creazione d i strumenti tecnico-
politici da parte delle direzioni capitalistiche, i l cui preciso obiettivo è risul-
tato in primo luogo dal tentativo di limitare gli effetti squilibranti del modo
spontaneo di sviluppo del capitale (cicli, crisi, ...) all'interno di una politica
di direzione e regolazione dello sviluppo. Nella politica anticiclica (con tutti
i suoi annessi più o meno immediati) è rilevabile i l nucleo di questo sforzo.
L'idea è semplice: si tratta di creare dei
feedback
che contrastino l'anda-
mento ciclico; i l pareggio del bilancio verrà realizzato, invece che di anno
in anno, nel lungo periodo. Nella realtà le cose non sono però così semplici.
Innanzitutto è necessario che i momenti d i inversione delrandamento
ciclico ( i punti superiori es inferiori d i ' « svolta ») vengano individuati con
un margine d i tempo abbastanza ristretto, e poi (ed è questo l'elemento
fondamentale) che i l sistema abbia raggiunto un grado d i elasticità tale
da 'permettere i n breve tempo l a messa i n atto d i quella politica l a cui
validità è stata dimostrata sul piano della teoria. Si supponga che per con-
trastare una tendenza deflazionistica lo Stato promuova stanziamenti e faci-
litazioni all'investimento privato: se queste misure, poniamo per la viscosità
del sistema burocratico, non venissero prese i n tempo, s i correrebbe i l
rischio d i renderle operanti i n un momento di ripresa dell'economia, con
effetto contrario a quello stabilito in teoria.
66
















