
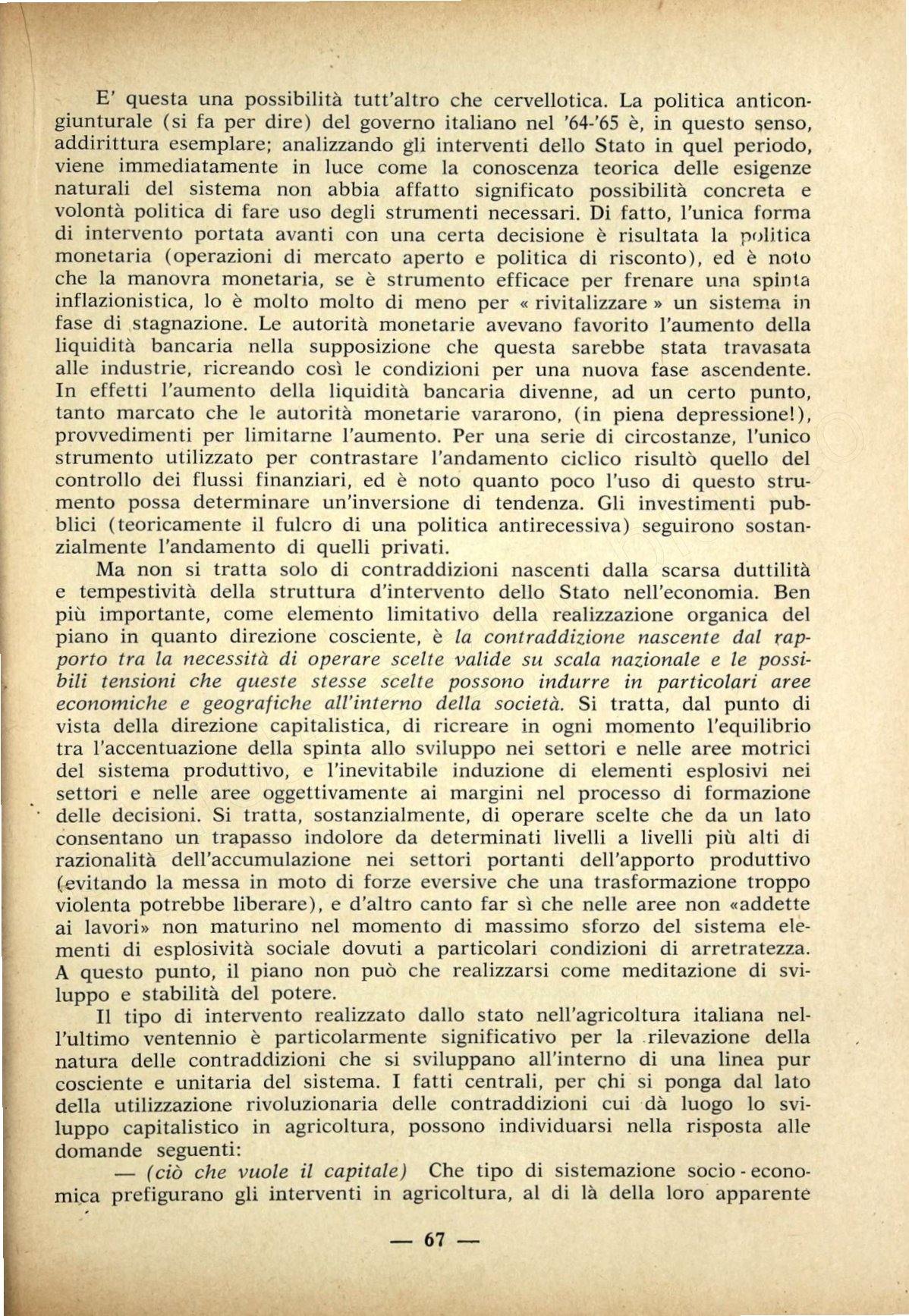
E' questa una possibilità tutt'altro che cervellotica. La politica anticon-
giunturale (si fa per dire) del governo italiano nel '64-'65 è, in questo senso,
addirittura esemplare; analizzando gli interventi dello Stato in quel periodo,
viene immediatamente i n luce come l a conoscenza teorica delle esigenze
naturali del sistema non abbia affatto significato possibilità concreta e
volontà politica di fare uso degli strumenti necessari. Di fatto, l'unica forma
di intervento portata avanti con una certa decisione è risultata la politica
monetaria (operazioni di mercato aperto e politica di risconto), ed è noto
che la manovra monetaria, se è strumento efficace per frenare una spinta
inflazionistica, lo è molto molto di meno per « rivitalizzare » un sistema in
fase di stagnazione. Le autorità monetarie avevano favorito l'aumento della
liquidità bancaria nella supposizione che questa sarebbe stata travasata
alle industrie, ricreando così le condizioni per una nuova fase ascendente.
In effetti l'aumento della liquidità bancaria divenne, ad un certo punto,
tanto marcato che le autorità monetarie vararono, ( i n piena depressione!),
provvedimenti per limitarne l'aumento. Per una serie di circostanze, l'unico
strumento utilizzato per contrastare l'andamento ciclico risultò quello del
controllo dei flussi finanziari, ed è noto quanto poco l'uso di questo stru-
mento possa determinare un'inversione d i tendenza. Gl i investimenti pub-
blici (teoricamente i l fulcro di una politica antirecessiva) seguirono sostan-
zialmente l'andamento di quelli privati.
Ma non si tratta solo d i contraddizioni nascenti dalla scarsa duttilità
e tempestività della struttura d'intervento dello Stato nell'economia. Ben
più importante, come elemento limitativo della realizzazione organica del
piano in quanto direzione cosciente, è
l a contraddizione nascente dal rap-
porto t ra la necessità d i operare scelte valide su scala nazionale e le possi-
bi l i tensioni che queste stesse scelte possono indur re i n par t icolar i aree
economiche e geografiche al l ' interno del la società.
S i tratta, dal punto d i
vista della direzione capitalistica, di ricreare i n ogni momento l'equilibrio
tra l'accentuazione della spinta allo sviluppo nei settori e nelle aree motrici
del sistema produttivo, e l'inevitabile induzione d i elementi esplosivi nei
settori e nelle aree oggettivamente a i margini nel processo d i formazione
delle decisioni. Si tratta, sostanzialmente, di operare scelte che da un lato
Consentano un trapasso indolore da determinati livelli a livelli più alti di
razionalità dell'accumulazione nei settori portanti dell'apporto produttivo
(evitando la messa in moto di forze eversive che una trasformazione troppo
violenta potrebbe liberare), e d'altro canto far sì che nelle aree non «addette
ai lavori» non maturino nel momento d i massimo sforzo del sistema ele-
menti d i esplosività sociale dovuti a particolari condizioni d i arretratezza.
A questo punto, i l piano non può che realizzarsi come meditazione di svi-
luppo e stabilità del potere.
Il tipo d i intervento realizzato dallo stato nell'agricoltura italiana nel-
l'ultimo ventennio è particolarmente significativo per l a .rilevazione della
natura delle contraddizioni che si sviluppano all'interno d i una linea pur
cosciente e unitaria del sistema. I fatti centrali, per chi si ponga dal lato
della utilizzazione rivoluzionaria delle contraddizioni cui dà luogo l o svi-
luppo capitalistico i n agricoltura, possono individuarsi nella risposta al le
domande seguenti:
(ciò che vuole i l capitale)
Ch e tipo di sistemazione socio - econo-
mica prefigurano gli interventi in agricoltura, al di là della loro apparente
•
— 67 —
















