
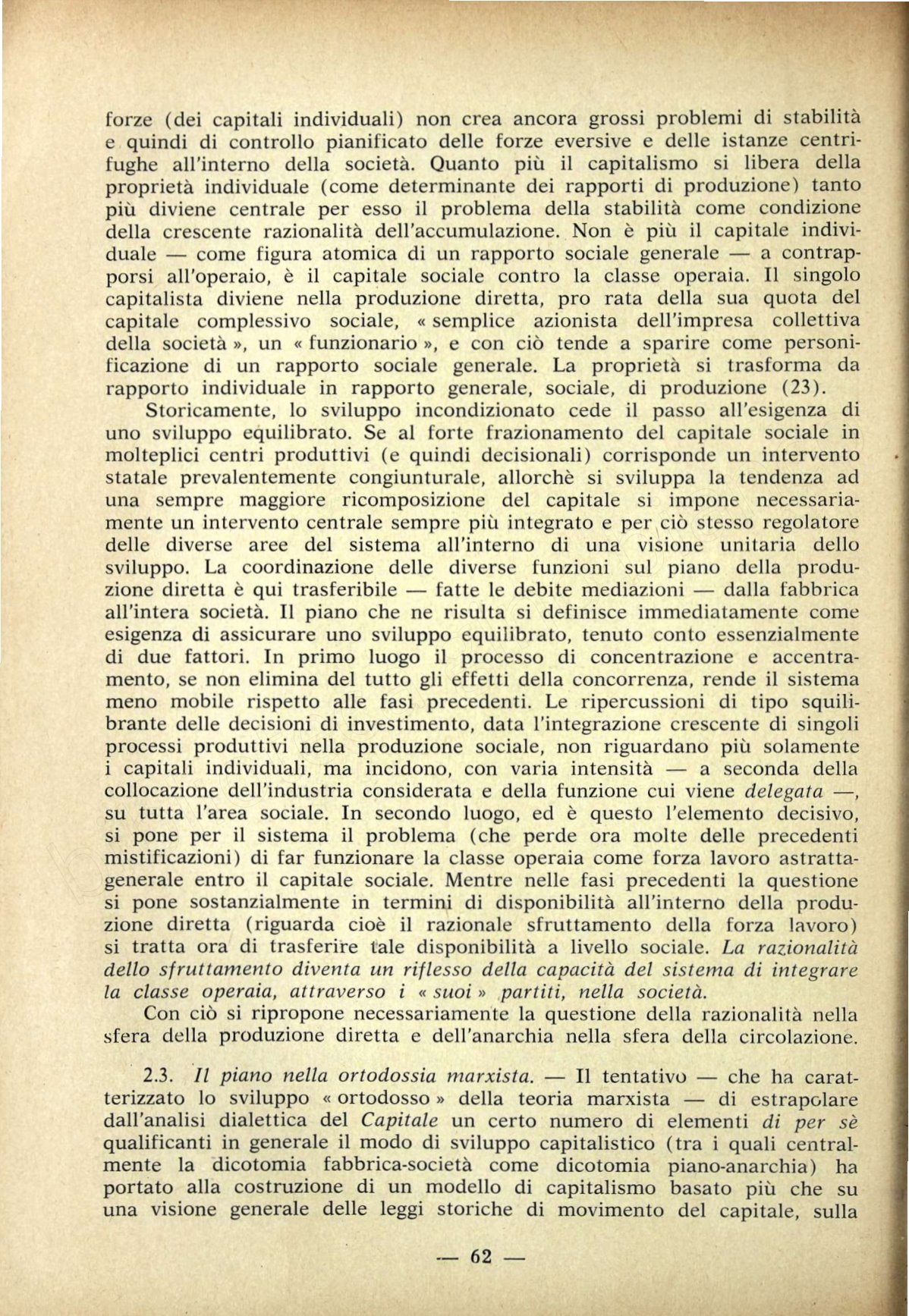
forze (dei capital i individual i) non crea ancora grossi problemi d i stabi l i tà
e quindi d i control lo pianificato del le forze eversive e del le istanze centri-
fughe al l ' interno del la società. Quanto p i ù i l capi tal ismo s i l i bera de l l a
proprietà individuale (come determinante dei rappor t i d i produzione) tanto
più diviene centrale pe r esso i l problema del la stabi l i tà come condizione
della crescente razionalità dell'accumulazione. Non è p i ù i l capitale indivi -
duale — come f igura atomica d i un rapporto sociale generale — a contrap-
porsi all'operaio, è i l capitale sociale cont ro l a classe operaia. I l singolo
capitalista diviene nel la produzione di ret ta, p r o r a t a del la sua quota de l
capitale complessivo sociale, « semplice azionista del l ' impresa col let t i va
della società », un « funzionario », e con ciò tende a sparire come personi-
ficazione d i u n rappor to sociale generale. L a propr ietà s i t rasforma d a
rapporto individuale i n rappor to generale, sociale, d i produzione (23) .
Storicamente, l o svi luppo incondizionato cede i l passo all'esigenza d i
uno svi luppo equilibrato. Se a l for te frazionamento de l capitale sociale i n
molteplici centri produt t ivi (e quindi decisionali) corrisponde un intervento
statale prevalentemente congiunturale, al lorchè s i svi luppa l a tendenza ad
una sempre maggiore ricomposizione d e l capi tale s i impone necessaria-
mente un intervento centrale sempre più integrato e per ciò stesso regolatore
delle diverse aree d e l sistema al l ' interno d i u n a visione un i t ar i a de l l o
sviluppo. L a coordinazione del le diverse funzioni s u l p i ano de l l a produ-
zione diretta è qui trasferibile — fatte le debite mediazioni — dalla fabbrica
all'intera società.
I l
piano che ne r isul ta si definisce immediatamente come
esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato, tenuto conto essenzialmente
di due fat tor i . I n p r imo luogo i l processo d i concentrazione e accentra-
mento, se non elimina del tut to gl i effett i della concorrenza, rende i l sistema
meno mobi le r ispet to al le fas i precedenti. Le ripercussioni d i t i po squi l i -
brante delle decisioni di investimento, data l'integrazione crescente d i singoli
processi produt t ivi nel la produzione sociale, non riguardano p i ù solamente
i capi tal i individual i, ma incidono, con var ia intensi tà — a seconda del la
collocazione dell'industria considerata e della funzione cui viene
delegata
,
su tut ta l 'area sociale. I n secondo luogo, ed è questo l 'elemento decisivo,
si pone per i l sistema i l problema (che perde o r a mol te del le precedenti
mistificazioni) d i far funzionare la classe operaia come forza lavoro astratta-
generale entro i l capitale sociale. Mentre nel le fasi precedenti l a questione
si pone sostanzialmente i n termini d i disponibi l i tà al l ' interno del la produ-
zione di ret ta (r iguarda cioè i l razionale sfrut tamento del la forza lavoro)
si t rat ta ora d i trasferi te tale disponibi l i tà a l ivel lo sociale.
La razional ità
dello sfruttamento diventa un riflesso del la capacità del sistema d i integrare
la classe operaia, attraverso i « suoi » par t i t i , nel la società.
Con ciò si ripropone necessariamente la questione della razionalità nella
sfera del la produzione di ret ta e dell'anarchia nel la sfera del la circolazione.
2.3. h piano nel la ortodossia marxista. — I l tentativo — che ha carat-
terizzato l o svi luppo « ortodosso » del la teor ia marxista — d i estrapolare
dall'analisi dialett ica del
Capitale
u n cer to numero d i elementi
d i pe r sè
qualificanti i n generale i l modo d i sviluppo capitalistico ( t r a i qual i central-
mente l a dicotomia fabbr i ca-società come dicotomia p i ano -anarchia) h a
portato a l l a costruzione d i un model lo d i capital ismo basato p i ù che s u
una visione generale del le leggi storiche d i movimento de l capitale, sul la
62
















