
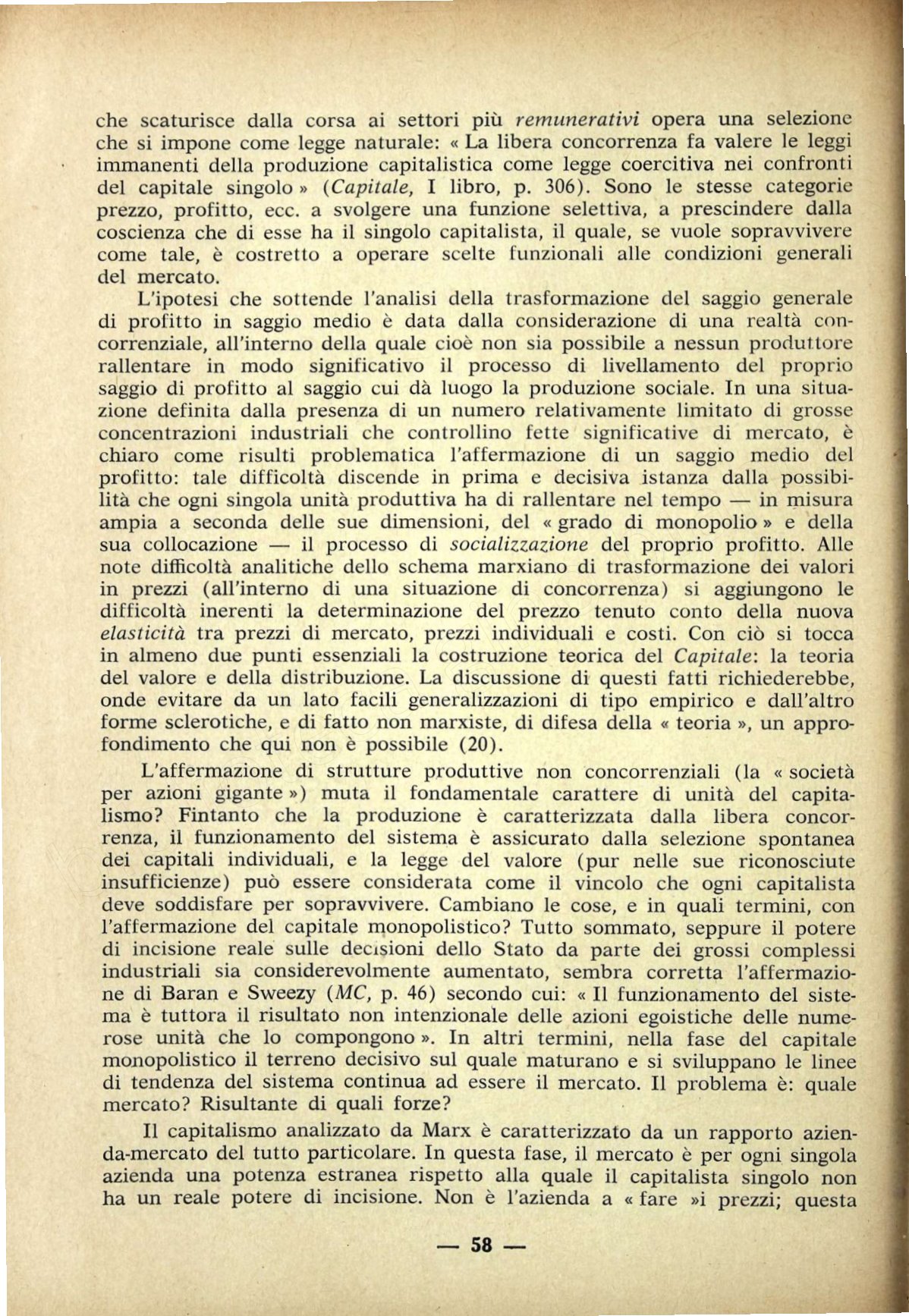
che scaturisce dal la corsa a i set tor i p i ù
remunerat ivi
opera una selezione
che si impone come legge naturale: «La libera concorrenza fa valere le leggi
immanenti della produzione capitalistica come legge coercitiva nei confront i
del capitale singolo))
(Capitale,
I l i bro, p . 306). Sono l e stesse categorie
prezzo, prof i t to, ecc. a svolgere una funzione selettiva, a prescindere dal la
coscienza che di esse ha i l singolo capitalista, i l quale, se vuole sopravvivere
come tale, è costretto a operare scelte funzional i al le condizioni general i
del mercato.
L'ipotesi che sottende l 'anal isi del la trasformazione del saggio generale
di prof i t to i n saggio medio è data dal la considerazione d i una real tà con-
correnziale, all'interno della quale cioè non sia possibile a nessun produttore
rallentare i n modo signi f icat ivo i l processo d i l ivel lamento d e l p r op r i o
saggio di prof i t to a l saggio cui dà luogo la produzione sociale. I n una situa-
zione definita dal la presenza d i un numero relativamente l imi tato d i grosse
concentrazioni indust r ial i che control l ino fet te significative d i mercato, è
chiaro come r i su l t i problematica l 'affermazione d i u n saggio med i o de l
profitto: t a l e di ff icol tà discende i n pr ima e decisiva istanza dal la possibi-
lità che ogni singola unità produttiva ha di rallentare nel tempo — in misura
ampia a seconda del le sue dimensioni, del «grado d i monopol io » e del la
sua collocazione — i l processo d i
socializzazione
de l propr io prof i t to. A l l e
note difficoltà analitiche dello schema marxiano d i trasformazione dei valor i
in prezzi (al l ' interno d i una situazione d i concorrenza) s i aggiungono l e
difficoltà inerent i l a determinazione de l prezzo tenuto conto del la nuova
elasticità
t r a prezzi d i mercato, prezzi individual i e costi. Con ciò s i tocca
in almeno due punt i essenziali la costruzione teorica del
Capitale:
l a teor ia
del valore e della distribuzione. La discussione d i questi fat t i richiederebbe,
onde evitare da un lato faci l i generalizzazioni d i t i po empi r ico e dal l 'al tro
forme sclerotiche, e di fatto non marxiste, di difesa della « teoria », un appro-
fondimento che qui non è possibile (20).
L'affermazione d i st rut ture produt t ive non concorrenziali ( l a « società
per azioni gigante ») mu t a i l fondamentale carattere d i un i t à de l capi ta-
lismo? Fintanto che l a produzione è caratterizzata da l l a l i be r a concor-
renza, i l funzionamento del sistema è assicurato dal la selezione spontanea
dei capi tal i individual i , e l a legge de l valore ( p u r nel le sue riconosciute
insufficienze) può essere considerata come i l vincolo che ogni capi tal ista
deve soddisfare per sopravvivere. Cambiano le cose, e i n qual i termini , con
l'affermazione del capitale monopolistico? Tut to sommato, seppure i l potere
di incisione reale sul le decisioni del lo Stato da parte de i grossi complessi
industriali s i a considerevolmente aumentato, sembra corret ta l 'affermazio-
ne di Baran e Sweezy
(MC,
p. 46) secondo cui: « I l funzionamento del siste-
ma è tut tora i l risultato non intenzionale delle azioni egoistiche delle nume-
rose un i tà che l o compongono ». I n a l t r i termini , nel la fase de l capi tale
monopolistico i l terreno decisivo sul quale maturano e si sviluppano le linee
di tendenza del sistema continua ad essere i l mercato. I l problema è: quale
mercato? Risultante d i qual i forze?
I l capitalismo analizzato da Marx è caratterizzato da un rapporto azien-
da-mercato del tut to particolare. I n questa fase, i l mercato è per ogni singola
azienda una potenza estranea rispetto al la quale i l capital ista singolo non
ha un reale potere d i incisione. Non è l'azienda a « fare » i prezzi; questa
— 58
















