
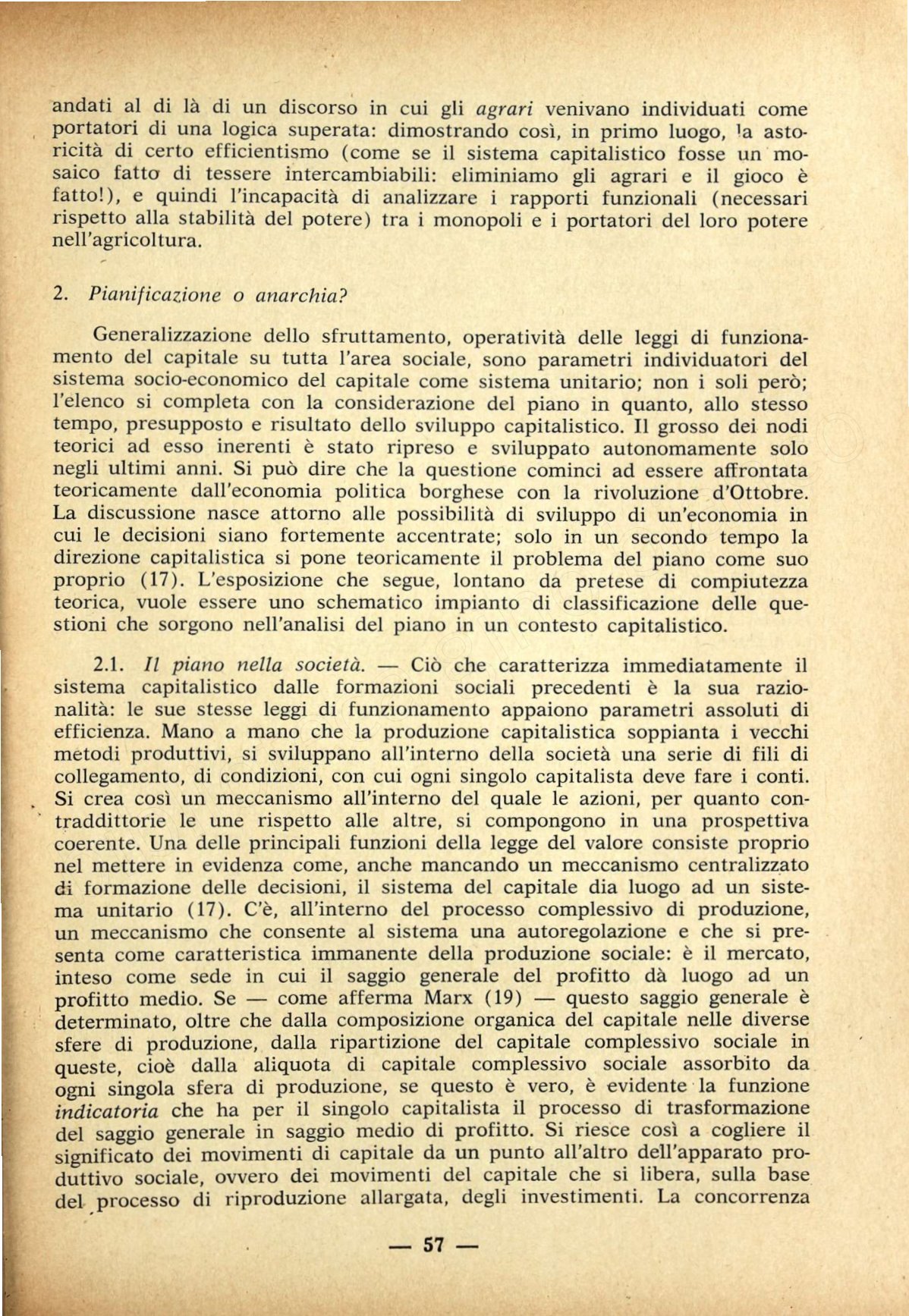
andati a l d i l à d i un discorso i n cu i g l i
agrar i
venivano individuat i come
portatori d i una logica superata: dimostrando così, i n pr imo luogo, la asto-
ricità d i certo efficientismo (come se i l sistema capitalistico fosse un mo-
saico f a t t a d i tessere intercambiabi l i : el iminiamo g l i agrar i e i l gioco è
fatto!), e qu i nd i l ' incapacità d i analizzare i rappor t i funzional i (necessari
rispetto alla stabilità del potere) t ra i monopoli e i portatori del loro potere
nell'agricoltura.
2. Piani f icazione o anarchia?
Generalizzazione del lo sfruttamento, operatività del le leggi d i funziona-
mento del capitale su tut ta l 'area sociale, sono parametri individuator i del
sistema socio-economico del capitale come sistema uni tario; non i sol i però;
l'elenco s i completa con l a considerazione del piano i n quanto, al lo stesso
tempo, presupposto e risultato dello sviluppo capitalistico. I l grosso dei nodi
teorici ad esso inerent i è stato r ipreso e svi luppato autonomamente solo
negli ul t imi anni. Si può di re che la questione cominci ad essere affrontata
teoricamente dall'economia pol i t ica borghese con l a rivoluzione d'Ottobre.
La discussione nasce at torno al le possibilità d i svi luppo d i un'economia i n
cui l e decisioni siano fortemente accentrate; solo i n un secondo tempo l a
direzione capitalistica si pone teoricamente i l problema del piano come suo
proprio (17) . L'esposizione che segue, lontano da pretese d i compiutezza
teorica, vuole essere uno schematico impianto d i classificazione del le que-
stioni che sorgono nell'analisi del piano i n un contesto capitalistico.
2.1.
I l piano nel la società.
— Ciò che caratterizza immediatamente i l
sistema capi tal ist ico da l l e formazioni social i precedent i è l a sua razio-
nalità: l e sue stesse leggi d i funzionamento appaiono parametri assoluti d i
efficienza. Mano a mano che l a produzione capitalistica soppianta i vecchi
metodi produtt ivi , si sviluppano al l ' interno del la società una serie d i f i l i d i
collegamento, di condizioni, con cui ogni singolo capitalista deve fare i conti.
Si crea così un meccanismo al l ' interno del quale le azioni, per quanto con-
traddittorie l e une r ispet to al le al t re, s i compongono i n una prospett iva
coerente. Una delle principal i funzioni della legge del valore consiste proprio
nel mettere i n evidenza come, anche mancando un meccanismo centralizzato
di formazione delle decisioni, i l sistema del capitale dia luogo ad un siste-
ma uni tar io (17) . C'è, al l ' interno de l processo complessivo d i produzione,
un meccanismo che consente a l sistema una autoregolazione e che s i pre-
senta come caratteristica immanente del la produzione sociale: è i l mercato,
inteso come sede i n cu i i l saggio generale de l pro f i t t o d à luogo a d u n
prof i tto medio. Se — come afferma Marx (19) — questo saggio generale è
determinato, ol tre che dalla composizione organica del capitale nelle diverse
sfere d i produzione, dal la ripart izione de l capitale complessivo sociale i n
queste, c i oè da l l a al iquota d i capi tale complessivo sociale assorbi to d a
ogni singola sfera d i produzione, se questo è vero, è evidente l a funzione
indicato ria
che ha pe r i l singolo capital ista i l processo d i trasformazione
del saggio generale i n saggio medio d i prof i t to. S i riesce così a cogliere i l
significato dei movimenti di capitale da un punto al l 'al tro dell'apparato pro-
duttivo sociale, ovvero dei movimenti del capitale che s i l ibera, sul la base
del eprocesso d i riproduzione allargata, degl i investimenti. L a concorrenza
57
















