
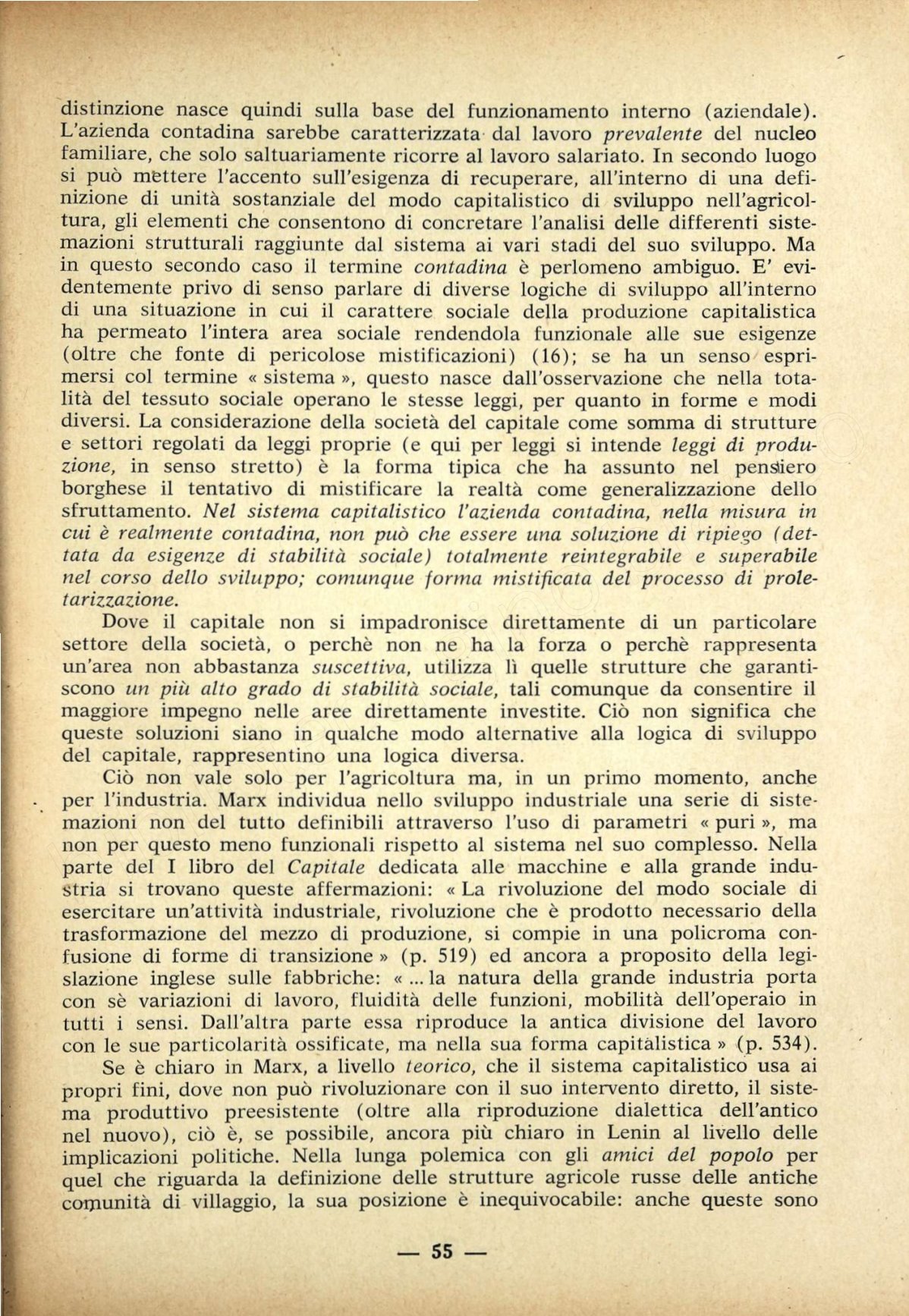
distinzione nasce quindi sulla base del funzionamento interno (aziendale).
L'azienda contadina sarebbe caratterizzata dal lavoro
prevalente
del nucleo
familiare, che solo saltuariamente ricorre al lavoro salariato. In secondo luogo
si può mettere l'accento sull'esigenza di recuperare, all'interno di una defi-
nizione d i unità sostanziale del modo capitalistico d i sviluppo nell'agricol-
tura, gli elementi che consentono di concretare l'analisi delle differenti siste-
mazioni strutturali raggiunte dal sistema ai vari stadi del suo sviluppo. Ma
in questo secondo caso i l termine
contadina
è perlomeno ambiguo. E ' evi-
dentemente privo di senso parlare di diverse logiche di sviluppo all'interno
di una situazione i n cui i l carattere sociale della produzione capitalistica
ha permeato l'intera area sociale rendendola funzionale al le sue esigenze
(oltre che fonte d i pericolose mistificazioni) (16) ; se ha un senso espri-
mersi col termine « sistema », questo nasce dall'osservazione che nella tota-
lità del tessuto sociale operano le stesse leggi, per quanto in forme e modi
diversi. La considerazione della società del capitale come somma di strutture
e settori regolati da leggi proprie (e qui per leggi si intende
leggi di produ-
zione,
i n senso stretto) è l a forma tipica che h a assunto ne l penstiero
borghese i l tentativo d i mistificare l a realtà come generalizzazione dello
sfruttamento. Nel sistema capitalistico l'azienda contadina, nella misura in
cui è realmente contadina, non può che essere una soluzione di ripiego (det-
tata da esigenze d i stabilità sociale) totalmente reintegrabile e superabile
nel corso dello sviluppo; comunque forma mistificata del processo di prole-
tarizzazione.
Dove i l capitale non s i impadronisce direttamente d i un particolare
settore della società, o perchè non ne ha l a forza o perchè rappresenta
un'area non abbastanza
suscettiva,
utilizza l ì quelle strutture che garanti-
scono un più alto grado di stabilità sociale, tali comunque da consentire i l
maggiore impegno nelle aree direttamente investite. Ciò non significa che
queste soluzioni siano i n qualche modo alternative alla logica d i sviluppo
del capitale, rappresentino una logica diversa.
Ciò non vale solo per l'agricoltura ma, i n un primo momento, anche
per l'industria. Marx individua nello sviluppo industriale una serie di siste-
mazioni non del tutto definibili attraverso l'uso di parametri « puri », ma
non per questo meno funzionali rispetto al sistema nel suo complesso. Nella
parte del I libro del
Capitale
dedicata alle macchine e al la grande indu-
stria si trovano queste affermazioni: « L a rivoluzione del modo sociale di
esercitare un'attività industriale, rivoluzione che è prodotto necessario della
trasformazione del mezzo di produzione, si compie in una policroma con-
fusione di forme di transizione » (p. 519) ed ancora a proposito della legi-
slazione inglese sulle fabbriche: « l a natura della grande industria porta
con se variazioni di lavoro, fluidità delle funzioni, mobilità dell'operaio in
tutti i sensi. Dall'altra parte essa riproduce l a antica divisione del lavoro
con le sue particolarità ossificate, ma nella sua forma capitàlistica » (p. 534).
Se è chiaro in Marx, a livello
teorico,
che i l sistema capitalistico usa ai
propri fini, dove non può rivoluzionare con i l suo intervento diretto, i l siste-
ma produttivo preesistente (ol t re al la riproduzione dialettica dell'antico
nel nuovo), ciò è, se possibile, ancora più chiaro in Lenin al livello delle
implicazioni politiche. Nella lunga polemica con gl i
amici del popolo
per
quel che riguarda la definizione delle strutture agricole russe delle antiche
comunità di villaggio, la sua posizione è inequivocabile: anche queste sono
— 55
t
















