
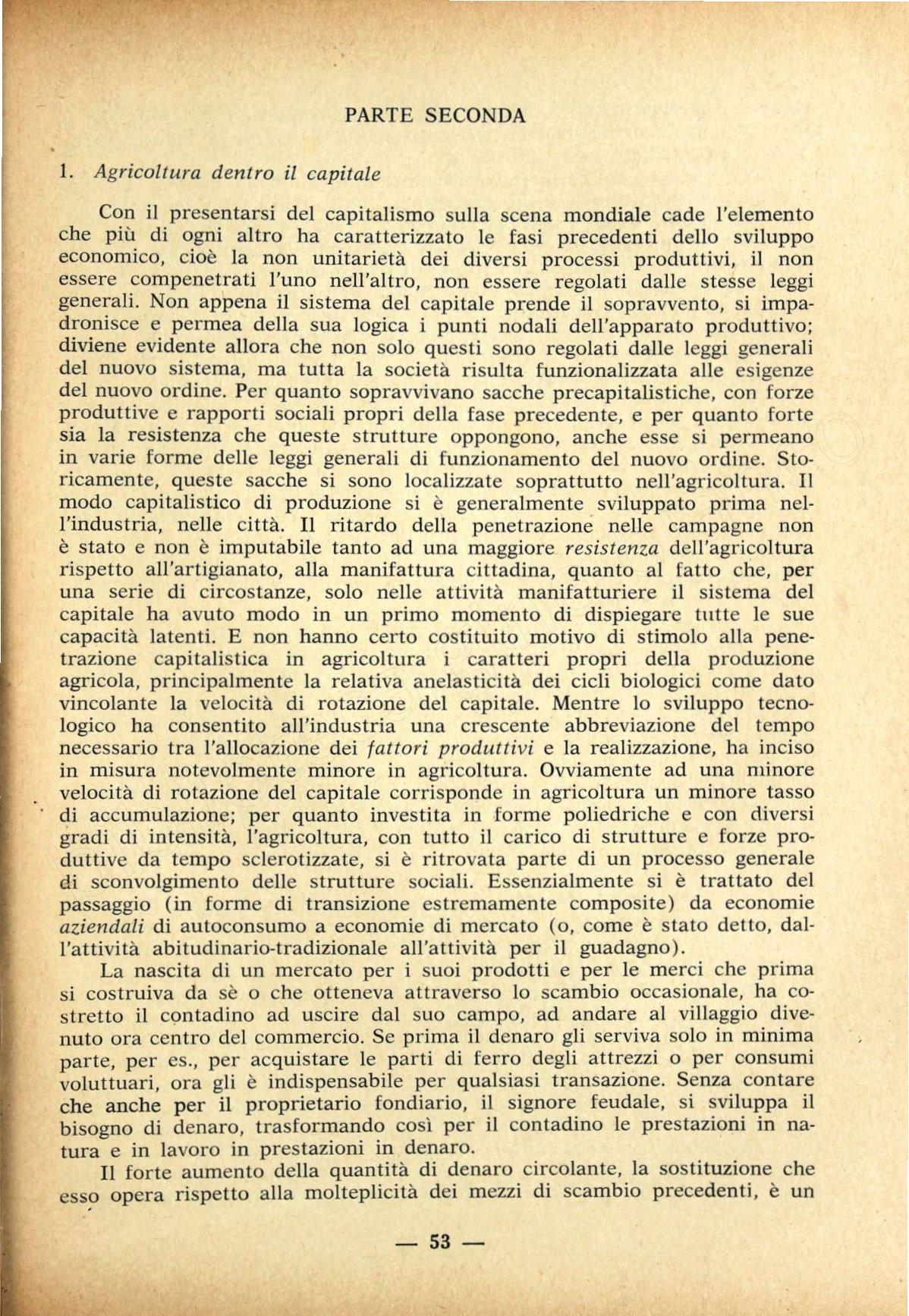
PARTE SECONDA
1. Agr i co l tura dentro i l capitale
Con i l presentarsi del capitalismo sulla scena mondiale cade l'elemento
che più d i ogni al tro ha caratterizzato l e fasi precedenti dello sviluppo
economico, cioè l a non unitarietà dei diversi processi produttivi, i l non
essere compenetrati l'uno nell'altro, non essere regolati dalle stesse leggi
generali. Non appena i l sistema del capitale prende i l sopravvento, si impa-
dronisce e permea della sua logica i punti nodali dell'apparato produttivo;
diviene evidente allora che non solo questi sono regolati dalle leggi generali
del nuovo sistema, ma tutta la società risulta funzionalizzata alle esigenze
del nuovo ordine. Per quanto sopravvivano sacche precapitalistiche, con forze
produttive e rapporti sociali propri della fase precedente, e per quanto forte
sia la resistenza che queste strutture oppongono, anche esse si permeano
in varie forme delle leggi generali di funzionamento del nuovo ordine. Sto-
ricamente, queste sacche si sono localizzate soprattutto nell'agricoltura. I l
modo capitalistico d i produzione si è generalmente sviluppato prima nel-
l'industria, nelle città. I l ritardo della penetrazioné nelle campagne non
è stato e non è imputabile tanto ad una maggiore
resistenza
dell'agricoltura
rispetto all'artigianato, alla manifattura cittadina, quanto al fatto che, per
una serie d i circostanze, solo nelle attività manifatturiere i l sistema del
capitale ha avuto modo i n un primo momento d i dispiegare tutte l e sue
capacità latenti. E non hanno certo costituito motivo di stimolo alla pene-
trazione capitalistica i n agricoltura i caratteri propr i del la produzione
agricola, principalmente la relativa anelasticità dei cicli biologici come dato
vincolante l a velocità d i rotazione del capitale. Mentre lo sviluppo tecno-
logico ha consentito all'industria una crescente abbreviazione del tempo
necessario tra l'allocazione dei
fattori produttivi
e la realizzazione, ha inciso
in misura notevolmente minore in agricoltura. Ovviamente ad una minore
velocità di rotazione del capitale corrisponde in agricoltura un minore tasso
di accumulazione; per quanto investita in forme poliedriche e con diversi
gradi di intensità, l'agricoltura, con tutto i l carico di strutture e forze pro-
duttive da tempo sclerotizzate, si è ritrovata parte di un processo generale
di sconvolgimento delle strutture sociali. Essenzialmente si è trattato del
passaggio ( i n forme d i transizione estremamente composite) da economie
aziendali
di autoconsumo a economie di mercato (o, come è stato detto, dal-
l'attività abitudinario-tradizionale all'attività per i l guadagno).
La nascita di un mercato per i suoi prodotti e per le merci che prima
si costruiva da sè o che otteneva attraverso lo scambio occasionale, ha co-
stretto i l cpntadino ad uscire dal suo campo, ad andare a l villaggio dive-
nuto ora centro del commercio. Se prima il denaro gli serviva solo in minima
parte, per es., per acquistare le parti di ferro degli attrezzi o per consumi
voluttuari, ora gli è indispensabile per qualsiasi transazione. Senza contare
che anche per i l proprietario fondiario, i l signore feudale, s i sviluppa i l
bisogno di denaro, trasformando così per i l contadino le prestazioni in na-
tura e in lavoro in prestazioni in denaro.
I l forte aumento della quantità di denaro circolante, la sostituzione che
esso opera rispetto alla molteplicità dei mezzi di scambio precedenti, è un
53
















