
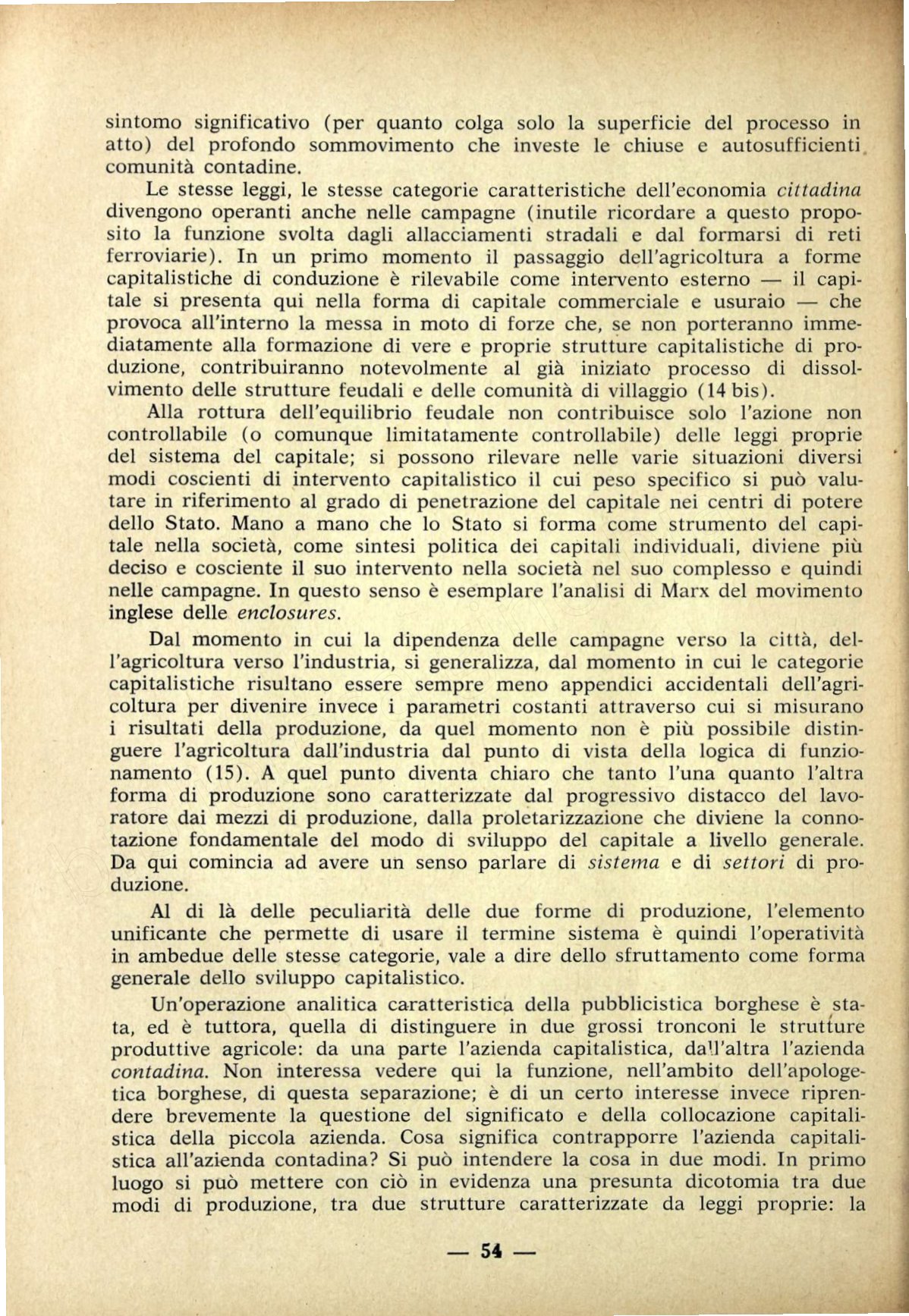
sintomo significativo ( pe r quanto colga solo l a superficie de l processo i n
atto) de l profondo sommovimento che investe l e chiuse e autosuff icient i
comunità contadine.
Le stesse leggi, le stesse categorie caratteristiche dell'economia
cittadina
divengono operanti anche nelle campagne ( inut i le ricordare a questo propo-
sito l a funzione svol ta dagl i allacciamenti stradal i e da l formarsi d i r e t i
ferroviarie). I n u n p r imo momento i l passaggio del l 'agricol tura a f o rme
capitalistiche d i conduzione è rilevabile come intervento esterno — i l capi-
tale s i presenta qu i nel la forma d i capitale commerciale e usuraio — che
provoca al l ' interno la messa i n moto di forze che, se non porteranno imme-
diatamente al la formazione d i vere e proprie strut ture capitalistiche d i pro-
duzione, contr ibui ranno notevolmente a l g i à iniziato processo d i dissol -
vimento delle strutture feudali e delle comunità di villaggio (
14
bis).
Alla rot tura del l 'equi l ibrio feudale non contribuisce solo l 'azione non
controllabile ( o comunque l imitatamente control labi le) del le leggi propr ie
del sistema del capitale; s i possono r i levare nel le var ie si tuazioni diversi
modi coscienti d i intervento capitalistico i l cu i peso specifico s i può valu-
tare i n riferimento al grado di penetrazione del capitale nei centri d i potere
dello Stato. Mano a mano che l o Stato si forma come strumento del capi-
tale nel la società, come sintesi pol i t ica dei capi tal i individual i , diviene p i ù
deciso e cosciente i l suo intervento nella società nel suo complesso e quindi
nelle campagne. I n questo senso è esemplare l'analisi di Marx del movimento
inglese delle
enclosures.
Dal momento i n cu i l a dipendenza del le campagne verso l a ci t tà, del-
l'agricoltura verso l ' industria, si generalizza, dal momento i n cui le categorie
capitalistiche r isul tano essere sempre meno appendici accidentali del l 'agri-
coltura per divenire invece i parametri costanti attraverso cui s i misurano
i r isul tat i del la produzione, da quel momento non è p i ù possibile dist in-
guere l 'agricol tura dal l ' industria da l punto d i vista del la logica d i funzio-
namento (15) . A quel punto diventa chiaro che tanto l 'una quanto l ' al t ra
forma d i produzione sono caratterizzate da l progressivo distacco de l lavo-
ratore dai mezzi d i produzione, dalla proletarizzazione che diviene la conno-
tazione fondamentale del modo d i svi luppo del capitale a l ivel lo generale.
Da qu i comincia ad avere un senso parlare d i
sistema
e d i
set tor i
d i pro-
duzione.
Al d i l à del le pecul iari tà del le due f o rme d i produzione, l 'elemento
unificante che permette d i usare i l termine sistema è qu i nd i l 'operat ivi tà
in ambedue delle stesse categorie, vale a dire dello sfruttamento come forma
generale dello sviluppo capitalistico.
Un'operazione analitica caratteristica del la pubblicistica borghese è sta-
ta, ed è tut tora, quel la d i distinguere i n due grossi t ronconi l e st rut ture
produttive agricole: da una parte l'azienda capitalistica, dal.l'altra l'azienda
contadina.
Non interessa vedere q u i l a funzione, nel l 'ambi to dell'apologe-
tica borghese, d i questa separazione; è d i un certo interesse invece ripren-
dere brevemente l a questione del significato e del la collocazione capi tal i-
stica del la piccola azienda. Cosa signi f ica contrapporre l 'azienda capi tal i-
stica all'azienda contadina? Si può intendere la cosa i n due modi. I n pr imo
luogo s i può mettere con c iò i n evidenza una presunta dicotomia t r a due
modi d i produzione, t r a due st rut ture caratterizzate da leggi propr ie: l a
54
















