
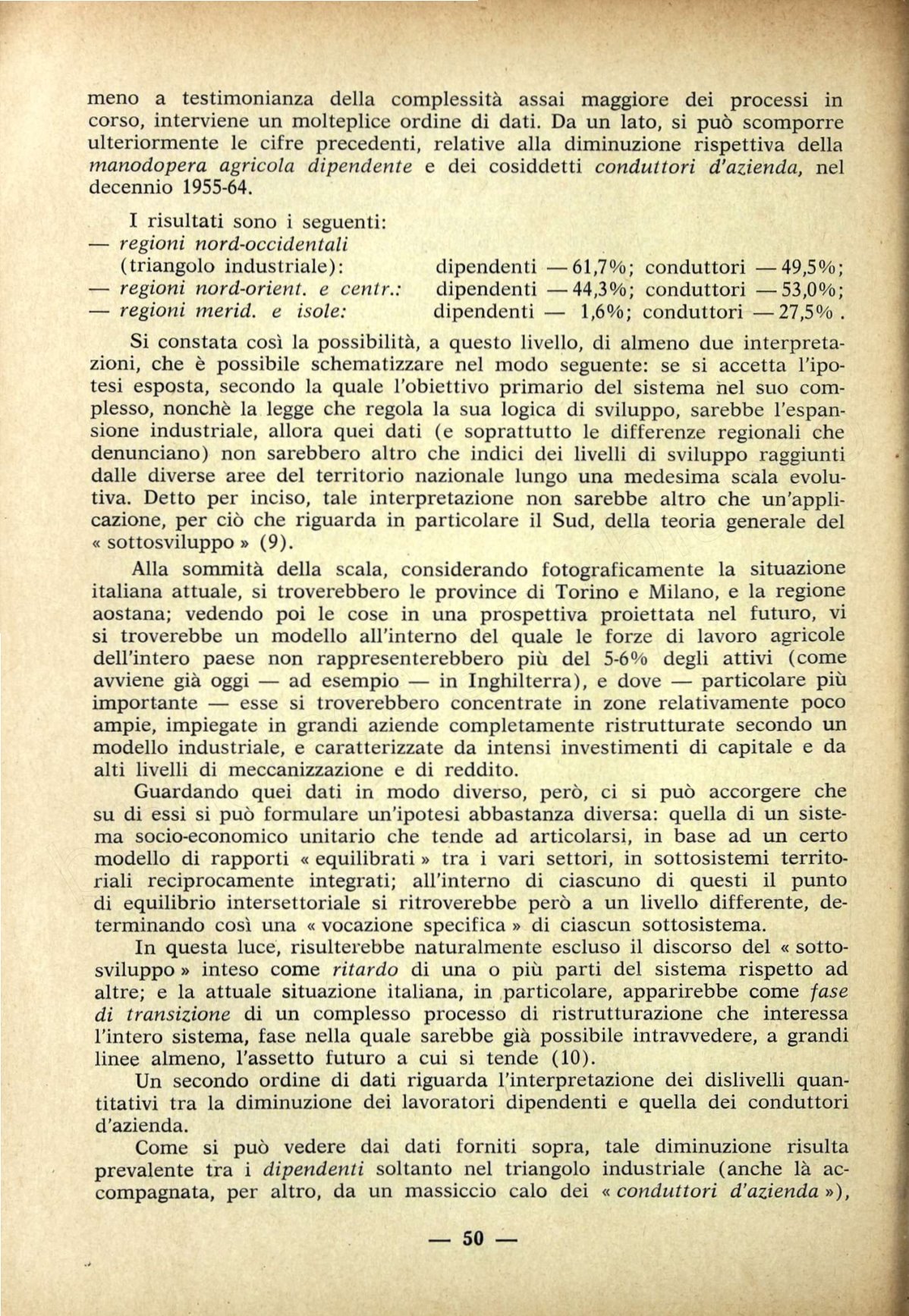
meno a testimonianza de l l a complessità assai maggiore d e i processi i n
corso, interviene un molteplice ordine d i dati. Da un lato, si può scomporre
ulteriormente l e c i f re precedenti, relat ive al la diminuzione r ispet t iva del la
manodopera agricola dipendente e de i cosiddetti condut tor i d'azienda, ne l
decennio 1955-64.
.
Si constata così la possibilità, a questo livello, di almeno due interpreta-
zioni, che è possibile schematizzare nel modo seguente: se s i accetta l ' ipo-
tesi esposta, secondo la quale l 'obiettivo pr imar io del sistema nel suo com-
plesso, nonchè la legge che regola la sua logica d i sviluppo, sarebbe l'espan-
sione industriale, al lora quei dat i ( e soprattutto l e differenze regional i che
denunciano) non sarebbero al t ro che indici dei l ivel l i d i svi luppo raggiunt i
dalle diverse aree del terr i tor io nazionale lungo una medesima scala evolu-
tiva. Det to per inciso, tale interpretazione non sarebbe a l t ro che un'appl i-
cazione, per ciò che riguarda i n particolare i l Sud, del la teoria generale del
«sottosviluppo » (9).
Alla sommi tà del la scala, considerando fotograficamente l a situazione
italiana attuale, si troverebbero le province d i Tor ino e Milano, e la regione
aostana; vedendo po i l e cose i n una prospettiva proiettata ne l futuro, v i
si troverebbe un model lo al l ' interno de l quale l e forze d i lavoro agricole
dell'intero paese non rappresenterebbero p i ù de l 5-6% degl i a t t i v i (come
avviene già oggi — ad esempio — i n Inghi l terra), e dove — particolare più
importante — esse s i troverebbero concentrate i n zone relativamente poco
ampie, impiegate i n grandi aziende completamente r istrut turate secondo un
modello industriale, e caratterizzate da intensi investimenti d i capitale e da
alti l ivel l i d i meccanizzazione e d i reddito.
Guardando quei da t i i n modo diverso, però, c i s i può accorgere che
su d i essi si può formulare un'ipotesi abbastanza diversa: quel la d i un siste-
ma socio-economico uni tar io che tende ad articolarsi, i n base ad un certo
modello d i rapport i « equilibrati » t r a i var i settori, i n sottosistemi terr i to-
rial i reciprocamente integrat i ; al l ' interno d i ciascuno d i quest i i l pun t o
di equi l ibr io intersettoriale s i ritroverebbe però a un l ivel lo differente, de-
terminando così una « vocazione specifica)) d i ciascun sottosistema.
In questa luce, risulterebbe naturalmente escluso i l discorso del « sotto-
sviluppo)> inteso come
r i tardo
d i una o p i ù par t i del sistema r ispet to ad
altre; e l a attuale situazione italiana, i n particolare, apparirebbe come
fase
di transizione
d i un complesso processo d i ristrutturazione che interessa
l'intero sistema, fase nella quale sarebbe già possibile intravvedere, a grandi
linee almeno, l'assetto futuro a cui s i tende (10).
Un secondo ordine d i dat i riguarda l'interpretazione dei disl ivel l i quan-
titativi t ra l a diminuzione dei lavoratori dipendenti e quel la dei condut tor i
d'azienda.
Come s i può vedere da i da t i f o r n i t i sopra, t a l e diminuzione r i su l t a
prevalente t r a i
dipendenti
soltanto nel triangolo industriale (anche l à ac-
compagnata, per al t ro, da un massiccio calo dei
«condut tor i d'azienda »),
I r isul tat i sono i seguenti:
regioni
dipendenti
61,7%;
49,5%
nord-occidentali
(triangolo industriale):
conduttori
;
— regioni nord-orient. c e n t r . :
dipendenti
44,3%;
53,0%;
e
conduttori
— regioni merid. i s o l e :
dipendenti
1,6%;
27,5%
e
conduttori
















